Giuliana Cordero Cabrini: «Pannella mi disse: ti candido solo se divorzi da tuo marito»
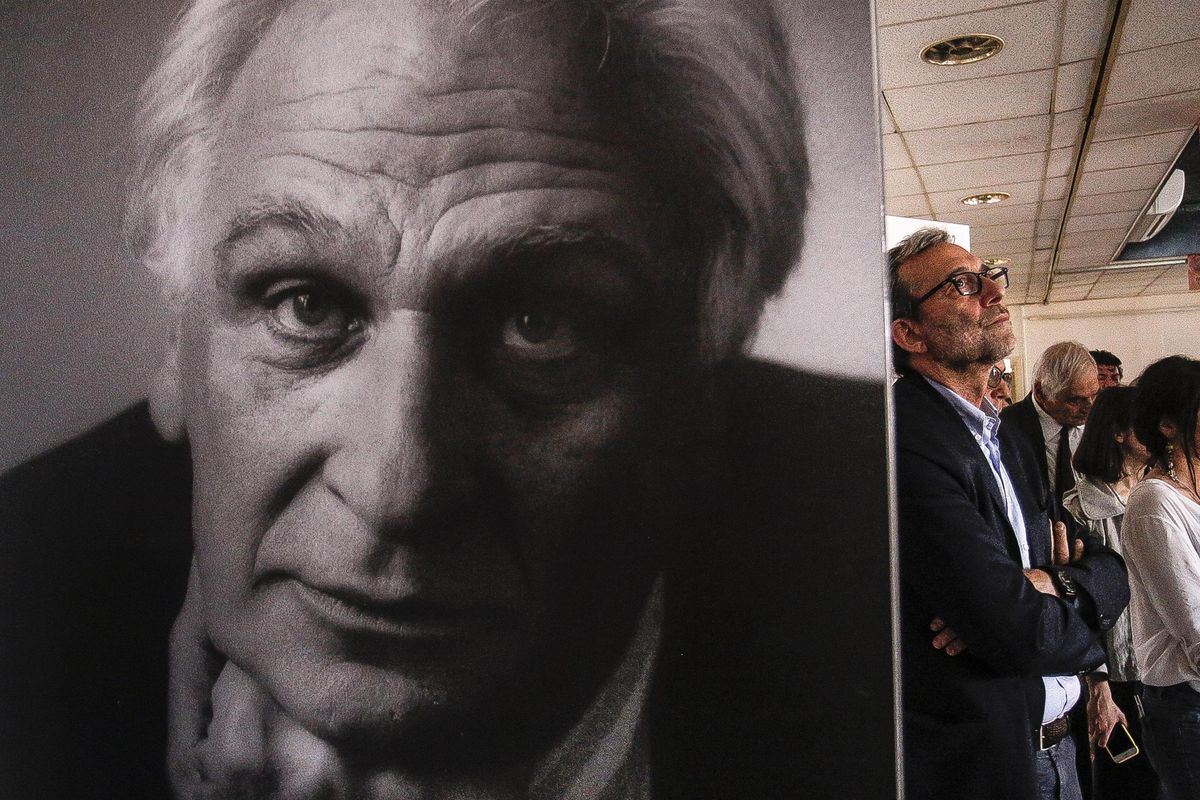
Giuliana, qual è il suo cognome? Cordero o Cabrini?
«Cordero. Il secondo appartiene al mio ex marito, l’insegnante e sindacalista Ferdinando Cabrini, ma durante l’intero periodo della mia azione come attivista nonviolenta ho utilizzato il cognome Cabrini ed è con questo che tuttora sono più nota».
Come arrivò alla militanza politica?
«Nel 1965 mi sono laureata e ho cominciato a insegnare Latino e Greco a Torino, la città in cui sono nata nel 1942. In seguito, dopo un periodo in maternità per la nascita, nel 1969, del mio unico figlio, Michele, sono stata chiamata al liceo “Carlo Alberto” di Novara, dove sono rimasta per un anno e mezzo. Subito, però, sono entrata in urto con il preside, che era un conservatore nel senso peggiore della parola mentre io ero piena di idee e di progetti per gli studenti. Con i miei alunni riuscii a stabilire un rapporto fecondo, basato sul dialogo, al punto di dare alle stampe, nel 1972, un libro dal titolo Alla mia prof con rabbia, in cui avevo raccolto parte della corrispondenza scambiata con i ragazzi della mia classe (che ovviamente comparivano in forma anonima)».
Libro che non passò inosservato.
«Dal momento che vi si toccava anche il tema della sessualità giovanile, destò un certo scandalo, non solo localmente, pure a livello nazionale. Io inoltre mi rifiutai di firmare il verbale degli scrutini di fine anno perché il preside voleva bocciare una ragazza e io ero contraria. Arrivammo ai ferri corti e così, l’anno scolastico successivo, lui mi sottopose a tre ispezioni ministeriali e, peggio ancora, mi fece incriminare per interessi privati in atti di ufficio (a causa dell’uscita del libro), per omissioni di atti d’ufficio (per non aver firmato il verbale) e per turpiloquio, in quanto gli studenti avevano usato nelle loro lettere un linguaggio informale, affine al parlato. Sono stata assolta in primo grado, mentre in appello venni prosciolta non con la formula piena ma per mancanza di prove certe. Ecco, l’idea di abbracciare la politica è nata in me dopo questi fatti».
Non ha mai abbandonato l’insegnamento, però.
«No, ho continuato a insegnare fino alla pensione, prima a Pinerolo e poi al liceo “Massimo d’Azeglio” di Torino. Tuttavia l’esperienza di Novara, assieme a ciò che accadde a Pordenone, presso il cui liceo classico ero stata trasferita, mi fece riflettere su una cosa: se a me, che avevo un padre magistrato e provenivo da una famiglia bene di Torino, la giustizia stava facendo vivere una situazione da incubo come quella, chissà cosa può passare chi finisce nelle sue maglie non avendo alle spalle nessun tipo di “protezione”. Perciò, con il mio ex marito Ferdinando Cabrini, che come ho già detto era un sindacalista, precisamente della Cisl, decisi di contattare il Partito radicale».
Cosa successe a Pordenone?
«Il preside non voleva farmi mettere piede nella scuola e allora io organizzai delle lezioni in strada. Il direttore de L’Espresso, Livio Zanetti, che già aveva seguito le mie vicissitudini, mandò un giornalista e un fotografo per documentare la mia protesta, tanto più che in quegli stessi giorni erano in corso degli scioperi da parte dei dipendenti dell’azienda Zanussi, e così la vicenda ebbe una grande eco in tutta Italia».
Torniamo al Partito radicale.
«Dapprima partecipai alle riunioni del Movimento Antimilitarista Italiano. Alle riunioni e pure alle manifestazioni, prendendomi la mia razione di manganellate. Quindi aderii al Partito radicale, di cui nel frattempo mio marito era divenuto il segretario regionale piemontese. In questo modo mi sono avvicinata alla causa omosessuale - specialmente grazie ad Angelo Pezzana, che era sia un militante radicale sia il promotore del “Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano”, meglio noto come Fuori! - e soprattutto fondai la “Lega nonviolenta per i diritti dei detenuti”. Cominciai così a recarmi regolarmente nelle case circondariali e a incontrare i carcerati, stabilendo con alcuni di loro dei bei rapporti umani. Per difenderne le ragioni mi sottoponevo anche a degli scioperi della fame».
Di che durata?
«Digiuni di tre o quattro giorni, ma l’acqua la bevevo. Però mi sono rovinata la salute. Verso i sessant’anni ho cominciato a soffrire di fibrillazioni cardiache e il medico mi ha detto che a causarle, probabilmente, sono stati proprio quei digiuni giovanili».
Questi incontri le hanno mai procurato dei problemi?
«Qualche volta è successo, ma più che di problemi parlerei di situazioni delicate. Ad Augusta un detenuto con cui mi scrivevo sequestrò un agente carcerario minacciandolo con un coltello. Io raggiunsi la Sicilia a bordo di un elicottero della polizia e lo convinsi a consegnarmi l’arma. Poco dopo fu sequestrato un altro agente a San Gimignano e in quel caso mi spaventai davvero, perché il detenuto non mi consentì di entrare nel locale in cui si trovava assieme al poliziotto e mi puntò contro una pistola».
Quando lasciò il Partito radicale?
«Se ricordo bene era il 1978. A parte che, essendo sempre stata fondamentalmente cattolica, mi ritrovavo poco nelle posizioni del partito sull’aborto, mio marito litigò aspramente con Pezzana e soprattutto con Marco Pannella, e questo creò le premesse per il mio abbandono. Pannella mi sottopose infatti a una sorta di ricatto: mi avrebbe fatto candidare alla Camera se avessi divorziato da Ferdinando. Io mi guardai bene dall’accettare».
Capitò soltanto a lei una cosa del genere?
«Lo escludo. Era il modus operandi di Pannella, che rendeva il Partito radicale qualcosa di non così diverso da una setta. Lui, il demiurgo, voleva entrare nelle vite dei militanti e decidere anche del loro privato sulla base delle sue personali simpatie o antipatie».
Nel libro L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini, firmato dalla giornalista Simona Zecchi, le si attribuisce un ruolo nell’avere messo in contatto Pasolini con il terrorista nero Giovanni Ventura, il quale, mentre era detenuto nel carcere di Bari, intrattenne con lo scrittore, a partire da marzo del 1975 e fino a ottobre dello stesso anno, un rapporto epistolare.
«È falso. Ventura poté iniziare a scrivere missive a Pasolini grazie all’intermediazione di un editore, Antonio Pellicani. Io Pasolini non l’ho mai conosciuto. Dal momento che lo stimavo, una volta gli mandai una lettera, ma non mi rispose e dunque con lui non ho mai avuto alcun rapporto».
Esiste una missiva, a lei inviata il 10 ottobre del 1975, in cui Pellicani le scrive: «Giovanni è stato ovviamente informato dello spirito e dei possibili sviluppi dell’iniziativa, ma ormai mi pare che il rapporto non abbia più bisogno di mediatori». Il riferimento è al rapporto con Pasolini?
«No, il riferimento è al Consiglio d’Europa, presso il quale io, come segretaria della “Lega nonviolenta per i diritti dei detenuti” e richiamandomi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, perorai, per mezzo di un ricorso, la causa di Ventura. Ma ormai, appunto, il rapporto fra Ventura e il Consiglio poteva prescindere da me».
Perché, secondo lei, Ventura volle contattare Pasolini e dibattere con lui degli stessi temi di cui l’intellettuale si occupava in quel periodo sul Corriere della Sera e altrove?
«Ventura cercava in ogni modo di far interessare al suo caso quante più personalità possibile, allo scopo di essere scarcerato. Mica provò a coinvolgere soltanto Pasolini: scrisse, sempre supportato da Pellicani, anche a diversi giornalisti e perfino a qualche politico. Ed è tramite Pellicani, del resto, che arrivò anche a me».
Da una comunicazione scritta di Ventura al Nucleo Antiterrorismo di Bari, che gliel’aveva richiesta per chiarimenti, si evince che lei, in data 2 novembre 1975, inviò al terrorista un telegramma in cui si accennava alla morte di Pasolini, avvenuta proprio in quel giorno. Nella comunicazione suddetta, Ventura scrive a un certo punto: «La coincidenza della straziante fine di Pasolini non poteva essere avvertita, né dalla cara amica che inviò il telegramma né da me, come “la morte di quel culattone là”, ma come una diretta lesione, una diminuzione personale».
«Mandai quel telegramma a Ventura perché il 2 novembre era il giorno del suo compleanno. Dopodiché, in ragione della concomitanza con l’assassinio di Pasolini, che mi aveva profondamente scosso, devo avere fatto cenno al delitto nel telegramma (che io sinceramente neppure ricordavo di avere inviato), tanto più che sapevo dei rapporti epistolari tra Pasolini e Ventura. Quanto alla frase oltraggiosa, è semplicemente assurdo pensare, come qualcuno ha fatto, che io, sostenitrice del Fuori! e da sempre refrattaria alle scurrilità, possa avere usato un’espressione del genere nei confronti del poeta ucciso. La spiegazione più probabile è che la frase fosse stata pronunciata da qualcuno del Nucleo Antiterrorismo durante un colloquio con Ventura e che lui, nel fornire i chiarimenti riguardo al telegramma, l’abbia ripresa proprio per contestarla, come effettivamente fa».
Oggi segue la politica?
«Sì, certo, ma credo che l’invadenza della magistratura, cominciata nel 1992 con Mani pulite e mai più interrottasi, abbia fatto sì che in Italia lo spirito autentico del fare politica si sia perso. In politica il confronto, anche aspro, deve essere dialettico, non giudiziario. Io non posso certo definirmi una “meloniana”, ma mi sembra che il recente caso legato all’espulsione da parte del governo del criminale libico Almasri rappresenti l’ultima conferma, in ordine di tempo, di quanto ho appena denunciato».






