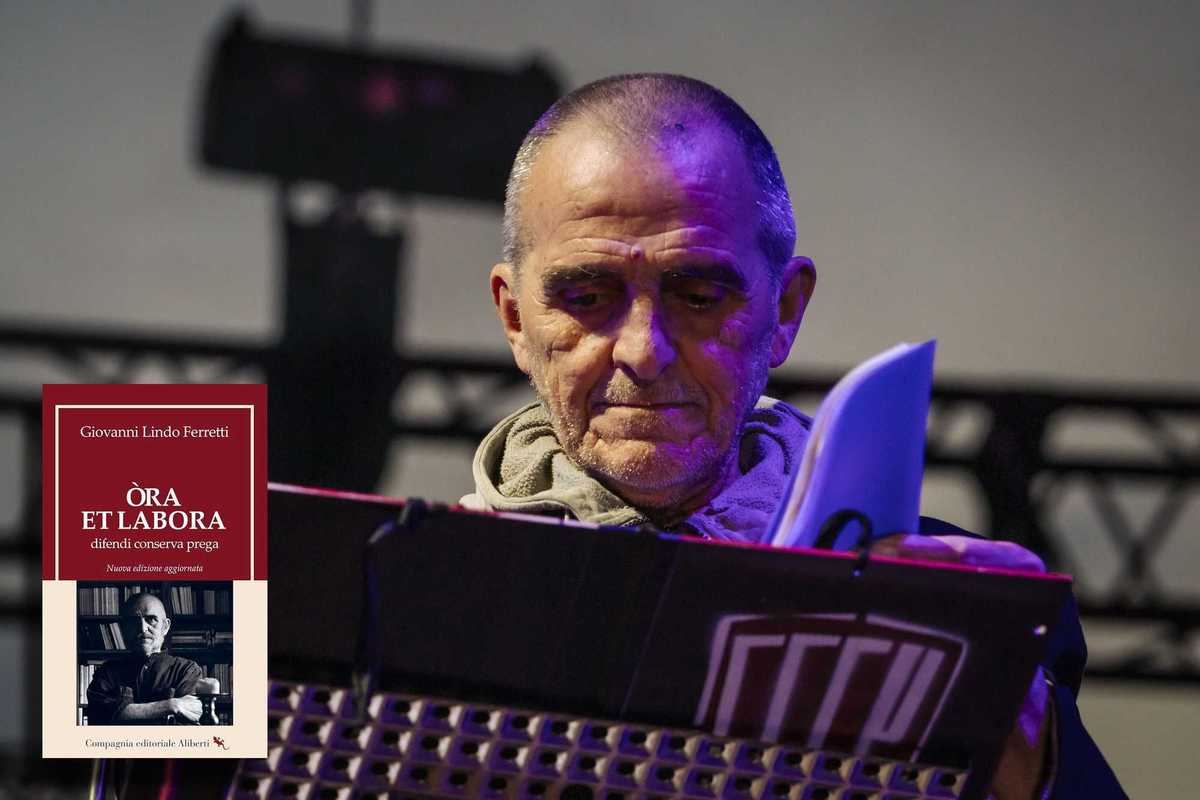Viste le circostanze, a mostrarsi in pubblico con la maglietta della X Mas - la stessa che è costata a Enrico Montesano l’espulsione dalla Rai con ampio carico di infamia – dovrebbero essere Carola Rackete, Luca Casarini, Nicola Fratoianni e numerosi altri tifosi dell’accoglienza senza limiti. Leggendo i giornali italiani, infatti, sembra proprio che i combattenti della Decima fossero entusiasti precursori degli attuali attivisti delle Ong.
Tutto si sviluppa a partire dall’arrivo nelle sale del nuovo film di Edoardo De Angelis intitolato Il Comandante, con Pierfrancesco Favino nei panni del personaggio principale, ovvero Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina. Todaro, il 16 ottobre del 1940, si rese protagonista di uno dei tanti eroici episodi che lo hanno consegnato alla storia. Al largo dell’isola di Madera avvistò un’imbarcazione nemica, il piroscafo belga Kabalo. Lo attaccò senza esitare, prima con i siluri (ma gli attacchi andarono a vuoto) e poi con il cannone di bordo, riuscendo ad affondarlo. Todaro però non si limitò a compiere il dovere di militare: diede pure prova di straordinaria umanità. Fece emergere dalle acque il sommergibile e soccorse i 26 membri dell’equipaggio del Kabalo, salvandoli da morte certa sul fondo dell’Oceano.
Il gesto suscitò le ire dell'ammiraglio Karl Dönitz, gran capo dei sommergibilisti tedeschi, il quale si sentì in dovere di biasimare il «buon samaritano» italiano. Todaro lo gelò con una risposta perfetta: «Gli altri non hanno, come me, duemila anni di civiltà sulle spalle». Come a dire: noi siamo italiani, e il nostro comportamento dev’essere all’altezza del nostro retaggio.
Questi i fatti entrati nei manuali. L’interpretazione che oggi ne viene offerta, tuttavia, è parecchio discutibile. Ad esempio quella scodellata da Sandro Veronesi – scrittore premio Strega e sceneggiatore de Il Comandante – ieri su La Stampa. Egli, opportunamente stimolato dall’intervistatrice, suggerisce un parallelo fra la nobile azione di Todaro e il comportamento di chi recupera migranti al largo della Libia. «Il principio del soccorso in mare è sacro», spiega Veronesi, «la priorità del salvataggio è obbligatoria, dopo l’operazione Mare Nostrum questi concetti sono stati messi in discussione e confusi con quelli dell’accoglienza».
A Repubblica, il regista De Angelis rincara la dose: «Il film indaga i rapporti tra italiani e prigionieri dentro il sommergibile che diventa un crogiuolo di religioni, culture, lingue». Todaro, aggiunge, era un militare, «cosa che non gli ha impedito di ricordarsi cosa vuol dire essere umano». E riecco il parallelo con le Ong: «I fatti di oggi sono legati alla mistificazione del concetto di forza intesa come sopraffazione, la storia di Todaro spiega come l’uomo davvero forte è quello capace di tendere la mano al debole».
In effetti, riguardo ai salvataggi in mare di mistificazioni ce ne sono parecchie, ma non quelle su cui punta il regista. Per prima cosa, la vicenda di Todaro smonta tutta la retorica attuale sul fascismo, a cui si fa abbondantemente ricorso proprio riguardo ai salvataggi in mare. Chi si oppone agli sbarchi di massa, dicono da sinistra, è un perfido nazifascista disposto addirittura a compiere una orrenda selezione in stile lager dei migranti. Ebbene, giova ricordare che il comandante Todaro, al momento del salvataggio, stava combattendo per il Fascio.
Non solo. Salvatore Todaro, nel 1941, entrò (volontariamente e con soddisfazione) nella X Mas. Assieme a Junio Valerio Borghese, che era stato suo compagno d’accademia, Todaro procedette alla riorganizzazione della flottiglia che si trovava in un momento di particolare difficoltà dopo le perdite subite durante l’attacco a Malta del 26 luglio dello stesso anno. Borghese si intestò il comando dei mezzi subacquei, Todaro divenne comandante dei mezzi di superficie. Per la Decima combatté fino al 14 dicembre del 1942, cioè fino al giorno in cui perse la vita nel tentativo di affondare le navi degli Alleati che si trovavano alla fonda presso il porto di Bona, in Tunisia. Todaro comandava i tre barchini siluranti che avrebbero dovuto colpire i nemici, ma le condizioni meteo avverse danneggiarono la missione, e l’eroe italiano fu ucciso sulla via del ritorno dalle raffiche di uno Spitfire britannico.
Manco a dirlo, sull’appartenenza di Todaro alla Decima i media nostrani hanno ampiamente sorvolato. Del resto, specie dopo le polemiche su Montesano, una sola versione può entrare nel discorso pubblico: la Flottiglia era composta da criminali fascisti, e va ricordata come una banda di assassini. L’unico a menzionarla, sempre su Repubblica, è Gianluca Di Feo, all’interno di un breve commento ricco di mirabili acrobazie. Lo stimato collega, infatti, spiega che le incursioni di Todaro per la Decima erano «più o meno le stesse che oggi compiono i commandos ucraini contro i russi». Capito? Per ripulire l’immagine di Todaro dall’onta fascista bisogna avvicinarlo a Carola Rackete e pure ai «nuovi partigiani» ucraini.
Come vedete, tutta questa storia è una collezione di cortocircuiti per il mondo progressista. Da un lato i nostri splendenti intellettuali si servono di Todaro per dimostrare che gli italiani hanno «i salvataggi in mare nel Dna», dall’altro devono in qualche modo giustificare la totale lontananza ideologica del comandante. Il quale, a ben vedere, si muoveva entro un perimetro ideale che è l’esatto opposto di quello delle Ong. Todaro era un combattente fiero della sua identità nazionale, pronto a morire per la patria. Gli attivisti di oggi, invece, vogliono costruire un mondo privo di frontiere. E, soprattutto, non rischiano la propria pelle, ma quella altrui.


 Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania
Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania