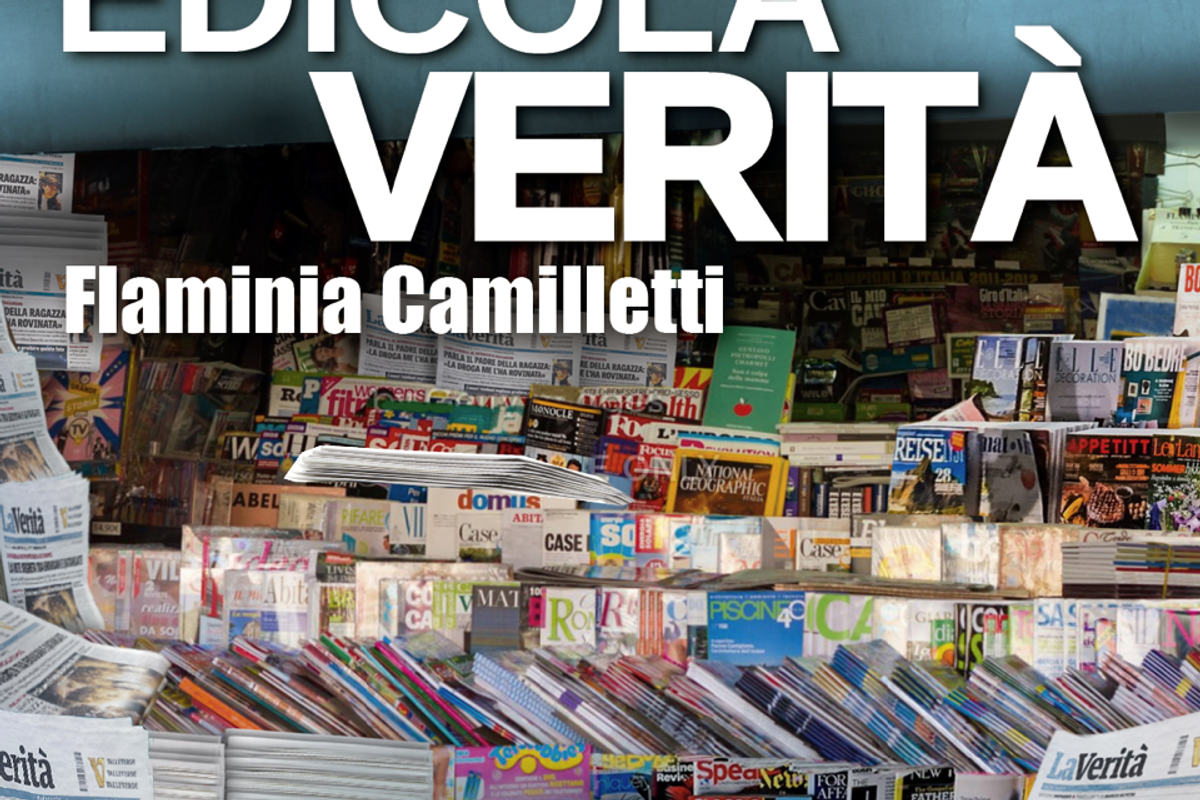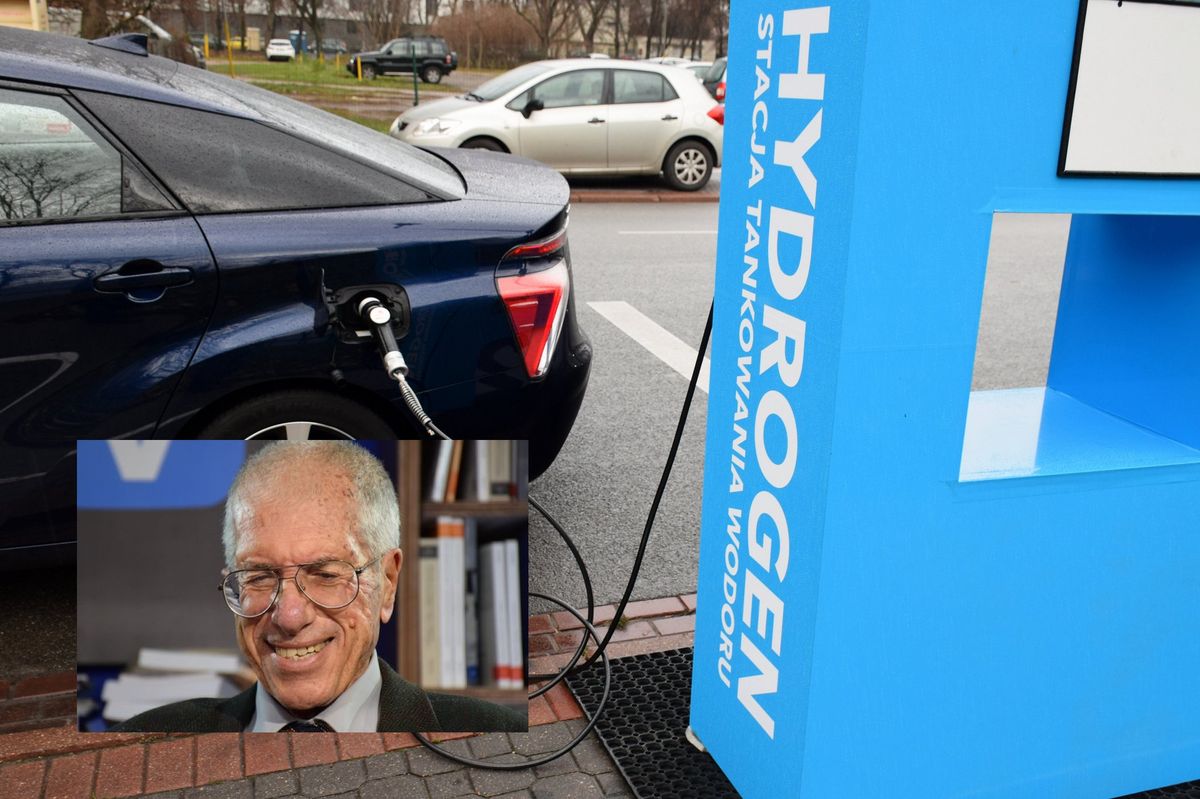
Il dogma dell’auto elettrica a tutti costi inizia a scricchiolare in Europa. Politica e mondo imprenditoriale, a suon di ceffoni menati da un mercato sempre più riottoso a spendere decine di migliaia di euro per le vetture a batteria, stanno mettendo in dubbio il totem che ha guidato strategie e investimenti degli ultimi anni. Miliardi buttati? Forse sì, come sentenziato su queste pagine proprio una settimana fa da Jody Brugola, discendente del mitico inventore dell’omonima vite e alla guida dell’azienda di famiglia che sta per tagliare il traguardo dei cent’anni di vita: «Le case automobilistiche si stanno accorgendo di aver buttato miliardi per l’elettrificazione delle vetture. Penso che, per il presente e anche per il futuro, un’ottima soluzione già a portata di mano per sostituire i carburanti fossili sia l’idrogeno». Una soluzione caldeggiata anche da Luigi Campanella, chimico, già ordinario di Chimica analitica all’Università Sapienza di Roma, oggi di Chimica dell’ambiente dei beni culturali. È stato presidente della Società chimica italiana e preside della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali alla Sapienza di Roma. Alla Verità spiega a che punto sono gli studi sull’idrogeno, oggi, in Italia.
Professore, a che punto siamo con gli studi sull’idrogeno nel nostro Paese?
«Il problema energetico impone, per la sua soluzione, scelte alternative a quanto fatto finora. Il binomio tra energie fossili e rinnovabili non è più monolitico, si cercano nuove soluzioni. L’idrogeno è un capitolo importante. È presente in natura in elevate concentrazioni, ha una disponibilità accessibile e attrattiva. Ma a questa disponibilità corrisponde un problema: l’idrogeno, in natura, non è presente come tale ma come elemento di un composto. Se lo si vuole utilizzare, bisogna estrarlo. E questo presuppone dei costi. Da qui gli aggettivi colorati che gli sono stati dati: nero, grigio, azzurro, verde. L’idrogeno verde è quello che prevede delle tecnologie di estrazione che siano sostenibili e ambientalmente compatibili. Tutto il contrario avviene ovviamente per quello nero. Le differenze si riflettono nei costi di estrazione: 2 euro a chilogrammo per quello nero, un costo che lo posiziona all’interno del mercato dell’energia; 7 euro a chilogrammo per quello verde. Una cifra, in questo caso, che lo pone fuori dal mercato».
Quali sono le prospettive, dunque?
«La speranza è quella di avere, nel 2050, l’idrogeno alla base di almeno un quarto dell’energia prodotta. Ma, ovviamente, sarà necessario, da qui a quella scadenza, procedere con l’abbattimento dei costi, altrimenti l’idrogeno rimarrà un vettore energetico interessante ma all’interno di quella che possiamo chiamare fascia nera, che non ci rende indipendenti da una produzione ulteriore di effetto serra, come conseguenza della sua estrazione».
Come si sta muovendo la ricerca?
«Se noi pensiamo all’idrogeno verde, che attira di più in prospettiva come risposta all’effetto serra, dobbiamo per forza arrivare a un nuovo sistema per ricavarlo. A parte l’uso sperimentale di alcuni batteri, oggi si presenta interessante, dal punto di vista pratico, il sistema di estrazione più verde che c’è: l’acqua. Per ricavare idrogeno, deve essere idrolizzata, scomposta nei suoi due componenti, idrogeno appunto e ossigeno. Bisogna, ovviamente, applicare un campo elettrico ma questa energia, se arriva dai fossili, non va bene. Il problema ambientale, così, non si risolve. Ma la ricerca sta studiando dei metodi di elettrolisi alternativi che sfruttino altre forme di energia come quella solare».
Ma così i costi di produzione non rischiano di rimanere elevati?
«Facciamo gol se: usiamo l’acqua per ottenere idrogeno; usiamo l’elettrolisi come metodo di separazione; usiamo come energia quella solare, la più verde possibile da utilizzare. Certo, così il costo di produzione resta elevato. Ma la ricerca sta individuando delle strade per abbatterlo, questo costo. E sono due: rendere il processo che utilizza l’energia solare da trasformare a rendimento elevato, facendo leva sul miglioramento dei semiconduttori; oppure, usare elettrodi che abbiano un potere catalitico tale da abbassare la quantità di energia necessaria».
Dove può «sfondare» l’idrogeno?
«Ci sono tre campi d’applicazione: la mobilità, l’industria e i processi chimici. Quello più sviluppato è, oggi, quello della mobilità. Nel mondo sono prodotte solo 10.000 auto che usano l’idrogeno come combustibile. Ma possiamo arrivare a 2,5 milioni di auto in una quindicina d’anni. In quel caso avremmo come emissioni soltanto acqua. Dal punto di vista ambientale, è un super gol. Ma nello stesso settore si sta sviluppando un’altra tecnologia: l’idrogeno non come combustibile al posto della benzina, ma come sorgente elettrica. Alle batterie tradizionali si stanno sostituendo le celle a combustibile a idrogeno».
Quindi l’idrogeno può sostituire la benzina?
«Una delle sue caratteristiche principali è la densità energetica, l’energia collegata all’unità di massa. In un chilo di benzina ci stanno 10 moli. In un chilo di idrogeno ce ne stanno 500, di moli. La densità energetica dell’idrogeno è maggiore rispetto alla benzina e con peso molecolare nettamente inferiore. Questo vuol dire che a parità di quantità di carburante, l’idrogeno produce più energia con un valore di inquinamento pari a zero».
L’idrogeno, come alternativa alla benzina, viene «coltivato» dai costruttori di auto?
«Nel mondo, le case automobilistiche che ci stanno dando dentro nell’applicare l’idrogeno ai propri prodotti sono tre: la Toyota, la Nissan e la Hyundai: colossi che possono avere la capacità di abbattere i costi produttivi. In Italia abbiamo la Hydrogen mobility che ha messo a punto una macchina a idrogeno. Abbiamo un accordo recente tra Edison, Tenaris ed Eni per investire sull’idrogeno. E poi abbiamo un’associazione di piccole imprese che lavorano sull’applicazione dell’idrogeno nella mobilità e che hanno lanciato recentemente una petizione, sottolineando come sia difficile per realtà come la loro operare senza degli incentivi statali. Il momento difficile è l’inizio, bisogna investire. Queste aziende hanno fatto rilevare che in Italia mancano le infrastrutture che aiutano queste pmi e gli incentivi statali».
Quindi è «solo» un problema di soldi?
«Il problema è sostanzialmente uno: quello della scalabilità. L’idrogeno è un settore difficile per quanto riguarda il passaggio dal laboratorio alla realtà, alla macchina diciamo. Questo passaggio è quello che toglie alle pmi la possibilità, non avendo gli incentivi, di iniziare i lavori di laboratorio e, laddove invece questi valori vengono iniziati, di passare a valori di scala superiori che sono quelli che danno un ritorno economico sul mercato. E questa difficoltà si riflette nei numeri: i progetti sull’idrogeno italiani sono 200, in Francia sono circa 500, in Germania sono vicini a mille. Le startup italiane che lavorano sull’idrogeno sono oggi solamente otto. Numeri bassissimi per il nostro Paese».
Le imprese italiane sono, per così dire, frenate.
«C’è una evidente difficoltà nel fare ricerche in settori nuovi, se non hai incentivi o finanziamenti ad hoc o dei Piani nazionali».
Però ci sono progetti faraonici, per così dire, come quello legato al treno a idrogeno che vede in campo Regione Lombardia, o come quello, che sarà a regime dalla prossima estate, dei 25 porti italiani dove l’idrogeno è divenuto il combustibile unico di alimentazione per le imbarcazioni che vi attraccano.
«Ha messo il dito nella piaga. Mentre una pmi non riesce a partire, nascono questi grandi progetti. Sono sicuramente eccellenze ma di rilievo modesto dal punto di vita nazionale».
La priorità della politica comunitaria europea, finora, è stata data sempre e solo all’elettrico.
«Ha ragione, finora è stato così. Non c’è stato spazio per alternative valide come l’idrogeno».
Il nostro governo o la nuova Commissione europea che uscirà dalle urne a giugno, quali passi dovrebbero compiere verso l’idrogeno?
«Serve una politica di educazione e di sensibilizzazione, di conoscenza dell’idrogeno. Quando a un cittadino spieghi perché investi nell’idrogeno, non devi fare discorsi complicati. Devi solamente dire: se prendo l’idrogeno e lo brucio, produco acqua; se prendo qualsiasi altro combustibile e lo brucio, produco anidride carbonica, ossido di carbonio, polidrocarburi e altre sostanze. Il confronto è semplice: quale delle due condizioni è più favorevole per la salute dell’uomo? La risposta è ovvia. I cittadini vanno informati, serve una campagna di conoscenza. E poi servono infrastrutture per abbattere i costi delle pmi e incentivi iniziali. Non dico a vita, ma far partire un progetto per studiare nuove forme di energia è una scelta giusta. Poi, se non si riesce a concludere niente, l’impresa viene lasciata. Ma bisogna partire».
Sostenendolo come si deve, l’idrogeno può rappresentare davvero un’alternativa alla benzina?
«Mantengo lo scetticismo del ricercatore. Ho visto, in passato, grandi attenzioni su settori che, poi, si sono un po’ sgonfiati. L’idrogeno è sicuramente in un momento favorevole, alcune delle opzioni alternative hanno dei punti interrogativi circa una loro applicazione diretta nella nostra vita. Ha una concorrenza debole, si potrebbe dire, e questo gli dà forza. Ci sono comunque difficoltà: la produzione costa ancora troppo ed è un gas diffusivo che tende a espandersi e quindi servono tubazioni. Abbiamo chiaro quello che abbiamo di fronte. Bisogna decidersi di perseguire su questa strada».