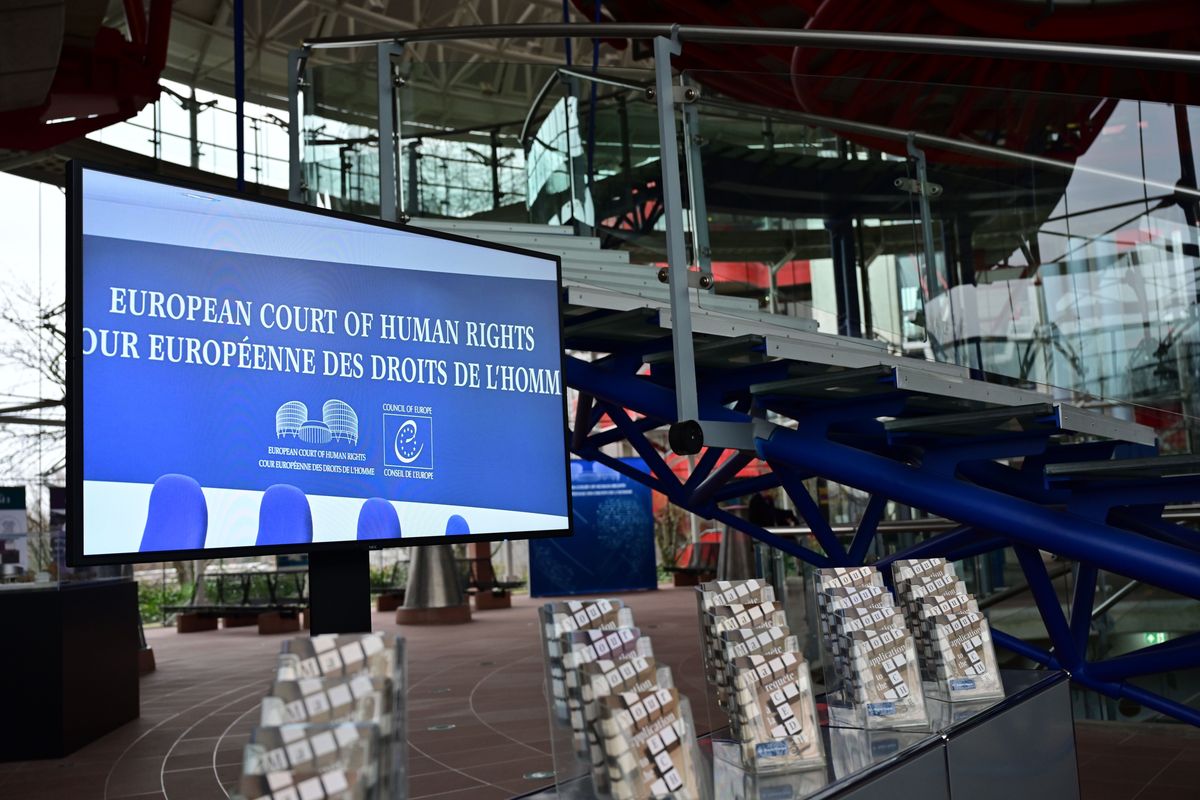
Pietro Dubolino, Presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione
Come ricordato da Patrizia Floder Reitter sulla Verità del 1 luglio 2025, Giorgia Meloni e la premier danese Mitte Frederiksen, in occasione della visita di quest’ultima a Roma, il 22 maggio scorso, sottoscrissero una lettera aperta - alla quale poi aderirono i capi di Stato e di governo di Austria, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca e repubbliche baltiche - in cui si denunciava come la giurisprudenza della Corte europea del diritti dell’uomo (Cedu), eccessivamente orientata in favore dei veri o presunti diritti dei «migranti», rendesse oggettivamente più difficile del dovuto il contrasto all’immigrazione irregolare. Denuncia, questa, poi sostanzialmente condivisa - come pure riferito nei giorni scorsi dalla Verità - anche dall’ «autorevole» (per definizione) Financial Times nonché dal commissario europeo agl’Interni Magnus Brunner, secondo il quale, per rimediare, occorrerebbe «fornire basi giuridiche affinché la Corte possa giudicare in modo diverso».
A quest’ultimo proposito vi è però da osservare che le «basi giuridiche» poste a fondamento delle pronunce della Cedu non si presterebbero affatto, di per sé, se rettamente interpretate, a giustificare il lamentato indirizzo «immigrazionista». Esse sono, infatti, costituite, essenzialmente, per quanto qui interessa, dal «divieto di tortura» previsto dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e, per l’implicito richiamo in esso contenuto, dall’obbligo del «non réfoulement» (non respingimento) contenuto nell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo «status» dei rifugiati, in cui si afferma che nessuno Stato contraente «espellerà o respingerà in alcun modo un rifugiato verso frontiere o territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate per via della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica». Ora, nella originaria e normalmente recepita interpretazione del suddetto obbligo, era pacifico che esso operasse soltanto in favore di quanti avessero ottenuto il formale riconoscimento dello «status» di «rifugiato». Si dava, infatti, per scontato che, nella normalità dei casi - in un’epoca in cui anche in Europa esistevano rigidi controlli alla frontiera di ogni singolo Stato - si trattasse di soggetti che avessero legalmente fatto ingresso nel territorio dello Stato al quale veniva poi richiesto il riconoscimento in questione. Dalla regola del «non réfoulement» non si sarebbe, quindi, potuta in alcun modo desumere - come invece è stato fatto dalla Cedu in diverse sue sentenze, tra cui, in particolare, quella «Hirsi c. Italia» del 2012 - l’esistenza di un divieto di respingimento alla frontiera di quanti pretendano di entrare, quale che sia la loro provenienza, senza averne titolo, solo adducendo o lasciando intendere di voler chiedere lo «status» di rifugiati.
Quel che occorrerebbe, dunque, con riguardo alla Cedu, non è tanto un mutamento delle «basi giuridiche» delle sue pronunce quanto un mutamento della loro interpretazione da parte dei giudici che la compongono, i quali - è bene ricordarlo - sono tutti di nomina sostanzialmente politica.
Ma non è solo la Cedu ad essere (o, almeno, apparire) pregiudizialmente orientata a favore dei «migranti». Analogo orientamento, infatti, si riscontra nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con la differenza, però, che la sua base giuridica è essenzialmente costituita dalla normativa dettata, in materia di immigrazione, dall’Unione europea, sotto forma di regolamenti, di diretta applicazione nei singoli Stati, o di direttive, non direttamente applicabili nei singoli Stati ma alle quali questi ultimi sono obbligati ad adeguare la propria legislazione interna. È, dunque, soprattutto su tale normativa che bisognerebbe intervenire, se si ritiene - come ultimamente ritenuto, ad esempio, anche dal ministro degl’Interni francese Bruno Retaillerau - che essa impedisca un’efficace difesa dei confini nazionali da indebite, massicce intrusioni di stranieri non aventi titolo, in partenza, ad essere accolti. In attesa, però, di tali interventi - richiedenti, com’è noto, procedure estremamente lente, macchinose e defatiganti - occorrerebbe, per quanto riguarda specificamente l’Italia, almeno eliminare dal suo ordinamento interno una vistosa anomalia: quella, cioè, costituita dall’obbligo, per il legislatore ordinario, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001,contenente la riforma dell’intero Titolo V della Costituzione, di attenersi al rispetto, oltre che all’ovvio rispetto della Costituzione, anche a quello «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Una riforma, quella ora detta, che ben a ragione il prof. Geminello Preterossi, nell’intervista comparsa sulla Verità del 30 giugno u.s., ha definito «sciagurata». Il suddetto obbligo, infatti, comportando (salvo rare, possibili eccezioni) l’equiparazione, di fatto, di una qualsiasi direttiva europea ad una norma costituzionale, fa sì che, qualora una norma interna sia ritenuta in contrasto con essa, si possa farla cadere, ad iniziativa di qualsiasi giudice chiamato ad applicarla, sotto la mannaia della Corte costituzionale per violazione appunto del citato art. 117. Il che si pone in radicale e assurda contrapposizione al fondamentale e da sempre indiscusso principio secondo cui la violazione di un accordo internazionale, anche per effetto di una norma interna introdotta o mantenuta da uno degli Stati contraenti, può dar luogo soltanto a responsabilità di quest’ultimo nei confronti degli altri Stati o dell’organismo sovranazionale (com’è l’Unione europea) creato da quell’accordo, ma non può mai tradursi in un motivo di invalidità della norma interna rilevabile dall’organo, parimenti interno, dal quale quella norma debba essere applicata. In determinate condizioni, infatti, l’inosservanza di un accordo internazionale può anche rispondere ad un superiore interesse dello Stato, la cui valutazione non può che essere rimessa alla sola autorità politica che ne risponderà, poi, in regime di democrazia, al corpo elettorale.
C’è quindi da augurarsi che venga ripresa e portata ad effetto la proposta di legge costituzionale avanzata tempo addietro, senza fortuna, dalla Lega, volta ad eliminare dall’art. 117 della Costituzione l’obbligo di conformità delle leggi interne ai vincoli derivanti da accordi internazionali, ivi compresi, in primo luogo, quelli imposti dall’appartenenza all’Unione europea. Ciò non comporterebbe, di per sé, violazione alcuna dei trattati europei e sarebbe, quasi sicuramente, approvato, in caso di «referendum», dalla maggioranza dei cittadini.






