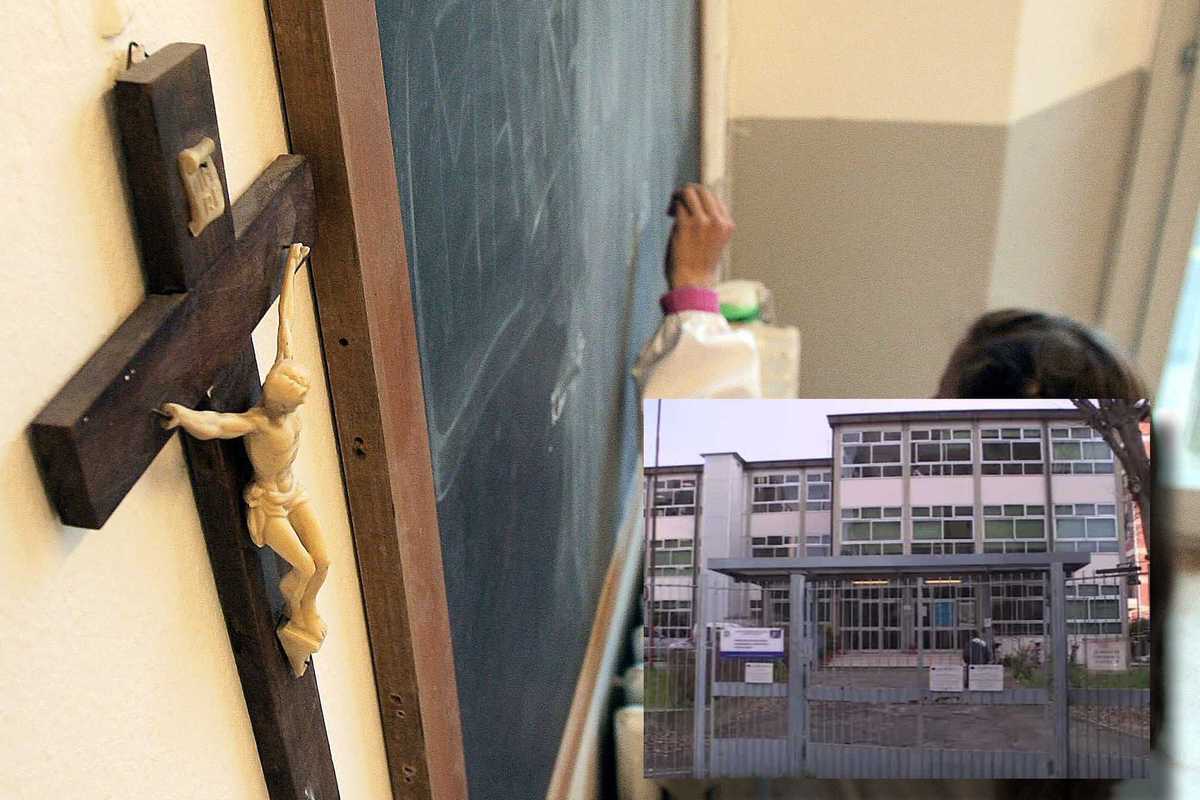Fu il democristiano Giulio Andreotti a mandare in esilio la Befana - assieme a San Giuseppe, San Pietro, San Paolo- abolendo nel 1977 la festa dell’Epifania del 6 gennaio e costringendo la vecchietta che porta i doni ai bambini buoni a cavalcare la scopa, pendolare della festa soppressa, in giorno lavorativo.
L’Epifania, secondo il legislatore, fu cancellata dal calendario civile in quanto incideva negativamente sulla produttività delle aziende e dei pubblici uffici. Alla Befana fu restituito il brevetto di volo festivo otto anni dopo, nel 1985, dal socialista Bettino Craxi che ripristinò la festa del Piccolo Natale rimettendo i Re Magi al loro posto davanti alla capanna di Betlemme con l’oro, l’incenso e la mirra da donare a Gesù bambino. La parola «Befana», insegnano gli etimologisti, deriva da Epifania, parola greca che significa manifestazione, passando per le voci gergali pifanìa, pifana, bifana, befana. L’Epifania, dice il proverbio, tutte le feste porta via. In effetti l’Epifania spegne lo spirito festaiolo e gastronomico che va dall’Avvento al Natale e da Natale a Capodanno, ma Epifania fa rima anche con gastronomia. Prima di cedere il passo a una lunga serie di giorni «normali», l’ultimo giorno del tempo di Natale accende i fuochi di antiche tradizioni culinarie servendo sulle tavole italiane lasagne, canederli, casunzei, tortelli, minestre, zuppe, capponi, salsicce e un’infinità di dolci.
Partendo da Ovest troviamo in Piemonte la fugassa d’la Befana dolce tipico (farina, zucchero, uvetta, canditi, granella di zucchero) a forma di fiore con tanti petali che si mangia e si gioca: due petali della focaccia nascondono altrettante fave, chi le trova deve pagare pegno offrendo il bere o la fugassa stessa. Un gioco che si fa anche in qualche località della Sardegna, ma senza pegni da pagare: nel dolce dell’Epifania si mescolano una fava, un cece e un fagiolo. Cotto l’impasto e servito in tavola, chi trova uno dei tre legumi nella propria fetta sarà fortunato tutto l’anno.
In Liguria si preparano biscotti da intingere nel vino dolce che vantano una antichissima storia: gli anexin (pronuncia anejin) genovesi. Sono anicini fatti con farina, zucchero, uova e un bicchierino di anice. Nel Ponente ligure, sulla strada per la Francia, troviamo la ciambella dei Re Magi, una soffice torta decorata con canditi, uvetta e granella di zucchero. È un dolce che risente della cultura gastronomica transalpina. In Francia lo chiamano galette de Rois in ossequio ai Re Magi. È una torta di pan brioche tradizionalmente farcita di frangipane e crema di mandorle, che qualche storico fa risalire addirittura ai legionari romani, spiegando che la preparavano per i Saturnalia, i giorni di festa dedicati a Saturno. Anche la galette, come la fugassa piemontese, nasconde una fava in una fetta, ma anche in questo caso chi la trova non paga pegno. Anzi, viene addirittura proclamato re della giornata e cinto con la corona che si pone in tavola accanto alla torta.
Le grandi protagoniste del pranzo dell’Epifania ligure sono le lasagne. Lo precisa l’Accademia Italiana della cucina nel libro sulle tradizioni gastronomiche delle festività religiose. L’Accademia cita il proverbio che minaccia chi non rispetta la tradizione: «Chi pe’ a Pefana i no fa la lasagna, tuto l’ano i s’arencagna». Cioè: chi per la Befana non mette in tavola le lasagne patirà la fame per tutto il resto dell’anno. Nel Varesotto, in Lombardia, più che ai Re Magi si punta alle loro cavalcature confezionando i cammelli dell’Epifania, dolcetti di pasta sfoglia che hanno la forma degli animali bis-gibbuti del deserto. In Brianza c’è una guerra di campanile tra Desio e Lissone per la paternità dei papurott dell’Epifania, pupazzetti antropomorfi fatti con farina, lievito, latte, zucchero e uvetta.
A Venezia il 6 gennaio arriva una parente stretta della Befana, la Marantega che, come la sua affine, è vecchia, brutta e porta i doni passando per la cappa del camino come riferisce Domenico Giuseppe Bernoni, etnologo vissuto nell’Ottocento, nel libro Tradizioni popolari veneziane. Nel sacco dei dolci in consegna, la Marantega porta immancabilmente la pinsa, una focaccia dolce, antichissima, preparata con due farine, di polenta e di frumento, uova, semi di finocchio, latte, uvetta, pezzetti di fico secco e, un tempo, con strutto, ora con burro. Nelle campagne di Pinocchio, tra Collodi, Lucca e la Versilia, in Toscana, i biscotti tipici dell’Epifania hanno un nome che più chiaro non può essere: befanini. E poiché in alcuni racconti si parla del marito della Befana, tale Befanotto, in suo omaggio vengono preparati biscotti con il suo nome, i befanotti, preparati con lo stesso tipo di impasto dei befanini: farina, burro, uova, zucchero, scorza grattugiata di limone, latte, rhum, confettini colorati e con le stesse tradizionali forme natalizie.
A Siena, antichi quanto il panforte e i ricciarelli, i biscotti dell’Epifania si chiamano cavallucci perché un tempo si offrivano ai viaggiatori nelle stazioni di cambio dei cavalli. Hanno forma rotonda, impasto morbido a base di noci, frutta candita, anice, cannella e altre spezie.
La tradizione dei biscotti epifanici continua passando dalla Toscana alle Marche, con le pecorelle di Corinaldo, il bellissimo borgo medioevale a una cinquantina di chilometri da Ancona. Ci vuole un bel po’ di fantasia per vedere delle pecore in questi biscotti di pasta sfoglia ripieni di mosto cotto, noci, cannella, pan grattato, frutta candita, scorze di arancia e limone. Somigliano ai cantucci toscani, ma sono tutt’altra cosa i pepatelli di Teramo, in Abruzzo, e gli mbepatielli molisani. Non è difficile intuire perché si chiamano così: tra gli ingredienti (farina, miele, cacao, mandorle) c’è il pepe nero che dà al biscotto un sapore particolare, ma senza nascondere il dolce.
Cosa si mangia a Napoli per l’Epifania? Si mangia, anzi, si beve o broro ‘e purpo, il brodo di polpo, pietanza antichissima che risale al tempo in cui Napoli si chiamava Parthenope e cioè all’epoca della Magna Grecia. I puristi della tradizione consumano o broro ‘e purpo passeggiando per Napoli nella notte dell’Epifania. Anche gli struffoli, secondo gli storici della fantasiosa cucina napoletana, palline preparate con farina, uova, zucchero e liquore all’anice, prima fritte poi rotolate nel miele caldo e decorate con i diavulilli, confettini multicolorati, sono di origine ellenica. Lo confermerebbero i Loukoumádes greci, stessa forma e (quasi) stessi ingredienti degli struffoli.
Se non fosse per gli zuccherini che li decorano, i purcedduzzi salentini, in Puglia, potrebbero essere scambiati per un piatto di gnocchi al pomodoro. La forma è la stessa, la superficie rugosa impressa dal rovescio della grattugia anche. Ricordano anche gli struffoli napoletani: anch’essi dopo la frittura vengono rotolati nel miele bollente e decorati con granella di zucchero di cento colori. Da Natale all’Epifania in Puglia - ma anche nella vicina Basilicata dove si chiamano crispedde e in Calabria dove prendono il nome di nevole - si fanno le cartellate, dolci dalla forma molto elaborata e simbolica. La pasta fatta con farina, olio e vino bianco viene modellata con ghirigori che ricordano un labirinto o una rosa. Una volta fritto, sul dolce viene versato un po’ di mosto cotto o un liquido denso, sempre cotto, ricavato dai fichi.
A Montelepre (Palermo) all’Epifania si tiene la sagra della sfincia di prescia, frittella così chiamata perché preparata in fretta. L’impasto è molto semplice: farina, latte e zucchero. Dall’impasto si ricavano le sfince a forma di «e» che vengono fritte nell’olio bollente e poi passate nel miele. Alla sfincia era legata un tempo una curiosa usanza: in caso di lite tra suocera e nuora la prima preparava le sfince che regalava alla seconda per ristabilire la pace. Meglio, l’armistizio.