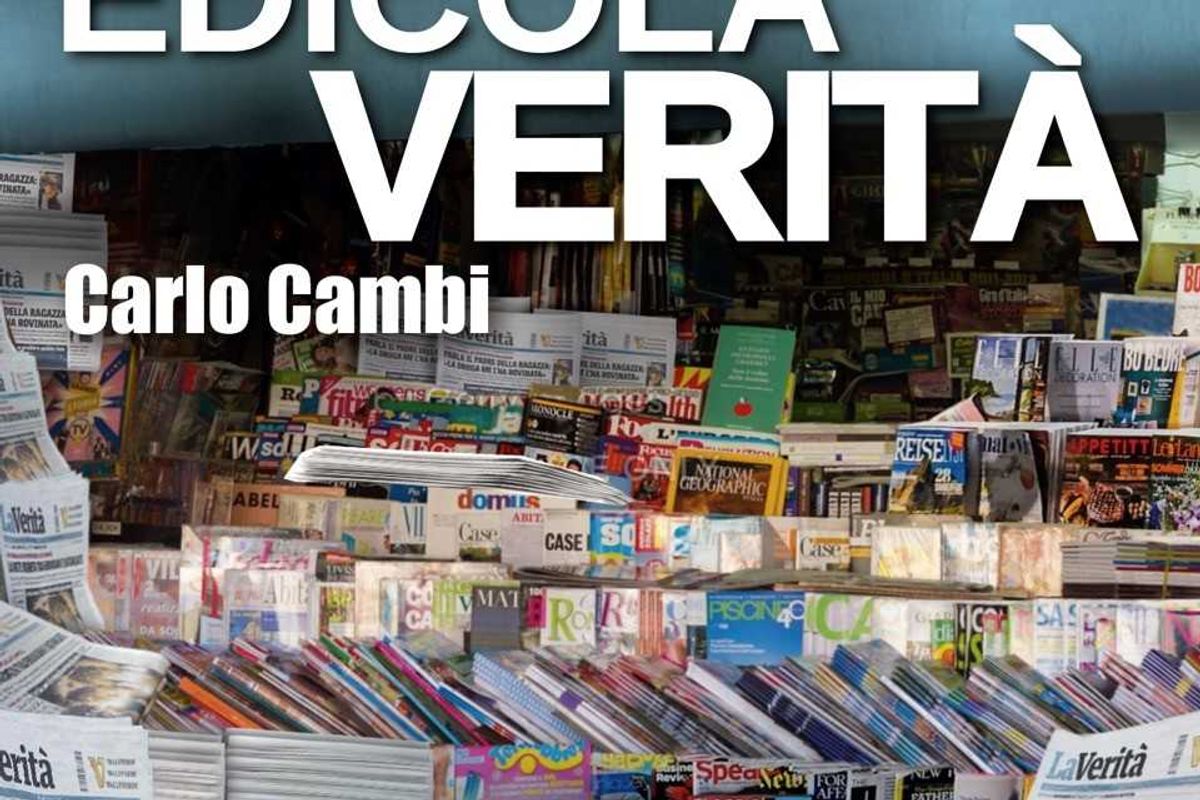- La nota al Def s'impegna per l'ennesima volta a eliminarli, ma non spiega come. L'ultimo censimento è del 2012: sono più di 500 e ci costano oltre 10 miliardi l'anno.
- «Nessun politico è intenzionato a sopprimere i pachidermi di Stato». Roberto Perotti, l'economista chiamato nel 2014 a sfrondare le società pubbliche spiega il flop della spending review di Matteo Renzi. «I miei dossier si sono arenati alla fase pre operativa. Lo spreco peggiore? Gli stipendi degli ambasciatori».
Lo speciale comprende due articoli.
L'ultima puntata della guerra agli enti inutili è scritta nella nota al Def 2019 (il Documento di economia e finanza). Una riga secca, nella quale il governo Conte bis ribadisce l'impegno a chiudere gli enti inutili. Nulla di più, nemmeno una quantificazione delle risorse pubbliche che si potrebbero recuperare. Sembra quasi un messaggio di impotenza, ancora più emblematico, se si pensa che i 5 stelle hanno fatto della lotta alla casta e agli sprechi il loro distintivo. D'altronde la storia parla chiaro. Chi ci ha provato, in passato, ha dovuto desistere. Guai a toccarli. E la spesa corre: il mantenimento di certe realtà costa allo Stato e quindi alle nostre tasche, oltre 10 miliardi l'anno.
Secondo l'ultimo censimento, effettuato dal governo Monti nel 2012, sarebbero più di 500 gli enti che zavorrano il bilancio pubblico: una ragnatela di istituti vigilati, partecipate, consorzi, comunità montane, fondazioni, associazioni in difesa di qualcosa o di qualcuno, comitati.
Oggi tali istituti dovrebbero seguire le regole previste dal Tusp, il Testo unico per le società a partecipazione pubblica, varato nel 2016, che ha imposto alle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una verifica di tutte le società in loro portafoglio. È emerso che il 37% di quelle monitorate erano almeno in una delle condizioni critiche indicate dal Tusp (perdite di bilancio, assenza di dipendenti o in numero inferiore agli amministratori). Inoltre, 119 enti avevano i tre fattori di rischio. Le amministrazioni però hanno liquidato solo tre società su dieci. Alcuni enti hanno una longevità impressionante. Sanno adattarsi ai tempi.
L'Unione italiana tiro a segno risale al Regno d'Italia. È sopravvissuta a diversi tentativi di abolizione, ha cambiato pelle e ora è sotto la vigilanza del ministero della Difesa ed è affiliata al Coni. Che cosa fa? Organizza l'attività istituzionale svolta dalle varie sezioni del tiro a segno sparse a livello nazionale. Domandiamo a una sezione, quella di Roma, il perché di quello che ci pare un doppione. La risposta: «Noi dipendiamo da loro».
L'analfabetismo è debellato, ma l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (Unla), fondata nel 1947 nell'ambito del programma governativo del secondo dopoguerra di alfabetizzazione della popolazione, esiste ancora. E si è reinventata. Sul sito c'è scritto che si occupa «della progettazione e realizzazione di progetti speciali». Il presidente, Vitaliano Gemelli, ci spiega che l'istituto fa formazione, convegnistica, presenta libri, organizza dibattiti e manifestazioni di promozione del territorio. Riceve un finanziamento di 45.000 euro l'anno. Attività già coperte da altre istituzioni pubbliche.
In Piemonte, l'interesse per l'Africa è tale da giustificare la permanenza dal 1983 del Centro piemontese studi africani. L'ente promuove ricerche di grande importanza, secondo il direttore, Federico Daneo, ma non al punto da evitare che la Corte dei conti lo inserisse nella black list. Anche il Comune di Torino, l'anno scorso, gli ha negato 10.000 euro di contributi. L'istituto riceve fondi per 30.000 euro dalla Regione Piemonte. Quest'anno, per il progetto Diplomazia dell'acqua, sulle conseguenze della siccità nel Ciad, ha avuto 10.000 euro dalla Farnesina. L'anno scorso è stata la volta di uno studio sull'emergenza idrica del Nilo, che ha ottenuto dall'Autorità di bacino 15.000 euro. Alla Corte dei conti, Daneo replica che «è stato fatto un elenco basandosi su dati statistici e senza analizzare le singole iniziative». Forse alla magistratura contabile è saltato all'occhio l'organico di soli tre dipendenti in una sede di 230 metri quadri, di proprietà del Comune, gestita dall'Atc (le case popolari) con un affitto di 290 euro mensili. «È fatiscente», specifica Daneo. Infatti presto si trasferiranno nella centralissima piazza della Repubblica, in un appartamento ancora più grande: 300 metri quadri. L'Atc ha chiesto un canone di 1.500 euro, ma il Comune potrebbe ridurre l'affitto fino al 90%.
Alcuni enti cambiano nome nel tempo. L'Indire, l'Istituto di documentazione, innovazione e ricerca educativa, il più vecchio ente di ricerca del ministero dell'Istruzione, dalla sua nascita, nel 1925, ha mutato pelle più volte. Nel 2007 si trasforma in Ansas (Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica) per poi tornare a essere Indire nel 2012. Il suo compito? «Sviluppare azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali del personale della scuola». Attorno al patrimonio storico artistico prolifera una serie di enti. Uno di questi è l'Ales (Arte, lavoro e servizi) che ha inglobato l'Arcus, società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Ha come socio unico il ministero dei Beni culturali, che «supporta nell'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» e negli «uffici tecnico amministrativi». Ma non ci sono altre strutture pubbliche che svolgono questa funzione? È quanto ci chiediamo anche per l'Istituto regionale Ville Tuscolane (Irvit), nato nel 1992, che rivendica il compito inalienabile di «assicurare la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza» delle dieci Ville Tuscolane dei Castelli romani. Oltre a qualche convegno, l'ente collabora con la Regione Lazio alle giornate di apertura delle dimore storiche. La Regione non riesce a far fronte a queste iniziative? Sopravvive l'Istituto per l'incremento ippico per la Sicilia che, si legge nel sito, «raccoglie l'eredità del Regio deposito stalloni, creato nel 1884 dall'allora ministro della Guerra». Sempre in Sicilia, il Comune di Marsala, dal 2006, si è fatto affiancare, nella gestione dei servizi scolastici, dall'istituzione comunale «Marsala Schola». L'attività «ferve». L'ente è aperto tre ore e mezzo la mattina per tre giorni a settimana e due volte nel pomeriggio, un'ora e mezzo in più.
I centri studi sorgono come funghi. C'è il Cuia (Consorzio interuniversitario italiano per l'Argentina) che si occupa dei progetti di cooperazione tra le università italiane e argentine, l'Indam (Istituto nazionale di alta matematica) che promuove la ricerca nella matematica e i rapporti con centri internazionali (come se gli atenei non bastassero). C'è il Cinid (Consorzio interuniversitario per l'idrologia), per «favorire la cooperazione tra le Università consorziate» su difesa del suolo e salvaguardia dei sistemi ambientali. A quanto pare, le università non riescono a parlarsi tra di loro direttamente.
I primi tentativi di disboscare questa giungla risalgono al 1956, quando fu creato addirittura un ulteriore ente, l'Iged, per velocizzare l'operazione. Ha continuato a funzionare fino al 2002 ed è costato circa 50 milioni di euro l'anno. Ma il «bosco», anziché sfoltirsi, s'è allargato. A ottobre 2009, l'allora ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, aveva promesso «una ghigliottina» per 1.621 istituti ed era riuscito a scrivere 29 decreti di riordino per altrettanti enti. Ma i decreti sono stati bocciati. Mario Monti, nella cura da lacrime e sangue per il Paese, mise anche il taglio di poltrone eccellenti, ma solo a scadenza degli incarichi. La Corte dei conti, in una relazione del 2018, è stata netta: nessun risultato dalla spending review.
Chiudere un ente è un'impresa quasi impossibile. La liquidazione può durare anni e nel frattempo lo scenario politico muta. Basta vedere quello che è accaduto al Cnel, dove stanno ancora brindando per lo scampato pericolo. Abolito dal governo Renzi, questo parcheggio per sindacalisti, che in 82 anni di vita ha proposto 26 disegni di legge nessuno dei quali approvato dal Parlamento, è stato resuscitato dal fallimento del referendum 2016.
«Nessun politico è intenzionato a sopprimere i pachidermi di Stato»
Cosa accadde?
«Ero consigliere economico del premier. È stata un'esperienza “normale". Rapporti umani normali, anche cordiali con molte persone. Non posso dire di avere incontrato ostacoli, anche perché non sono mai arrivato ad una fase in cui potessi essere considerato una minaccia per qualche persona o organizzazione o ente. Mi piacerebbe poter dire altrimenti, ma ero decisamente fuori dai nodi decisionali».
Chi resisteva ai tagli?
«Di fatto mi sono occupato soprattutto di raccolta dati, sulla base dei quali traevo conclusioni che affidavo a dei dossier; ma in termini di tempo la raccolta dati era preponderante. Oltre non sono mai riuscito ad andare. Moltissimi dati sono online, se uno vuole li trova, quindi c'erano pochi ostacoli da frapporre. Altri li chiedevo ai ministeri. Alcuni hanno collaborato lealmente, altri meno, come la Farnesina. Ma questo non mi ha sorpreso perché in passato avevo criticato le remunerazioni, a mio avviso, molto alte, dei nostri ambasciatori».
Perché lasciò l'incarico?
«Mi ero accorto che le priorità erano cambiate, e il mio lavoro non era più una priorità, ammesso e non concesso che lo fosse mai stata. È una decisione politica che ancora adesso rispetto, forse al posto dei politici in quella situazione avrei fatto lo stesso, ma non avevo voglia di rimanere a Roma a girarmi i pollici».
A che punto era arrivato nel suo lavoro?
«Avevo prodotto molti dossier su ministeri, enti pubblici, aziende di Stato, remunerazioni, istituzioni politiche, spese fiscali... Nessuno è mai arrivato però a una fase nemmeno pre operativa».
I predecessori le avevano lasciato i loro report o ha cominciato da capo?
«In alcuni casi ho utilizzato il lavoro di Carlo Cottarelli e del suo staff, anche se loro dipendevano dal Mef e io dalla presidenza del Consiglio. Strettamente parlando non avevamo predecessori».
Non le sembra assurdo che un tema come questo non sia ancora stato risolto?
«Sì e no. A me sembrano troppo alte le remunerazioni degli ambasciatori, loro probabilmente ritengono che i professori universitari, come me, servano a poco o niente. Non ci sono criteri oggettivi. Anche se certe situazioni sono più estreme e assurde di altre. E in alcuni casi i raffronti internazionali parlano chiaro».
Altri enti da eliminare?
«Non ci sono criteri oggettivi. Non c'è una lista condivisa da tutti: se ci fosse sarebbe tutto più semplice. Personalmente trovo difficile trovare una qualsiasi ratio in certi intrecci diabolici di partecipazioni di Comuni o Regioni. Allo stesso tempo alcuni enti a me sembravano non solo inutili ma dannosi, eppure altri avevano idee molto diverse. Sentivo molti dirigenti o funzionari che privatamente ammettevano che l'ente in cui lavoravano aveva miriadi di problemi, ma si guardavano bene dal fare alcunché di tangibile per migliorare la situazione, alcune volte per quieto vivere, altre volte perché non avevano la capacità. E quando qualcuno è intervenuto, spesso ha peggiorato la situazione, perché sottoposto a veti incrociati o anche per mera incompetenza o superficialità. Si pensi alle province: difficile fare una riforma più assurda. A Roma mi divertivo a chiedere a ogni politico che incontravo: “Ma allora le province sono state abolite o no?". Non ne ho mai incontrato uno che sapesse darmi una risposta precisa».
Perché certi enti sono dannosi?
«Perché creano un sottobosco dove si incrociano politica e impresa. Per esempio, molti imprenditori invece di lavorare nell'innovazione perdono il loro tempo a inseguire i soldi dei fondi strutturali europei».
Il caso del Cnel. Un ente che sembra avere sette vite.
«Penso che se venisse obliterato dalla faccia della terra, nessuno se ne accorgerebbe, eccetto chi ci lavora e ci andrebbe di mezzo incolpevolmente, e i suoi membri, molti dei quali si fanno ancora oggi inspiegabilmente vanto di appartenere a un ente obsoleto e ridicolo. Sfido chiunque a citarmi una pubblicazione, un convegno, un evento del Cnel che abbia avuto un qualche impatto. Il Cnel è un residuo preistorico, un fossile ammuffito, uno scandalo. Fortunatamente è uno scandalo molto piccolo, oggi ci costa poche centinaia di migliaia di euro».
Per liquidare un ente c'è un problema burocratico?
«Il problema è a monte: bisogna prima voler liquidare un ente …».