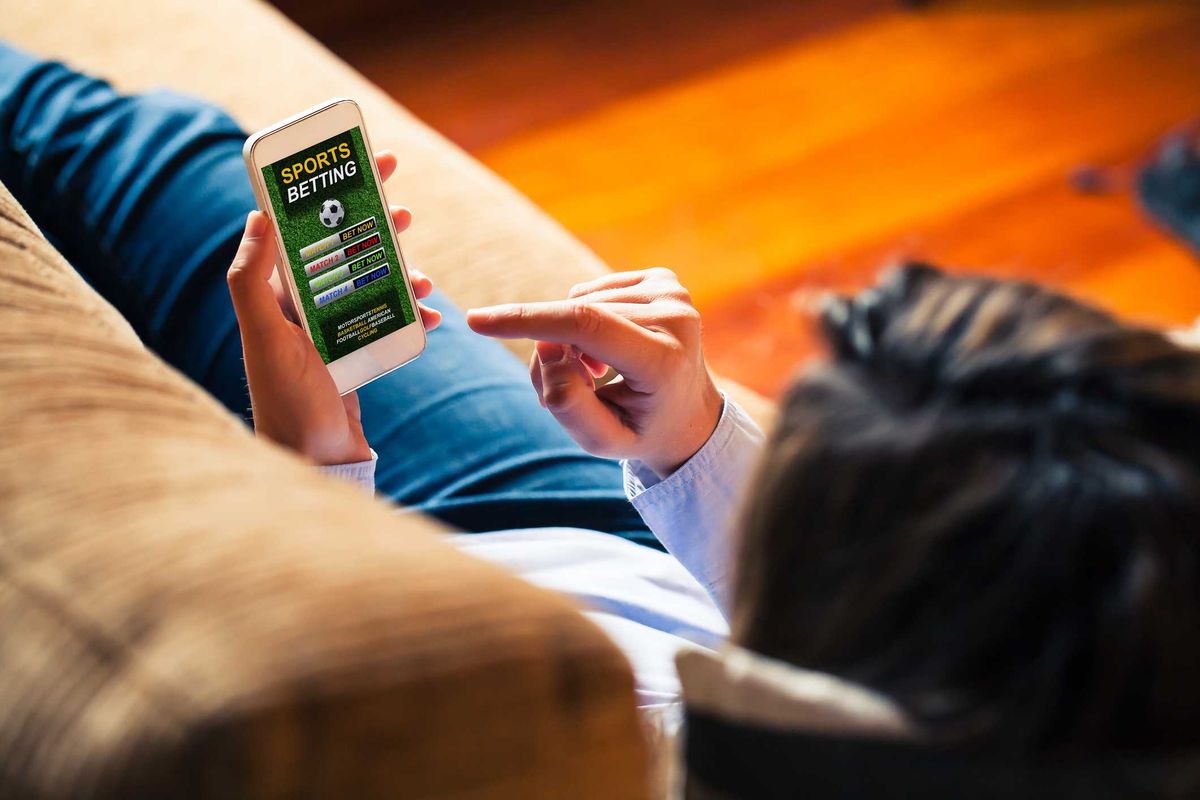Percepito come legato alle storie dei migranti contemporanei, in realtà è un piatto che ha radici lontane. Cibo di scorta per i lunghi viaggi delle tribù nomadi, resistente ai capricci del clima e di facile abbinamento. Protocollato dall'Artusi alla ricetta numero 46.Mediterraneo da sempre crocevia di uomini, civiltà, storie, anche golose. Un esempio, per certi versi inaspettato, il cous cous. Nell'attuale immaginario collettivo è percepito come legato alle storie migranti del terzo millennio, in realtà ha radici lontane, lungo tutta la costa tirrenica, dalla Sicilia alla Sardegna e poi a lenta navigazione più su, con scalo ai porti livornesi e genovesi.L'origine è magrebina, in quel tratto di continente africano che va dal Marocco all'Algeria e Tunisia. Cibo di scorta per i lunghi viaggi delle tribù nomadi perché facile al trasporto, resistente ai capricci del clima, di facile abbinamento con quel che si trovava poi per strada. Per Clifford Wright il termine deriva da kaskasah, che in arabo classico significa «macinare, tritare», termine che rinvia alla sua lavorazione, una delle varianti della lavorazione del grano. Le prime tracce d'archivio nel XVI secolo. Ne parla, nel 1550, Giovanni Battista Ramusio, in un diario di viaggio, ma la descrizione più vivace la da qualche anno dopo Francesco Sansovino «una vivanda la quale si fa come i coriandoli et lo cuociono in certe pignatte forate per ricevere il fumo di altre pignatte». Oramai i tempi sono maturi per il suo sbarco nel continente. Si inizia dalla costa Elima, quel tratto di Sicilia Occidentale che ha Trapani come capitale, estendendosi poi Mazara del vallo, Marsala, come nelle isole, Favignana in primis, ma anche Pantelleria. Galeotti i pescatori che per riempire le loro reti si spingono sino alle coste tunisine. E qui avviene un pacifico scambio di civiltà. Nelle case sulla costa ci si cibava di zuppe di pesce chiamate matalotta, generalmente realizzate con il pesce non commerciabile al mercato. Dai magrebini si scopre che si può arricchire il tutto con un impasto di semola, opportunamente lavorato, che loro abbinavano generalmente alla carne di montone. I pescatori di ritorno al focolare domestico istruiscono le donne di casa a far tesoro di questa scoperta. Il cous cous ha ottime capacità di saziare la fame, se abbinato al pesce meglio, anche perché questi era parte del salario in natura, che si affiancava alla scarsa moneta sonante. Il primo giacimento domestico si sviluppa nel rione Casalicchio, nelle vicinanze della torre di Lingny, estremo avamposto occidentale della città sul mare. Cominciano ad affiancarsi le leggende per dare storia alla nascita di questa nuova scoperta. I più istruiti raccontano che un piatto di cuscusù fu quello che fece risorgere il re Salomone dal mal d'amore verso la principessa di Saba, che lo ignorava. I più romantici che, un giorno, una donna, sulla spiaggia, notò dei grani di una sabbia diversa dal solito. Li assaggiò e ne fece scorta, erano arrivati sulla rena da una nave naufragata al largo. Era il tempo di dare loro dignità tanto che Edmondo De Amicis, nel resoconto di un suo viaggio, li descrive come piatto di principi e di popolo, ma anche del clero, descritto dal cuoco dei papi, Bartolomeo Scappi, come «piatto moresco», ma anche quale omaggio di nozze dei novelli sposi al parroco che li aveva uniti per sempre, come racconta di un matrimonio a Trapani nel 1777 Giuseppe Pitrè «fu lasciata al parroco una pietanza chiamata cuscusu, colla carne di porco, vivanda in Sicilia dai saraceni lasciata». Il sigillo di nobiltà lo pone Alberto Denti di Pirajno, eclettico uomo d'armi e cultura. «Il confronto con quello nordafricano è trionfale per la Sicilia. Quanto là era cibo rozzo e triviale con il grasso di montone che lo imbeve, diventa nel trapanese preparazione che esalta, senza involgarire. Dà sapore e delicato alla semola senza trasformarla né in crema di semolino al sugo di mare, né in pastone ammazzafame». Altra storia, altro couscous, che stavolta all'anagrafe recita Cascà. Siamo a Carloforte, avamposto della Sardegna nel quale si rifugiarono i corallari. Di origine ligure, più precisamente del rione genovese di Pegli, avevano seguito la famiglia dei Lomellini quando, per quegli strani giochi della diplomazia, nel XVI secolo il re tunisino concesse l'isola di Tabarka. Un giacimento di corallo (e di pesce) di cui i nuovi coloni fecero tesoro. Un periodo di splendore che imboccò una crisi agli inizi del Settecento, tanto che, nel 1738, gran parte di queste famiglie prese la rotta del ritorno. In quegli anni re Carlo Emanuele III di Savoia era intento da colonizzare le terre disabitate dei nuraghi. Fu così che nacque, sull'isola degli sparvieri Carloforte, un doppio omaggio, laico, alla corona, e religioso, a san Carlo Borromeo. Qui il cascà si è sviluppato in due declinazioni, quella invernale, con verdure e carne di maiale, e quella della bella stagione, con piselli, fave, carciofi, melanzane fritte a dadini. Talmente entrato nel Dna dei locali da figurare in modi di dire ancora attuali. «te venisci u giurnu de cascà» (se venissi il giorno del cascà), ovvero un modo scherzoso per dire a qualcuno di diradare le sue visite, così come altri. Dalla Sardegna al porto livornese il passo può essere breve ma vi fu un tempo, attorno al XVI secolo, in cui la città del Vernacoliere, fondato da Mario Cardinali (uno dei rari esempi di periodico satirico ancora in circolazione), divenne, assieme ad Amsterdam, la piccola Gerusalemme d'Europa. Qui si rifugiarono, grazie ad una legislazione assai favorevole, tutte quelle famiglie ebraiche in fuga dai territori a dominazione islamica, dall'Andalusia alla Sicilia, la costa magrebina. Fu qui che Pellegrino Artusi, il primo ad aver codificato la cucina nazionale, descrisse il cuscusù, protocollato alla ricetta numero 46. Ospite di una famiglia ebraica lo volle poi riprovare nella sua Firenze. Ecco la diagnosi. «Non è un piatto da grandi feste, ma può piacere anche a chi non ha il palato avvezzo a tali vivande. Della sua legittimità garantisco, ma non di farvela capire». Probabilmente per la notevole complessità della sua lavorazione, con un protocollo che prevede dedizione di una squadra familiare che si applica per qualche ora. Infatti, tornando a Trapani, la prova del nove per una candidata novella sposa, non era tanto quella di saper cucire o cucinare, ma di sapersi destreggiare con la preparazione del cous cous (spesso con la vigile suocera accanto). Ma non tutti la pensavano come l'Artusi. Angelo Orvieto, un poeta fiorentino, fa ritornare l'acquolina in bocca con la sua Ode al cuscussù. «Se pur mi spinge al cuscussù la nostalgia sognante di carovane che procedon lente per le vie d'Oriente… io preparo il diletto rosmarino, ché fiorentino e cresce sul mio poggetto, onde sentor d'Etruria io colgo nel sapore dei deserti». L'approdo finale di questo cous cous italico avviene a Genova, «attracco del nord Europa, dove arrivano e muoiono le culture mediterranee». Se è pur vero che all'ombra della Lanterna (da cui sono partiti i corollari verso Tabarka) domina incontrastato il pesto imperatore, in qualche taverna nostalgica si può ancora trovare lo scuccusù, con agnello, capperi e pinoli. Se Trapani è e rimane la capitale storica del cuscusù, lavorato pazientemente con la mafaradda per provvedere all'incocciatura e alla couscoussiera per procedere con la lunga cottura dove i vapori della parte inferiore avvolgono e impregnano la semola contenuta in quella superiore (i due contenitori avvolti in una sorta di caldo abbraccio dal cudduruni, una sorta di cintura fatta con pasta fresca o un panno di lana per non perdere nessun respiro dei vapori), la capitale mediatica è San Vito lo Capo, dove, dal 1998, si svolge il cous cous Festival, un melting pot di sapori, tradizioni, peccati di gola che portano qui, da tutto il mediterraneo i couscussari e i loro adepti per giorni di festa e di contaminazioni golose.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».