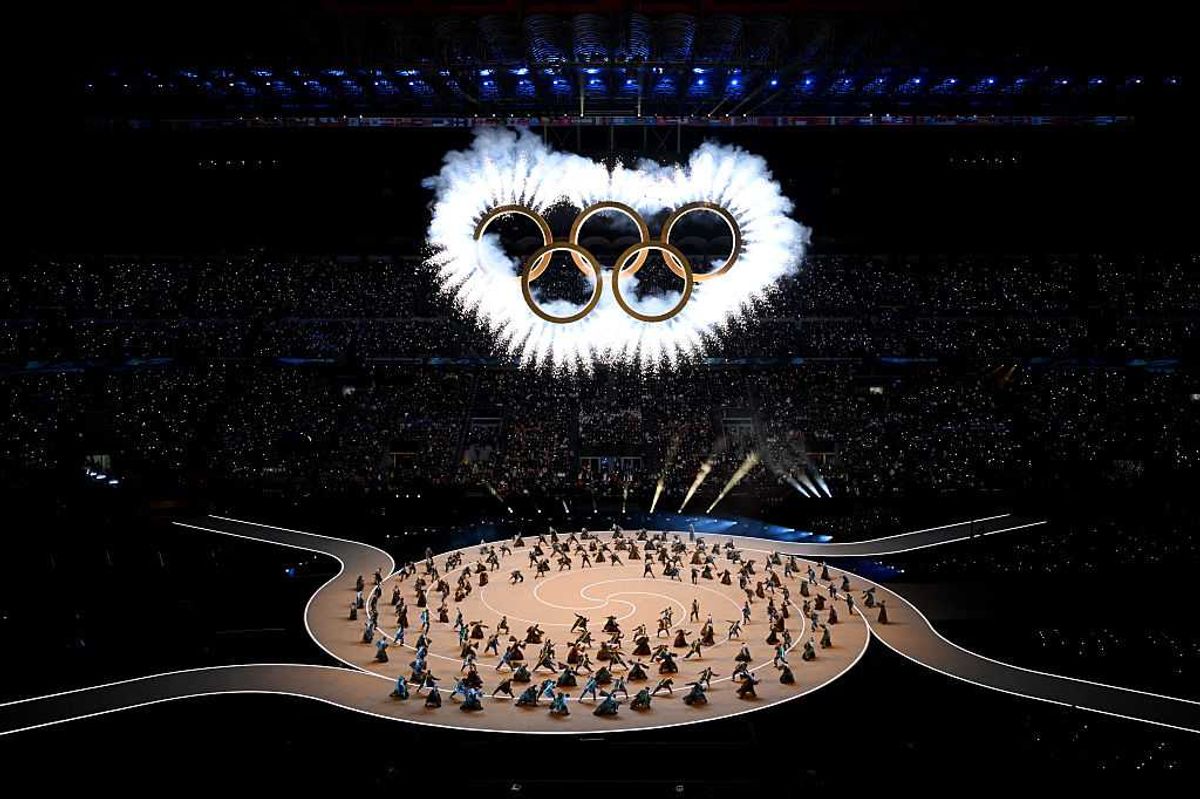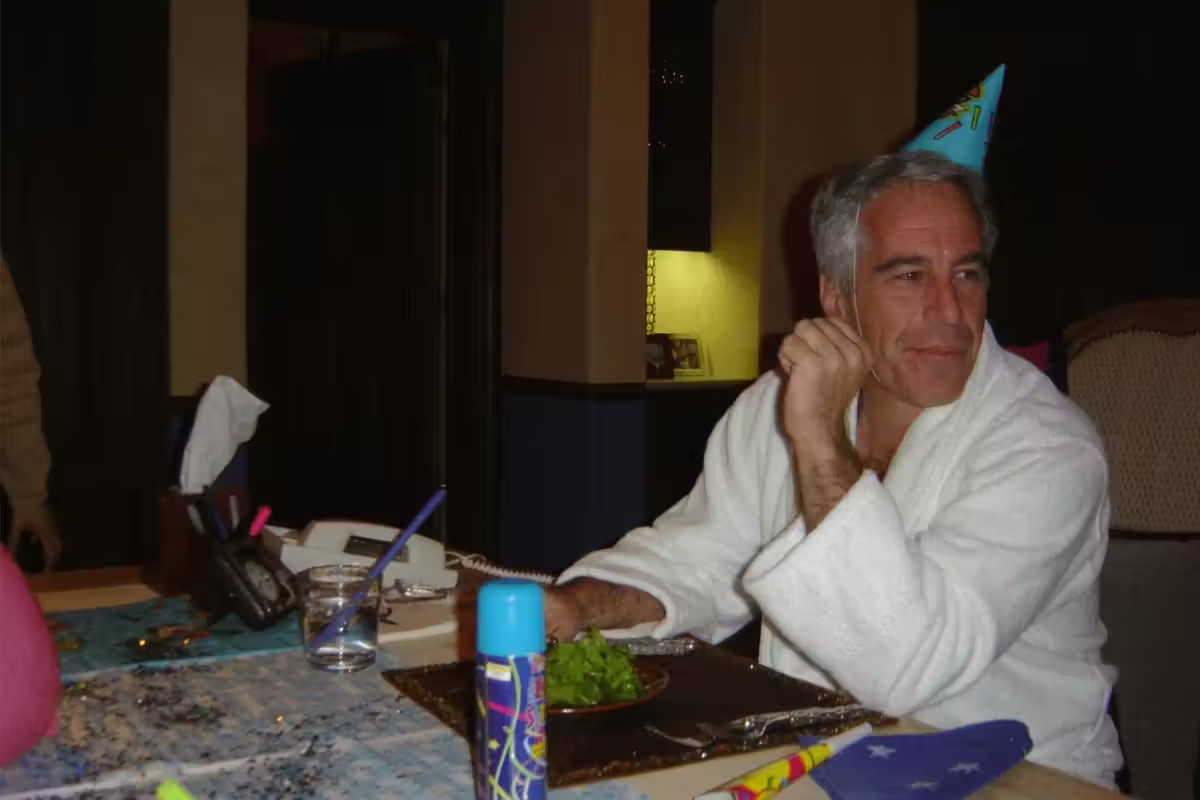Com'è noto, il leit motiv sul quale le Ong basano la loro pretesa di far sbarcare in Italia e, in particolare, a Lampedusa i migranti raccolti in mare è costituito dal richiamo all'obbligo, previsto dalla «legge del mare», di condurli nel più vicino «porto sicuro», da individuarsi - secondo loro - appunto in quello di Lampedusa. Ciò soprattutto perché non potrebbe essere considerato «sicuro» il porto di Tripoli e neppure qualsiasi altro porto dell'Africa settentrionale, a cominciare da quello di Tunisi, dal momento che né la Libia né la Tunisia garantirebbero il rispetto delle Convenzioni internazionali che tutelano i diritti dei migranti e, segnatamente, di quelli che avessero, in ipotesi, titolo per chiedere ed ottenere lo status di rifugiati. In Libia, inoltre, a causa della locale situazione politica, i migranti sarebbero addirittura esposti al pericolo di torture e violenze di ogni genere, proprio per sfuggire alle quali avrebbero tentato di raggiungere, via mare, l'Europa.
Questa argomentazione, però, è del tutto priva di fondamento giuridico. Essa è, infatti, solo il frutto di una consapevole e volontaria distorsione del reale contenuto delle norme invocate, fatta per mascherare il vero scopo delle Ong che non è certo quello, da esse sbandierato, di salvare dei naufraghi (peraltro volontari) altrimenti destinati alla morte, ma piuttosto quello di sottrarli al salvataggio da parte della Guardia costiera libica e così consentire loro la realizzazione dell'obiettivo da essi perseguito, che è quello di raggiungere l'Europa, via Italia, pur non avendone, il più delle volte, alcun diritto. Cominciamo quindi col ricordare che la «legge del mare» è essenzialmente costituita, per quanto qui interessa, dalla Convenzione di Amburgo del 1979 (più nota come Convenzione Sar), integrata dalle linee guida elaborate nel 2004 dall'Imo (International maritime organization). È di fondamentale importanza mettere in luce che l'una e le altre sono state dettate solo ed esclusivamente con riferimento alla situazione di soggetti qualificabili come «naufraghi» e non come «migranti». Ed è solo per tali soggetti, quindi, che è stabilita la regola per cui essi, una volta raccolti, devono essere condotti non esattamente in un porto, ma, più genericamente, in una place of safety, da intendersi come «una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove: la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale». Appare chiaro, dunque, che tra le condizioni richieste perché un luogo o, più specificamente, un porto possa essere considerato sicuro per dei naufraghi non vi è affatto quella che gli stessi, in quanto migranti e non più naufraghi, possano anche fruire, una volta sbarcati, della possibilità di presentare e vedere accolte le eventuali richieste di asilo o protezione internazionale. Questo non significa, naturalmente, che l'esigenza di assicurare, per quanto possibile, tale possibilità, sia necessariamente destinata a rimanere del tutto ignorata. Significa soltanto che di essa non può e non deve occuparsi il comandante della nave soccorritrice, il quale deve invece, di regola, attenersi all'indicazione del luogo sicuro che deve essergli fornita dal governo o da altra autorità dello Stato responsabile della zona Sar in cui è avvenuto il recupero.
Quella che dovrebbe occuparsene è invece la competente autorità dello Stato di bandiera della nave soccorritrice, dal momento che quest'ultima è da considerare, a tutti gli effetti, come territorio del medesimo Stato. Essa e solo essa, quindi, avrebbe titolo per fornire al comandante le opportune istruzioni sul come gestire la situazione dei «migranti». Come pure è la stessa autorità quella che dovrebbe assumersi il compito e la responsabilità di autorizzare il comandante a non attenersi all'indicazione del porto sicuro fornita dallo Stato responsabile della zona Sar, quando ritenga che manchi, in realtà, taluna delle condizioni previste dalle Linee guida Imo, impartendogli, anche in questa ipotesi, le opportune istruzioni.
Nell'uno e nell'altro caso, fra tali istruzioni, potrebbe anche esservi quella di dirigersi verso un porto di uno Stato diverso, a condizione però di aver preventivamente chiesto ed ottenuto il suo consenso. Il che, tuttavia, non comporterebbe affatto, come conseguenza automatica, che quello Stato, e non lo Stato di bandiera, diventi quindi competente per l'accoglienza dei migranti e la trattazione delle eventuali richieste di protezione internazionale. In base, infatti, all'art. 13 del vigente Regolamento europeo n. 604/2013 (che ha sostituito l'originaria Convenzione di Dublino), soltanto nel caso che il richiedente la protezione internazionale abbia «varcato illegalmente» la frontiera terrestre, marittima o aerea di uno Stato, quest'ultimo diventa necessariamente competente all'esame della domanda, con obbligo, quindi, di consentire la presenza del richiedente sul suo territorio fino a che l'esame non sia stato completato. Ma la suddetta condizione sarebbe, con ogni evidenza, mancante qualora i migranti venissero fatti sbarcare a seguito di volontaria e libera adesione dello Stato alla richiesta avanzata da un altro Stato. Quest'ultimo, pertanto, rimarrebbe comunque competente all'esame delle richieste di protezione internazionale, previo accoglimento dei richiedenti, dopo lo sbarco, nel proprio territorio.
In conclusione, dunque, deve escludersi che i comandanti delle navi Ong abbiano titolo alcuno per disattendere, di loro iniziativa, l'indicazione del porto sicuro che ad essi sia stata fornita dalla competente autorità dello Stato responsabile della zona Sar in cui è avvenuto il recupero; e meno che mai può ammettersi che abbiano titolo alcuno per individuare essi stessi il diverso porto al quale dirigersi per poi pretendere di farvi sbarcare le persone soccorse. E ciò senza che si possa, in contrario, far leva sul fatto che la Commissione europea, l'Unhcr o altri organismi internazionali, avrebbero affermato che il porto di Tripoli e, più in generale, tutti i porti del Nord Africa, sarebbero da considerare «non sicuri» e perciò da evitare.
Si tratta, infatti, di prese di posizione frutto di valutazioni puramente politiche alle quali non può quindi attribuirsi la benché minima efficacia vincolante nei confronti tanto dei governi quanto dei comandanti delle navi. Al che sia poi consentito aggiungere, a puro titolo di cronaca, che anche il porto di Tripoli, al pari di tutti gli altri porti del Nord Africa, risulta regolarmente aperto al normale traffico marittimo di merci e passeggeri. Diventa perciò alquanto difficile comprendere come esso possa essere considerato non sicuro per l'accoglienza dei naufraghi, sempre che, naturalmente, per la nozione di sicurezza si faccia doverosamente riferimento a quanto è previsto dalla pur invocata «legge del mare» e non ad altri parametri di valutazione che con essa, come si è visto, non hanno assolutamente nulla a che vedere e sui quali solo le pubbliche autorità dello Stato di bandiera della nave soccorritrice, e non le Ong, hanno titolo ad interloquire.