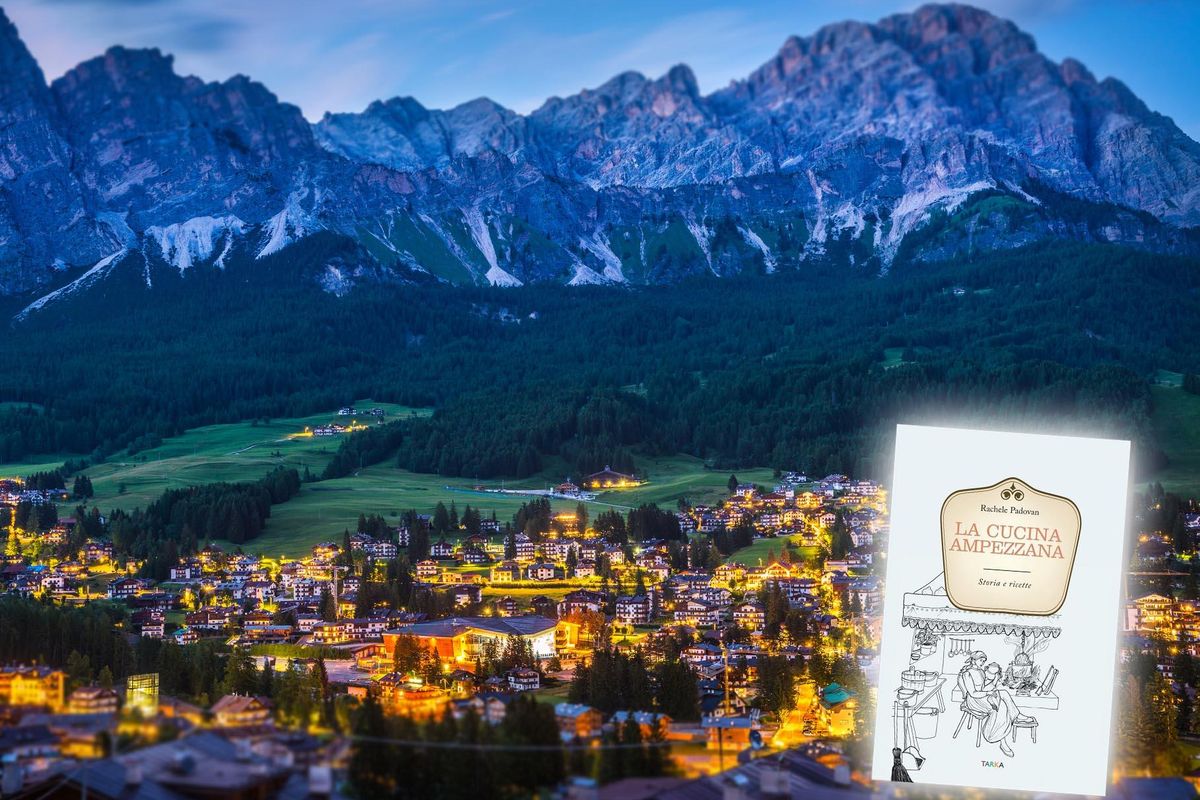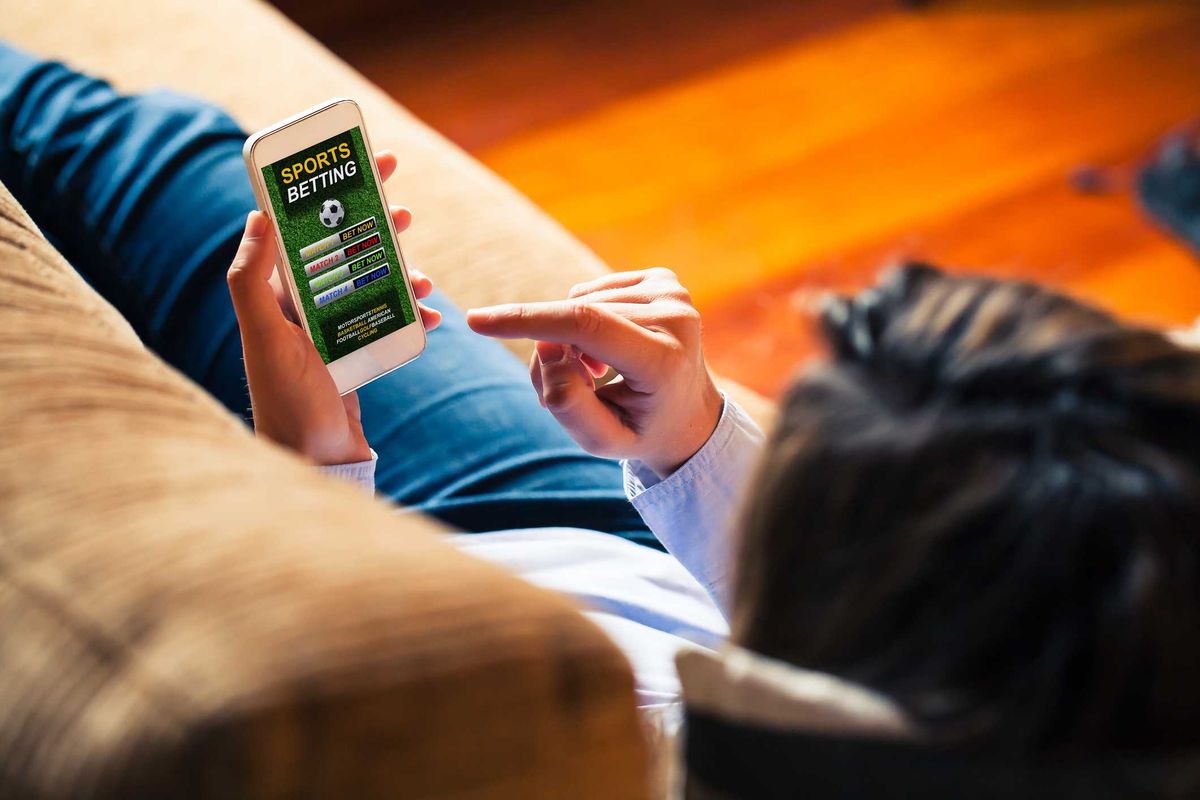2022-09-03
Cortina, come Cenerentola diventò fashion
Cortina D'Ampezzo (IStock)
Cucina di confine tra gastronomia asburgica e tradizione delle montagne venete, quella ampezzana è sempre stata improntata a sobrietà e sostanza, senza fronzoli. Prima di essere la regina delle Dolomiti era un luogo dove fare i conti con sacrificio e impegno.Per tutti è la regina delle Dolomiti, ma forse pochi ricordano che Cortina d’Ampezzo, per secoli, è stata umile Cenerentola. Alcune centinaia di montanari resistenti che facevano tesoro di quanto boschi e pascoli permettevano loro di coltivare e metter da parte per sostenere le famiglie lungo tutto l’anno. Cortina uno dei sestieri, cioè i villaggi, sparsi nella conca d’Ampezzo. Terra di confine tra mondi diversi, posta lungo l’antica strada Alemagna, quella delle tratte commerciali che collegavano il Tirolo asburgico con le vicine terre Serenissime, tanto che, per circa un secolo, tra il 1420 e il 1511, anche i podestà che rappresentavano l’autorità di San Marco poterono bearsi delle bellezze delle Tofane o del Cristallo. Nella realtà quotidiana la prima preoccupazione di un capo famiglia era quella di ottimizzare i raccolti di fieno, cereali e altri prodotti in funzione del terreno di proprietà. Più si saliva in quota più lenta era la crescita e maturazione di quanto si seminava, tanto che il frumento era poco diffuso privilegiando altre varietà più resistenti quali l’orzo o la segala. Anche l’allevamento del bestiame era mirato lungo i pascoli che, invece, erano di proprietà condivisa di tutta la comunità, ossia le regole. I bovini erano funzionali al latte e alle sue lavorazioni per le vacche, mentre i vitelli venivano venduti giù a valle per le loro carni. Con le pecore si lavorava la lana e solo a missione compiuta, dopo molti anni di tosatura, le loro carni venivano valorizzate, ma con parsimonia, contorno della festa, la domenica ad arricchire la consueta minestra d’orzo. Chi poteva permetterselo allevava il maiale, esclusivamente per uso domestico. Il giorno del sacrificio supremo si consumava il sangue, cotto e lavorato con diverse preparazioni, oltre alle immancabili frattaglie: fegato, cuore, polmoni. Non erano molto diffusi gli insaccati, mentre invece tradizione voleva che, grazie alle abili mani di un familiare, il divin porcello venisse scomposto in cinquantadue tagli, uno per ogni settimana dell’anno a venire. Una liturgia di preparazione complessa e paziente. Ben descritta da Rachele Padovan, autentica testimone della sua terra, che ritroveremo più volte in queste narrazioni della tradizione. Infatti il suo libro La Cucina ampezzana, uscito nel 1981, è stato paragonato dal vicentino Neri Pozza, editore e uomo di cultura senza pari, al più celebre Cristoforo di Messisbugo, cuoco al servizio dei signori d’Este che, nel 1549, pubblicò un testo, riccamente illustrato, dedicato ai banchetti in uso nella migliore aristocrazia del tempo. E così fece la Padovan, grazie alla mano felice di Mariuccia Buscicchio, accompagnando i suoi amarcord a disegni che li traducono visivamente. Ebbene, una volta scomposti, i tagli del maiale venivano conciati con sale grosso, spezie e aromi, tra cui le brombe de zenoro, ovvero bacche di ginepro. A questo punto si utilizzava un grande mastello appoggiato su di uno sgabello. Al fondo uno scolatoio da cui, ogni giorno, si scaricava la salamoia che si formava e la si riversava di nuovo sopra le carni messe a frollare. Un rito che si ripeteva per circa due settimane. Dopo di che i tagli e il lardo venivano asciugati, appesi al soffitto e affumicati per un’altra settimana con rami di ginepro. Da qui poi avviati alla fresca cantina in attesa di essere consumati nei mesi a seguire. Il sale era materia preziosa e la comunità ampezzana si era attrezzata a dovere sin dal XIV secolo con un fondaco comune, ovvero un magazzino, dove si custodivano anche sementi e granaglie acquistate all’ingrosso in pianura, mentre il sale proveniva dalle saline di Hall, nei pressi di Innsbruck. Una istituzione benemerita, che restò in funzione fino al 1888. Non solo utile per acquistare all’ingrosso e alle migliori condizioni quanto serviva in valle, ma anche ammortizzatore indispensabile per le gravi carestie che si verificarono ai primi dell’Ottocento, provvedendo alla distribuzione gratuita del grano alle famiglie più bisognose. La cucina ampezzana è sempre stata improntata a sobrietà e sostanza, senza tanti fronzoli. Le donne erano il motore della famiglia. Oltre alle normali funzioni di mogli e madri dovevano provvedere quotidianamente alla stalla e all’orto, per cui non c’era da dedicare tanto tempo alla creatività culinaria. L’alimento base era il pane. Era un blended, con poca farina bianca, molto orzo e segale, e quel tanto di farina gialla di polenta che serviva ad ammortizzare ulteriormente l’equilibrio tra i costi e le necessità alimentari di tutta la brigata. Vi erano undici molini nella conca ampezzana. La farina poi veniva conservata in sacchi di pelle di pecora, foles, deposti dentro dei cassoni di legno. Per ottimizzare al meglio la fertilità del suolo vi era una precisa rotazione delle colture. Si iniziava con l’orzo per passare poi al grano, la fava, e infine le patate, arrivate per ultime anche in ordine temporale, ai primi dell’Ottocento. Per far riposare la terra il campo non veniva più arato per qualche anno, diventando «vara», cioè prato utile per il pascolo. Le donne di casa confezionavano i loro pani, messi a cuocere con tecnica dedicata, entro il fornel, la stufa, con pezzi di legno messi da parte apposta. Nel 1885 aprì bottega il primo pistòr, ovvero fornaio, Massimiliano Apollonio. Inizialmente panificava per le poche locande e osterie, poi iniziarono anche le famiglie, con un protocollo ben codificato. La farina arrivava entro sacchi che avevano il marchio di identità di ciascuno. Bisognava specificare se era già stata lavorata con il sale, in caso contrario il pistor lo aggiungeva con relativo sovraprezzo. Ogni famiglia aveva anche un proprio stampo di ferro che marchiava le forme prima di essere infornate, così non vi era tema di scambio di pagnotte. La filiera familiare era completata dai ragazzini che venivano poi mandati a ritirare l’infornato. Si formavano divertenti cordate di bricconcelli che, correndo verso le rispettive case, non mancavano di scambiarsi qualche pezzetto di pane reciproco, in innocenti sfide golose a chi lo avesse più buono. Apollonio fu un pioniere in valle, tanto che molti giovani di belle speranze si recarono da lui per imparare il mestiere. Pane dal forte valore simbolico, non solo come ingrediente principale delle diete di allora, ma anche in altri contesti. Quando la giovane sposa varcava la soglia della sua nuova famiglia veniva accolta dalla suocera che le offriva una pagnotta con un pizzico di sale accanto. Vi era poi il pan da morto, confezionato per rendere l’estremo saluto ad un familiare mancato. Farina bianca arricchita con cumino. Poteva essere consumato rigorosamente solo dopo aver recitato il rosario. Pane e culto dei morti molto sentito. Forme diverse di pane venivano consegnate in occasione del trigesimo a chi lo voleva ricordare così come forme più piccole, le petuches, venivano espressamente confezionate per i bambini. Una cultura contadina che doveva fare i conti con una realtà quotidiana che richiedeva sacrificio ed impegno, ma sempre affrontati con quell’ironia che diventa buona compagna di vita per chi sa gestirla con realistica saggezza. Come testimoniano alcuni proverbi trasmessi di generazione in generazione nelle notti davanti al larin. «Piuttosto che arare con il bagnato è meglio andare in osteria». «La benedizione dei campi è il letame». Ma anche antica sapienza, a futura memoria «Con la luna crescente si semina quello che cresce sopra la terra, con quella calante quello che cresce sotto la terra».