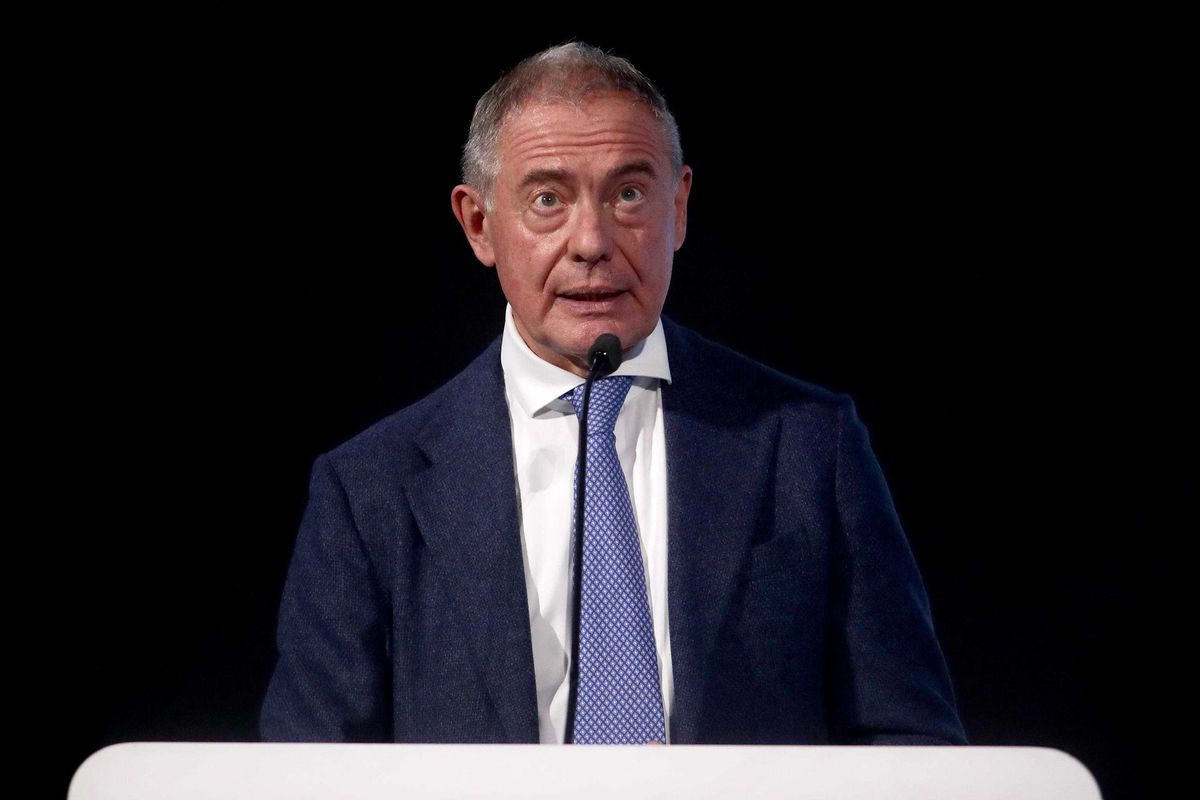2022-06-24
Contro i blitz ideologici della Consulta basterebbe un giudice con coraggio
Il palazzo della Consulta (Imagoeconomica)
Quella sul doppio cognome è solo l’ultima ingerenza discutibile della Corte costituzionale sull’ordinamento. Tuttavia essa non ha il potere di annullare le decisioni giudiziarie che confermino le norme contestate.Pietro Dubolino, Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione Dalli al padre! L’ennesimo colpo alla figura paterna, già oggetto di feroce e sistematica contestazione a far tempo dall’ormai remoto 1968, è stato sferrato recentemente dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 131/2022, depositata il 1 giugno scorso (ma il cui contenuto era stato già anticipato con un comunicato-stampa del 27 aprile), ha dichiarato l’incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza, delle norme che prevedevano l’automatica attribuzione del cognome del padre al figlio nato da genitori uniti in matrimonio o anche da genitori non uniti in matrimonio ma dai quali il figlio fosse stato congiuntamente riconosciuto. Secondo questa sentenza, escluso in ogni caso il suddetto automatismo, «il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». In questo modo la Corte non si è limitata ad espungere dall’ordinamento una norma ritenuta incostituzionale ma si è, di fatto, sostituita al legislatore per creare, al suo posto, una norma del tutto nuova, di sua esclusiva creazione: proprio ciò che nelle precedenti occasioni in cui era stata chiamata ad occuparsi dello stesso problema, aveva escluso di poter fare. In particolare, infatti, con le pronunce nn. 176/1988, 586/1988 e 61/2006, la Corte aveva dichiarato inammissibile la proposta questione di costituzionalità, poiché all’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma vigente si sarebbe dovuta accompagnare la creazione di una nuova disciplina comportante scelte di natura politica da considerare, come tali, di esclusiva competenza del legislatore. Ed anche con la successiva sentenza n. 286/2016 la Corte si era limitata a dichiarare incostituzionale la norma sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nella sola parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di aggiungere al cognome paterno quello materno, fermo restando che, per il resto, non si poteva che rimettersi ad un «intervento legislativo», sia pure postulato come «indifferibile» e «destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità». La palese contraddizione nella quale la Corte è caduta, ritenendo, con la sentenza del 2022, che le fosse consentito fare qualcosa che essa stessa, in precedenza, aveva escluso, trova giustificazione, secondo il mainstream del pensiero progressista, nell’inerzia che, in questa come in altre occasione, il legislatore aveva mostrato a fronte della rappresentata esigenza di un suo intervento. Ma la giustificazione, ad onta dei funambolismi dialettici che anche da autorevoli cattedre vengono escogitati per sostenerla (e che non è qui possibile, per ovvie ragioni, illustrare e confutare), non ha il benché minimo fondamento giuridico. Né la Costituzione, infatti, né le norme che regolano le attribuzioni ed il funzionamento della Corte (in particolare, la legge costituzionale n. 1/1948 e la legge n. 87/1953) prevedono la possibilità, per la stessa Corte, di impartire prescrizioni vincolanti al legislatore. Essa può soltanto, a rigore, riconoscere o escludere la conformità alla Costituzione della norma di legge sottoposta al suo esame, senza in alcun modo poterne ammettere, in caso di ritenuta incostituzionalità, la sopravvivenza «a tempo», in vista di una sua sostituzione ad opera del legislatore. La sentenza della Corte, inoltre, proprio perché contiene valutazioni che, secondo quanto dalla stessa Corte affermato nelle sue precedenti pronunce, le sarebbero state precluse a causa della loro natura politica, si pone in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 28 della citata legge n. 87/1953, per il quale «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento». Vero è che tale norma (peraltro semidimenticata, ma indubbiamente vigente), non è munita di apposita sanzione. Ciò non significa, però, che, a fronte della sua inosservanza, altro non vi sia da fare se non rassegnarsi all’assurdità per cui solo la Corte costituzionale potrebbe debordare a suo piacimento dai limiti che pur le sono espressamente imposti dalla legge, mentre, se a debordare dai propri limiti fosse un qualsiasi altro organo costituzionale, esso finirebbe per trovare, sulla sua strada, in un modo o nell’altro, proprio il controllo esercitato dalla stessa Corte costituzionale. Occorre quindi andare alla ricerca, nelle pieghe del sistema giuridico, di uno strumento mediante il quale tale assurdità possa essere evitata. E lo strumento potrebbe essere trovato considerando che la Corte costituzionale ha sì il potere di dichiarare l’incostituzionalità delle norme sottoposte al suo esame, ma non ha quello di annullare le decisioni giudiziarie che, disattendendo, in ipotesi, una tale declaratoria, proprio perché riconosciuta contraria all’art. 28 della legge n. 87/1953, continuino a fare applicazione di quelle stesse norme. Il che significa che qualora tali decisioni trovassero sistematica conferma da parte della Corte di cassazione, che è e rimane il supremo giudice di legittimità dei provvedimenti emessi dai giudici ordinari, l’effetto della pronuncia di incostituzionalità verrebbe, di fatto, del tutto azzerato. Ma sarebbe ragionevole sperare (o, a seconda delle opinioni, temere) che una tale prospettiva possa realizzarsi? La risposta, almeno allo stato, non può che essere negativa, atteso che la sua realizzazione richiederebbe non solo e non tanto la condivisione delle argomentazioni giuridiche sopra illustrate, ma anche e soprattutto il sovrumano coraggio che sarebbe necessario per fronteggiare il prevedibile fuoco di sbarramento da parte dell’establishment, incondizionatamente favorevole, nella stragrande maggioranza, alla sacralità delle decisioni della Corte costituzionale e tra di esse, in particolare, di quelle che vengano incontro alla aspettative del politicamente corretto.
Ecco #DimmiLaVerità del 4 novembre 2025. Il deputato Manlio Messina commenta la vicenda del Ponte sullo Stretto e la riforma della Giustizia.