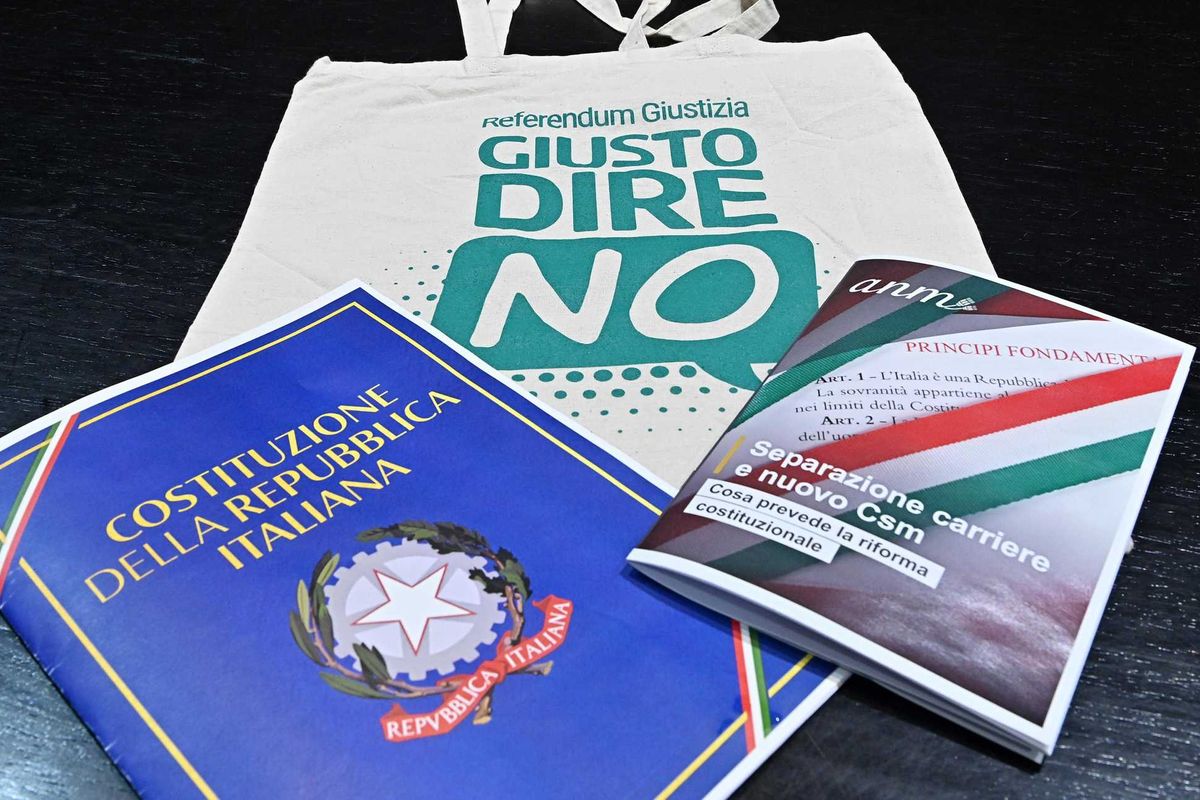Dovevano salvare la nostra economia: pagarci le pensioni, fare i lavori che non vogliamo più fare, aprire nuove aziende come funghi. Parliamo ovviamente degli immigrati, la manna dal cielo per ogni economia in crisi. O almeno così ci hanno detto.
Ora, tuttavia, lo studio «Migranti: la sfida dell'integrazione», degli istituti Cesvi e Ispi, ci spiega, dati alla mano, quello che empiricamente ogni italiano ha sempre saputo, e cioè che l'accoglienza è soprattutto un costo. E diminuire gli sbarchi significa anche risparmiare un bel po' di denaro pubblico. Secondo il rapporto, in particolare, il recente calo degli arrivi ha generato significativi risparmi (ovvero costi evitati) che secondo la stima media si aggirano intorno a un miliardo di euro il primo anno e a 1,9 miliardi all'anno dal 2019 in avanti. Capito? È bastato fare un po' la voce grossa con le Ong e abbiamo risparmiato un miliardo quest'anno e quasi due dal prossimo anno in poi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio
Tra gennaio 2013 e luglio 2018, circa 685.000 stranieri hanno raggiunto le coste italiane via mare attraverso canali irregolari, ovvero più del triplo rispetto ai 220.000 registrati nei dieci anni precedenti (2003-2012). Dal 16 luglio 2017 in poi, tuttavia, gli arrivi si sono drasticamente ridotti, tanto che il periodo 16 luglio-31 dicembre ha fatto registrare un calo del 78% rispetto allo stesso periodo del 2016. Quanto abbiamo risparmiato, evitando che i numeri folli degli arrivi del 2016 si ripetessero? Per capirlo, occorre entrare nel dettaglio della spesa pubblica per singolo immigrato. Lo sappiamo bene: mantenere uno straniero ci costa i famosi «35 euro al giorno», ormai entrati nel gergo politico quotidiano. Le cose, nello specifico, sono un po' più complicate, ovviamente. Ispi e Cesvi calcolano che i costi diretti per singolo migrante, facendo una media ponderata delle spese di ogni regione, peraltro molto differenti tra loro, arrivino a 27,1 euro giornalieri. Insomma, un po' meno dei famosi 35 euro.
Ma questi, per l'appunto, sono i costi diretti. Il costo per fornire servizi sanitari e garantire l'accesso al sistema educativo nazionale ai migranti presenti nelle strutture di accoglienza si attesta invece sugli 8,8 euro al giorno per migrante. Sommandoli al precedente dato, raggiungiamo la cifra di 35,9 euro al giorno per ogni straniero. Ma non è finita. Secondo la Corte dei conti, il processo di valutazione della domanda di asilo costa allo Stato circa 204 euro a pratica. Ecco quindi il riassunto dello studio: «35,9 euro al giorno portano a un costo annuo di 13.104 euro (1.092 euro al mese), cui si sommano i 204 euro per la valutazione della domanda d'asilo, portandoci a 13.308 euro per migrante nel corso di dodici mesi».
Giunti a questa conclusione, non resta che calcolare il risparmio per le casse pubbliche dovuto al mancato arrivo di una quantità di barconi analoga a quella degli anni scorsi. Ispi e Cesvi calcolano il numero di migranti non arrivati in Italia negli ultimi dodici mesi in 140.000 unità. Per calcolare in maniera corretta i risparmi generati dal calo degli sbarchi bisogna però tenere presente che il numero di persone non giunte in Italia rispetto alle previsioni non è cresciuto tutto in una volta, ma è andato progressivamente accumulandosi lungo l'intero arco temporale dei dodici mesi.
Fatti i dovuti calcoli, ecco le conclusioni del rapporto: «Nel caso in cui - in assenza del calo iniziato a luglio 2017 - gli sbarchi in Italia si fossero assestati mese dopo mese sul livello minimo delle previsioni, nel corso di un anno i risparmi sulla spesa pubblica italiana sarebbero stati quantificabili in circa 570 milioni di euro. Se invece si utilizzano le previsioni massime, i risparmi per lo stato italiano superano 1,4 miliardi di euro. Utilizzando la previsione media, infine, i risparmi in spesa pubblica sfiorano il miliardo di euro». Negli anni successivi al primo la stima media del risparmio sfiora i 2 miliardi e, nello scenario massimo, supera i 2,5 miliardi.
In generale, l'impressione è che i veri calcoli circa i costi dell'immigrazione siano ancora tutti da fare. Le Chinatown delle nostre città, per esempio, brulicano di bettole e negozi di chincaglieria. Una grande vitalità imprenditoriale, giudicando astrattamente. Ma chi calcola le perdite dovute al degrado, alla chiusura dei negozi storici, al calo in picchiata dell'offerta qualitativa, all'attività in nero e fuori da ogni regola lavorativa e igienico sanitaria? È solo un esempio terra terra, ma rende bene l'idea.
Nella prefazione allo studio, i dirigenti dei due istituti che hanno realizzato il rapporto, scrivono: «Al diritto alla mobilità umana si affianca il diritto di ciascuno Stato sovrano a regolare i flussi migratori che attraversano i propri confini. Trovare un equilibrio sostenibile tra questi diritti è una sfida per tutti: quello che è certo, comunque, è che ogni Paese dovrebbe ambire a “governare" i processi migratori e non semplicemente subirli». Sacrosanto.
Va però aggiunto che per giungere a tale risultato bisognerebbe evitare di criminalizzare chiunque faccia davvero qualcosa per gestire i flussi. E che se siamo giunti al punto di «subire» gli sbarchi è stato proprio perché, per tutta la prima parte dell'ondata migratoria ancora in corso, la retorica istituzionale dominante è stata quella boldriniana: quella, cioè, del migrante come pura «risorsa», benedizione caduta dal cielo (anzi, venuta dal mare), che avrebbe portato arricchimento materiale e culturale. Non era così. E piano piano lo stanno scoprendo tutti.