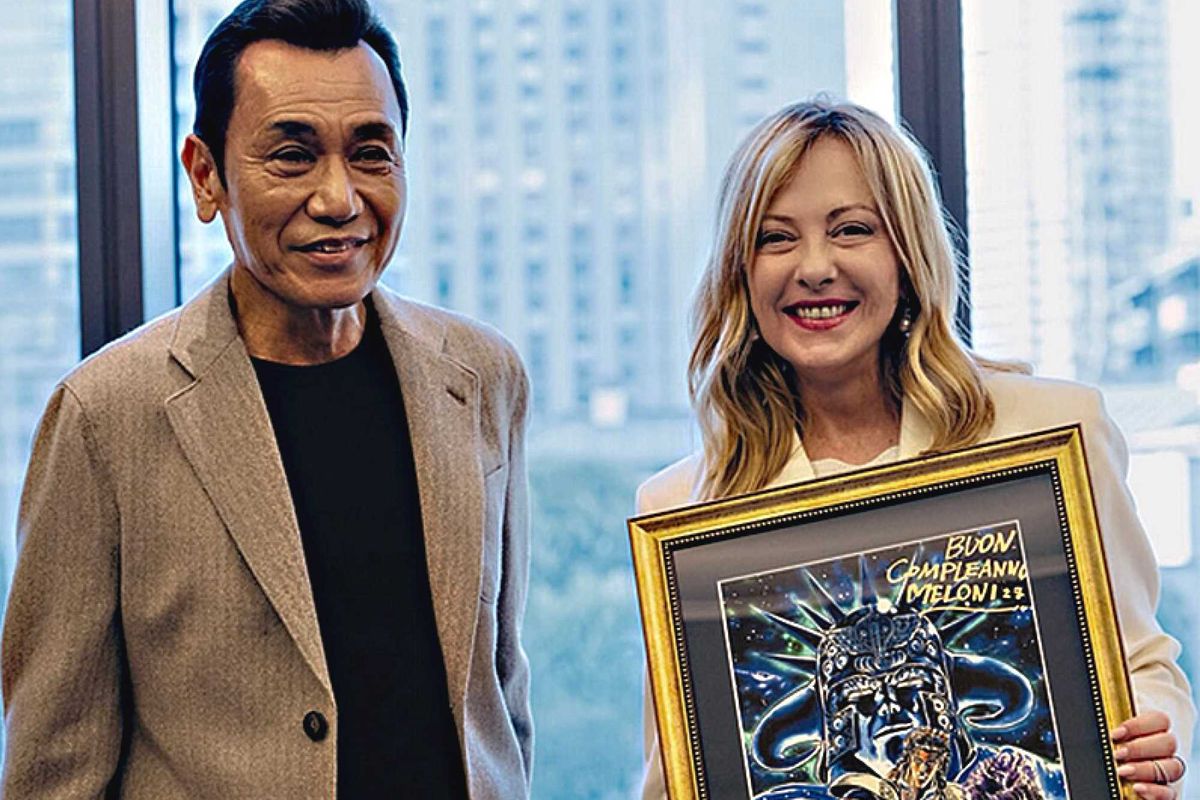Parla come mangi è un saggio consiglio, utile per secoli e finito fuori moda suppergiù alla fine del secolo scorso. Veniva dato a coloro che in casa mangiavano con la regola delle due «s», sano e semplice, ma fuori dimenticavano il palato aggrovigliando la lingua in discorsi tortuosi, imbottiti di ragionamenti fumosi, effetti retorici e vaneggiamenti astratti.
Dopo il Duemila il consiglio non serve più. Oggi la maggior parte della popolazione, soprattutto quella giovanile, parla veramente come mangia. Mastica snack, hamburger, poke con la naturalezza con cui farcisce i dialoghi di «ok». Se girando per i licei, anche quelli classici, o per le università si trova uno studente che al posto dell’«okappa dice» «va bene» oppure «certo», va segnalato al Fai, il Fondo ambientale italiano che si occupa di tutelare il patrimonio naturale e artistico, quindi anche della lingua cesellata da Dante Alighieri, Petrarca, Leopardi e Manzoni, come individuo da proteggere. Se poi se ne sente uno che davanti a una meraviglia della natura se ne esce con un «corbezzoli!» (il punto esclamativo è d’obbligo) al posto del belluino «wow», si allerti subito il Wwf: quello studente va preservato come specie in via di estinzione. Non facciamogli fare la fine del Dodo, l’uccello delle Mauritius che l’uomo ha cancellato dal pianeta quattro secoli fa.
Corbezzoli è un bellissimo quadrisillabo. Scivola sulla lingua fino alle labbra per poi staccare come uno sciatore che si lanci dal trampolino olimpico. Ha un che di rinascimentale, anche se in Toscana, la Regione madre della lingua italiana, si presta a fare da eufemismo ai corbelli, a loro volta sinonimo di una parte anatomica maschile che gira vorticosamente in presenza di persone fastidiose. Come mai una parola così bella e cortese non si usa quasi più? Probabilmente perché ci stiamo dimenticando della pianta cui la parola si riferisce, il corbezzolo, e dei suoi frutti, le corbezzole. La corbezzola è da riscoprire. Somiglia a una ciliegia, ma la rossa buccia è bitorzoluta, coperta da minuscoli brufoli. La polpa, bianco-giallastra, ha un sapore lievemente acidulo, ma fresco, piacevole. Ricorda un po’ quello della fragola. È uno di quei sapori che i nostri nonni conoscevano bene e di cui noi ci stiamo dimenticando.
Le corbezzole sono frutti che nella cucina mediterranea vengono impiegati in molti modi, soprattutto per preparare dolci. Vengono usate per fare marmellate, crude in macedonia e insalata, caramellate, candite, immerse nella grappa e soprattutto nell’aceto per aromatizzarle. Ancora: sono utilizzate nella preparazione di gelati, frullati, torte, cocktail, crostate vegane e biscotti. I gourmet assicurano che le salse preparate con le corbezzole si sposano bene con carni e pesce. Merita un discorso a parte il miele di corbezzolo, chiamato anche miele amaro o amaro di corbezzolo. Un miele amarognolo, aromatico che non è facile trovare anche perché viene prodotto e apprezzato nelle Regioni che si affacciano sul mare: Sardegna, Toscana, Liguria, Marche. Ma anche perché le api bottinatrici incaricate di raccogliere il nettare e il polline dai profumatissimi fiori bianchi che si aprono in novembre, se la stagione è precocemente fredda, se ne stanno rintanate nell’arnia anticipando il riposo invernale.
Non va sottovalutato l’aspetto benefico. Il corbezzolo, nelle sue varie parti, ha proprietà diuretiche, antisettiche, antinfiammatorie delle vie urinarie, biliari e del fegato. I frutti sono ricchi di vitamina C, pectine e antociani, soprattutto betacarotene, che hanno potere antiossidante e contrastano i radicali liberi combattendo lo stress e l’invecchiamento. Le pectine, in particolare, regolarizzano il passaggio intestinale. Con le foglie, infine, si prepara un infuso che ha effetti antispasmodici e antinfiammatori.
Controindicazioni? Essendo ricche di zuccheri, le corbezzole vanno mangiate con giudizio dai diabetici.
Il corbezzolo rappresenta l’Italia, dimenticarlo è come scordare la patria. Non è un albero, è una bandiera grazie ai frutti rossi, i fiori bianchi e le foglie verdi che in autunno si presentano tutti insieme sulla pianta: un tricolore vivo e vegeto davanti al quale i militari dovrebbero mettersi sull’attenti portando la mano al berretto. Teniamoci stretti i corbezzoli che meritano rispetto storico: durante il Risorgimento hanno simboleggiato l’Unità d’Italia. Il Messico nella bandiera ha il fico d’India sacro agli Aztechi? L’Italia, nella fascia bianca del tricolore potrebbe mettere un ramo di corbezzolo.
Giovanni Pascoli cantò il corbezzolo nell’ode omonima raccontando in versi a rima alternata come la pianta dai tre colori fiorì sulla tomba di Pallante, alleato di Enea nella guerra contro Turno, considerato dal poeta il primo martire caduto per la libertà dell’Italia: «Il tricolore!... E il vecchio Fauno irsuto/ del Palatino lo chiamava a nome,/ alto piangendo, il primo eroe caduto/ delle tre Rome». Virgilio nell’Eneide fa presente l’usanza di depositare rami di corbezzolo sulle tombe. Ovidio nei Fasti racconta che Proca, futuro re di Alba Longa, quand’era neonato stava per essere vampirizzato, nel sonno, dalle Strigi, malvage creature con le ali. A salvarlo dai denti di quegli uccellacci demoniaci fu Carna la dea protettrice dei neonati e dei cardini delle porte: usando un ramo di corbezzolo toccò la porta della camera trasformandola in una sorta di camera blindata. Forse è per questa leggenda che a lungo si è creduto che porti fortuna tenere appeso in casa un ramoscello di corbezzolo con tre frutti capace di scacciare negatività e gli spiriti maligni. È una pianta che resiste perfino agli incendi. La sua capacità di rinascere dal fuoco simboleggia l’eternità e personifica l’eroismo e la volontà di non piegarsi alle sciagure.
L’Arbutus unedo, questo il nome scientifico, appartiene alla famiglia delle Ericaceae. La parola unedo deriva da due parole latine: unum, uno, edo, mangio. La dobbiamo a Plinio il Vecchio che, a quanto pare, non gradiva il sapore del frutto e confessò di averne mangiato uno solo. Il corbezzolo è conosciuto con un altro bellissimo nome: albatro. Deriva dal latino arbutus, corbezzolo appunto, e suggerisce il mare e il volo degli uccelli marini. Il frutto è chiamato anche ciliegia marina. Dal che si capisce quanto l’alberello adori il clima e la macchia mediterranea. In ogni parte d’Italia dove cresce, troviamo il corbezzolo con un nome dialettale corrispondente. Tra i più curiosi: cucummaràra, armurin, lallarone, cerasa marina, sorbola pilosa e, legati alla capacità delle corbezzole di ubriacare se messe a fermentare, ’mbrijachèlle ’mbriachitte, ‘mbriachedd, ‘mbriacula. Si fa anche un vino chiamato vino di corbezzolo. Ed ecco perché era una pianta cara a Bacco, il dio del vino e di tutte le bevande inebrianti.
Come detto, vicino alle coste cresce rigoglioso. Tanto che i greci, che 24 secoli fa colonizzarono quello che adesso è il territorio di Ancona, battezzarono kòmaros, monte corbezzolo, il promontorio che si fa largo, sgomitando, tra le onde dell’Adriatico: il Cònero. Il monte è ancor oggi ricco di corbezzoli. Ancona e il corbezzolo sono indissolubilmente legati. Nello stemma della città è raffigurato un braccio nudo che regge una fronda di corbezzolo con due bacche. L’arbutus è presente anche nello stemma di una grande capitale europea: Madrid. Nello scudo coronato si vede un’orsa che allunga le zampe verso le rosse corbezzole. Nel Prado c’è il dipinto Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch chiamato pintura del madroño, ossia «dipinto del corbezzolo» per i frutti rossi seminati nel giardino.