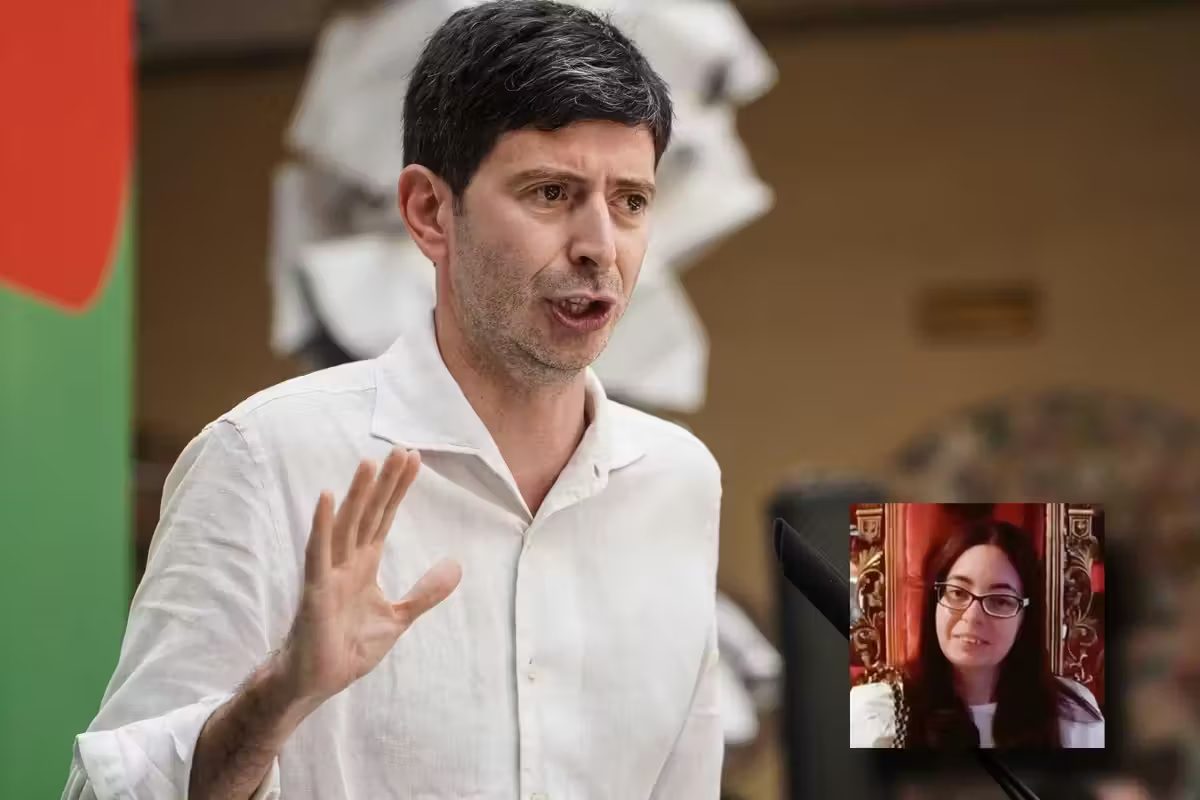È stato, per certi versi, il primo grande ambasciatore della cucina italiana all’estero. Un genio eclettico ben descritto da Luigi Veronelli: «Se fosse nato in Francia avrebbe vie e monumenti dedicati come è capitato ad Auguste Escoffier», mentre invece lo scorrere rapido della modernità lo ha esiliato in una sorta di limbo, il suo nome divenuto «un’entità astratta», presente tuttalpiù negli archivi della memoria di chi ne ha sentito parlare a suo tempo, magari sbirciando nella biblioteca di cucina delle madri o delle nonne di casa. Eppure quella di Luigi Carnacina è una storia che va oltre la sua apparente dimensione professionale, ovvero culinaria, rappresentando quell’ideale percorso di ascensore sociale che ha premiato talento e volontà di chi, ogni giorno, cercava di affrancarsi dalla povertà diffusa dell’Italia di un tempo.
Nasce a Roma il 2 settembre del 1888, primo di cinque figli. Un’infanzia apparentemente serena, crescendo in quella via Veneto che doveva ancora diventare simbolo della felliniana dolce vita. Andava a caccia di lumache nei dintorni dei Parioli per recarsi poi a trovare il papà che, al tempo, gestiva il rinomato Cafè Chantant. Un sogno che giunse presto al tramonto con scenari che lo costrinsero, in breve tempo, a doversi costruire un futuro con le sue sole forze.
Costretto a chiudere la propria attività, il padre, per mantenere la famiglia, ripiegò come portiere notturno di un alberghetto. La mamma si diede da fare per trovare un lavoro al «Giggetto» in calzoncini corti. Dapprima come strillone a un’edicola, poi come garzone in una fabbrica di scopette e, ancora, in una rilegatoria anche se, segretamente, considerata la sua dote di piccolo cantore, la mamma lo sognava in abito talare, amato parroco delle famiglie di quartiere. Il destino continua a infierire sul piccolo Luigi.
Ancora dodicenne, nel giro di sei mesi, perde entrambi i genitori. Si trova con i quattro fratellini più piccoli «bisognosi di cure, di affetto e di pane». Una sfida improba, ma bisogna venirne fuori. Strillone mancato, diventa «camerieretto» nell’osteria di un amico del papà nei pressi della stazione Termini. La sfida continua, ogni giorno, dalle prime luci del mattino fino a sera. Deve pulire di ramazza le sale occupate dai vetturini, i taxisti di allora, che bighellonavano in attesa dei clienti. «Non mi risparmiavano né frizzi, né motti, se non ricoprirmi di insulti per un mio piccolo ritardo o involontarie piccole disattenzioni».
Ma lui aveva già la corazza che si stava consolidando, anche perché la sera, prima di abbassare la serranda, il proprietario gli permetteva di portare a casa degli avanzi, tra pane, minestre e poco altro, per riempire le scodelle dei fratelli. Giggetto non demorde e sfida la sveglia mattutina. Si alza ancora prima del servizio e va a lezione da un curioso personaggio del tempo, che lui chiamava professore, per imparare il francese, la lingua dominante di allora. La sera, prima di tornare a casa, quando poteva, si fermava davanti alle finestre di un rinomato albergo nei dintorni per osservare rapito «quei camerieri in marsina alle prese con clienti di riguardo». Mai mettere limite a inseguire i sogni ed è così che il quattordicenne Carnacina prende il treno, varca le Alpi e va in terra germanica.
In pochi anni, girando l’Europa, da tenace autodidatta è in grado di dialogare anche in inglese e tedesco. Poliglotta senza laurea, non è da tutti. Nel 1917 Luigi Carnacina decide che è ora di tornare in patria, in forma più o meno stabile. «Avevo imparato a ubbidire e comandare e il mio nome iniziava ad avere qualche risonanza». Non è più il camerieretto in calzoni corti di cui si prendevano gioco i vetturini, ma l’esperienza all’estero aveva consolidato una innata sensibilità per la qualità di un servizio che poteva fare la differenza e, se con il marchio del made in Italy, ancor meglio. «Il cliente è l’anima della propaganda», e quindi tutta la struttura di accoglienza, che sia albergo o ristorante, deve sapersi modulare sui desideri e le curiosità del potenziale cliente che ne diventerà poi automaticamente ambasciatore se si sarà trovato bene «anche se è fisiologico uno zoccolo duro del 5%», gente che non si potrebbe accontentare mai, a prescindere.
Il Carnacina che poi diventerà maître di fama internazionale sta affinando le armi. Se in sala contano cordialità e gentilezza, in cucina ci vuole abilità e professionalità conseguente, anche perché la miglior sala non potrà mai compensare le carenze di pignatta e dintorni. E qui entrano in gioco le qualità richieste a un cuoco di talento. Deve essere un tecnico, che conosce il potere nutritivo e la valorizzazione degli alimenti. Un economista, per gestire con equilibrio risorse disponibili e risultati conseguenti. Un artista, che sa applicare al meglio fantasia e buon gusto. Il tocco in più, quello che fa la differenza, la sinergia tra il maître di sala, il ruolo di Carnacina e la cucina. Maître e cuoco devono saper dialogare al meglio perché sarà il primo a diventare, poi, ambasciatore (e narratore) al tavolo del cliente del meglio che esce dalla cucina stessa. Debutta in grande stile presso l’hotel che allora era tra le mete preferite dell’élite dell’epoca. Carnacina non era il solito maître di sala, ma aveva una marcia in più. Conosceva la cucina, anche se non la praticava ai fornelli, e iniziava, memore anche delle sue esperienze internazionali, a elaborare delle ricette con le quali si confrontava poi con i cuochi.
Nasce così l’idea del baccalà al raggio di sole. Un successo che si inserì tra i piatti del buon ritorno non solo tra gli appassionati di dieta ittica, ma anche tra i carnivori impenitenti. In sostanza: del baccalà impanato e fritto passato al forno su di un letto di cipolla, trito di filetti di acciughe, capperi, pinoli e uvetta sultanina. Una sfida alla dominante cucina transalpina, come si usava nei locali d’alto bordo, perfettamente tradotta al piatto dal compagno di ventura, il bravo Francesco Lanzi. Piatto calamita, che attirava palati curiosi da altre insegne di solido blasone tanto che il maître più noto del tempo a Roma, Annibale Balbi, un maestro per il giovane Giggetto, un giorno lo apostrofò con fare inusualmente poco cordiale. «Ma mi spieghi perché la clientela viene da te e non più da me?». «Cavalier Balbi, lei ha mai fatto il cameriere da osteria?». «No». Era tutta qua la sostanza, tanto che alcuni anni dopo, a un Carnacina dalla fama oramai consolidata, il maestro ebbe l’onestà di riconoscere all’ex allievo «avevi pienamente ragione nel fare piatti all’italiana e di fantasia. Mi ci sono convinto con il tempo, e prendo atto, ogni giorno, dei risultati».
Nonostante i palpabili successi la strada era ancora in salita, con tornanti imprevisti. Di vario genere. Un giorno trova al suo tavolo Ciro Capozzi, un napoletano che, nella regia Montecarlo, aveva fondato «Ciro’s», in breve tempo divenuto leggenda. Aveva da poco ceduto la sua creatura, ma desiderava che la qualità che lui aveva creato rimanesse solida e, allora, vede nel giovane Luigi degno testimone. Gli apre scenari stellati, ma a una condizione: per qualche tempo deve accettare di scendere di grado, vice maître. Il diniego è conseguente: oramai teneva famiglia e l’allontanarsi da Roma, scendendo di grado, non sembrava attrattiva sufficiente, pur se la destinazione era Montecarlo. Il destino era dietro l’angolo, galeotta una tirata d’orecchi dell’invidioso direttore d’albergo che lo redarguì ingrato: «Noi abbiamo bisogno di un maître e non di un ballerino tra i tavoli come lei».
La svolta della vita. L’ennesima. Luigi Carnacina fa le valigie e va a Montecarlo, dove conoscerà il maestro che gli cambierà la vita, per sempre: Auguste Escoffier.