«Persegue i peccati invece dei reati. Il magistrato di lotta deve sparire»
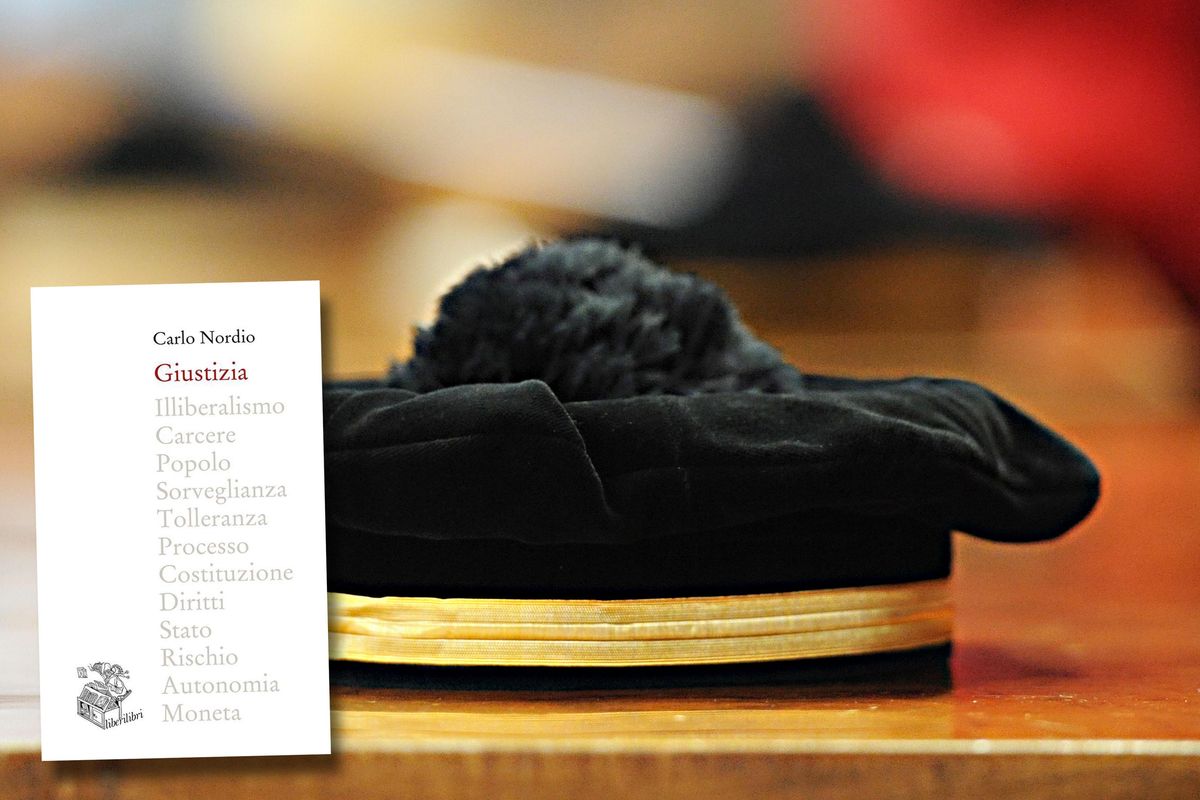
Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, un estratto del libro di Carlo Nordio, Giustizia (Liberilibri). Un viaggio storico-filosofico attraverso l’evoluzione del concetto di giustizia nel corso dei secoli.
Alla dissoluzione confusionaria dell’impianto normativo ha peraltro contribuito, aggravandola, l’intervento sulla scena di un protagonista che, nella sua attitudine sacerdotale e apocalittica, ha imbastardito la razionalità della giustizia. Recependo i connotati più bigotti del retribuzionismo, esso ha ammonito i potenti con la veemenza polemica degli antichi profeti: è il cosiddetto magistrato etico. Non un accorto giurista preoccupato di applicare la legge, ma un temperamento oracolare animato da una stizzita attitudine pedagogica.
Esso rappresenta la figura più perniciosa, e per certi aspetti più caricaturale, dello Stato di diritto: soprattutto quando si converte in magistrato di lotta. Non è un fenomeno nuovo. Ma è un fenomeno incompatibile con la divisone dei poteri, consustanziale a una democrazia liberale. [...] Le norme che definiscono i delitti, e quelle che disciplinano il modo di accertarne la colpa sono dettate dal legislatore; che può essere un sovrano assoluto, com’è ancor oggi il sommo Pontefice, o un’assemblea eletta dal popolo, com’era fino a poco tempo fa l’Unione Sovietica. Due esempi che già dimostrano come, in linea di principio, non esistano sistemi migliori o peggiori. Dipende dalla loro attuazione concreta. [...]
Un affermato luogo comune vuole che l’Inquisizione fosse il più severo di tali sistemi, ma non è proprio così. A modo suo essa aveva un’austera e rigorosa solennità, appena temperata dall’insistenza molesta con la quale si voleva convincere il «paziente» che la sua confessione sarebbe stata salutare per l’anima sua. Al contrario, il tribunale popolare di Parigi, durante la Rivoluzione francese, aveva una struttura estremamente garantista: una netta separazione tra giudice e accusatore; una giuria popolare, un difensore, un dibattimento pubblico, orale e, come si dice oggi, trasparente. Ciò non gli impedì di mandare al patibolo migliaia di innocenti, a cominciare da Maria Antonietta per finire con lo stesso grande accusatore: Fouquier-Tinville, che aveva appunto chiesto e ottenuto di ghigliottinare tanti disgraziati. Non era un delinquente. Era semplicemente un fanatico.
Tanto il tribunale dell’Inquisizione quanto quello rivoluzionario, apparentemente incompatibili, avevano in comune una cosa: miravano all’affermazione della giustizia etica o, come si dice, della giustizia sostanziale. Si proponevano, in altre parole, di attuare, per via giudiziaria, l’affermazione di principi religiosi o politici attraverso l’eliminazione fisica dei dissidenti. Ponendo come postulato un ideale, intendevano perseguirlo processando l’eretico. E poiché l’eresia è un concetto relativo, in quanto rappresenta la deviazione dall’ideologia dominante, il tribunale religioso bruciava gli atei e quello laico decapitava i religiosi. [...] L’evoluzione dei tempi ha portato al perfezionamento dei sistemi: alla soppressione fisica dell’eretico si è aggiunta, o sostituita, un’opzione più raffinata: quella di isolare l’avversario, rendendolo odioso all’opinione pubblica, alla propria chiesa e infine a se stesso. [...]
Per fortuna quei tempi sono passati, e oggi, almeno nel mondo occidentale, rimangono uno sgradevole ricordo. Ma servono come esempio, sia pure esasperato e crudele, della deformazione della giustizia, o meglio del processo penale, quando il magistrato diventa interprete delle istanze che provengono dal di fuori: possono essere politiche, sociali, culturali, religiose o anche vagamente moralizzatrici. Ma la conseguenza è sempre la stessa: chi amministra la giustizia identifica in se stesso lo strumento per la realizzazione di un valore. [...] La logica perversa di una simile spirale porta il giudice ad autolegittimarsi come garante non delle regole, ma di valori sostanziali e a osservare con sospetto, e talvolta con ostilità, chiunque tenti di riportarlo sulla via della ragione. Questi magistrati non sono affatto in mala fede. [...] Li accomuna la consolidata certezza della loro missione salvifica, che mira all’affermazione della giustizia sostanziale.
Ciò è l’accertamento della verità cosiddetta reale: non quella più modesta, insoddisfacente e amara che emerge dalle carte; ma quella storica. Quella oggettiva. [...]
La giustizia umana mira a verificare se un fatto sia accaduto oppure no; se sia stato commesso da Tizio, oppure da Caio, oppure da uno sconosciuto; se sia stato commesso con intenzione, o per imprudenza, o per puro accidente. Se ci perdessimo nelle divagazioni speculative della teoria della conoscenza, i tribunali, e non solo i tribunali, dovrebbero chiudere. È dunque comprensibile che, da un punto di vista etico ed emotivo, si cerchi il colpevole a tutti i costi, anche forzando le regole del gioco. Ma non lo è affatto dal punto di vista logico e giuridico, perché quelle regole servono proprio a evitare lo sconfinamento delle buone intenzioni.
Dato e concesso che gli strumenti di conoscenza sono precari e ingannevoli, le regole, necessariamente imperfette come la natura umana, servono a stabilire criteri omogenei per ricostruire gli eventi, tutelando la collettività nei confronti dei malandrini e gli individui nei confronti dell’autorità. La quale non è un’entità astratta munita di una metafisica investitura di infallibilità, ma è rappresentata da uomini soggetti a pregiudizi ed errori. [...] E la saggezza del magistrato sta proprio nell’adeguarsi a queste regole anche quando si rivelano insufficienti ad attuare la giustizia, proprio perché non esiste giustizia al di fuori delle regole.
Ecco perché, nel processo penale, nulla è più pericoloso della ricerca della cosiddetta verità sostanziale, quella cioè di cui si ha la certezza logica, ma che manca di conforto probatorio. Il processo deve assicurare il rispetto dei suoi canoni, costi quel che costi. L’alternativa è la giustizia privata: perché se lo Stato è il primo ad essere inadempiente al cospetto delle sue autolimitazioni, altrettanto è tentato di fare il cittadino quando il suo debitore è moroso, o il suo aggressore resta impunito.
All’esaltazione oracolare del cosiddetto magistrato etico, monopolista di una virtù integrale, fa paradossalmente riscontro il conflitto tra le frammentate competenze del nostro ordinamento. Un esempio significativo di questa débacle è costituita dal conflitto sorto poco tempo fa tra il Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno di giudici e pm, e il Consiglio di Stato, suprema giurisdizione amministrativa. Quest’ultimo aveva dichiarato illegittime le nomine sia del presidente della Cassazione sia della sua vice, nomine sorrette da una motivazione «irragionevole e gravemente carente»; un giudizio drastico, e quasi offensivo, perché si trattava di un conflitto tra organi essenziali del nostro sistema. [...] Il paradosso è che il Csm dovrebbe godere di una sorta di supremazia, vista la sua rilevanza costituzionale e la sua prestigiosa composizione. Ma così non è. I suoi provvedimenti sono atti amministrativi, come tali impugnabili al Tar e successivamente al Consiglio di Stato. [...] In teoria il giudizio sulla loro validità dovrebbe limitarsi alla cosiddetta illegittimità, ma in pratica si estende al merito, cioè al loro contenuto. Nel caso in esame, definendo «irragionevole» la motivazione delle due nomine, il massimo organo della giurisdizione amministrativa ha rivolto al Csm le stesse censure espresse in varie altre occasioni.
Di fronte a conflitti così insanabili, che sconfinano nella zuffa, il cittadino è un vaso di terracotta tra due martelli demolitivi, e soffre impotente di un’incertezza del diritto che si converte inevitabilmente in sopruso.






