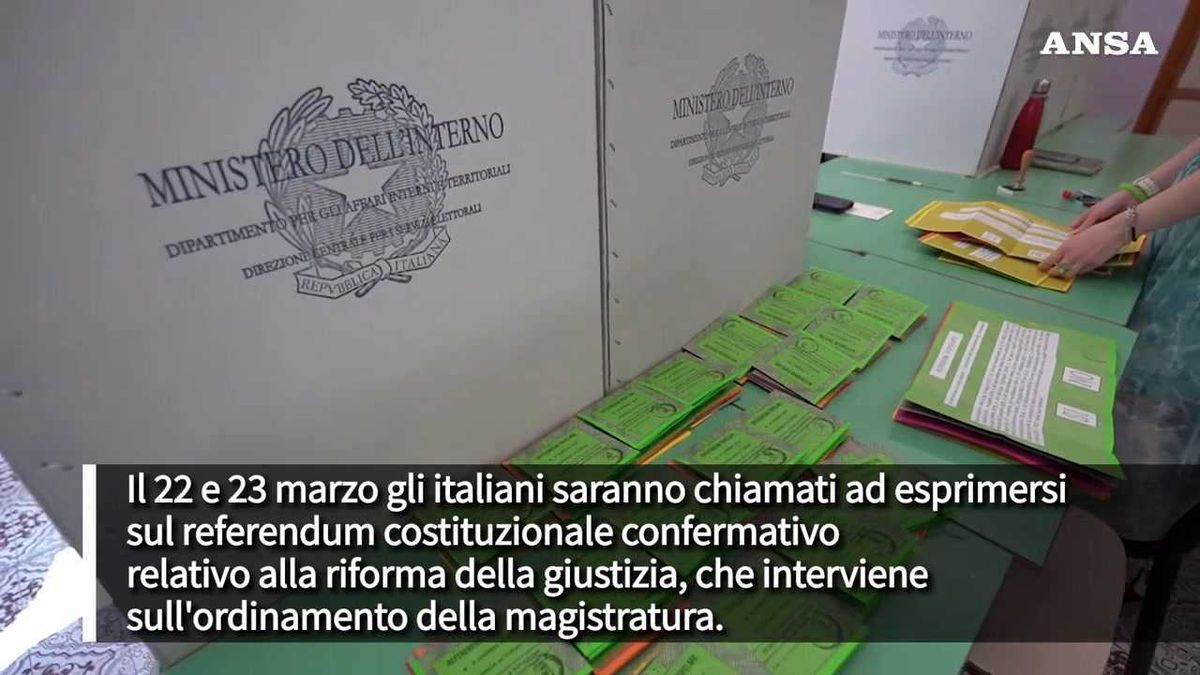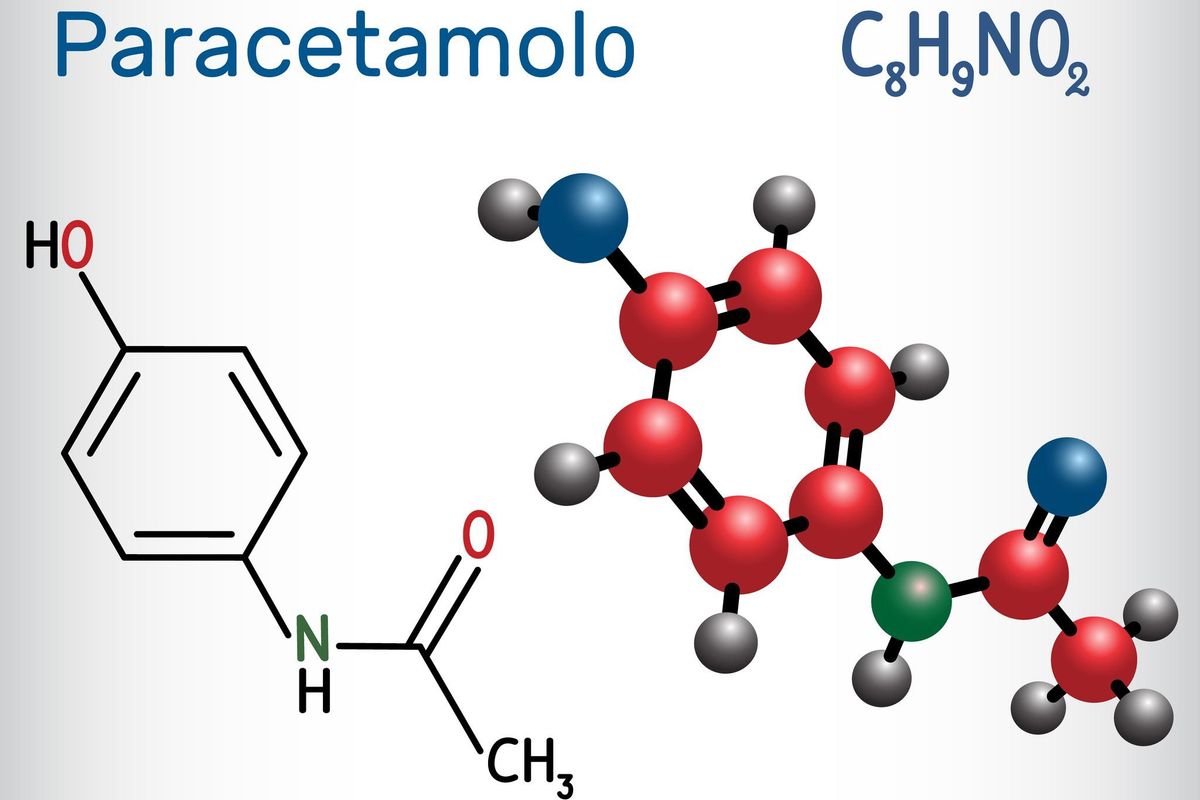
Quando nel marzo 2020, in piena pandemia, l’India bloccò l’esportazione del paracetamolo, venne fuori tutta la fragilità dell’Unione europea. Ci si rendeva conto per la prima volta che la catena della fornitura dei medicinali era ormai pericolosamente fuori dal recinto europeo. Oggi, a distanza di quasi due anni, ci troviamo nella stessa difficoltà, senza che nulla sia cambiato.
Nei primi mesi del 2022, infatti, il report dell’Aifa prevede una carenza di farmaci a base di paracetamolo per due case farmaceutiche che si occupano di generici. In questo caso si tratta del dosaggio per adulti. Al contrario di quanto è successo in pandemia, la carenza non dipenderà da un blocco alle esportazioni, ma da problemi produttivi di non specificata origine. Il sospetto è che si tratti degli stessi problemi che si stanno avendo in tutti i settori e che derivano dall’ingolfamento della supply chain.
Il paracetamolo è un farmaco largamente utilizzato perché molto efficace e tollerabile. Come per altri farmaci, però, è composto da principi attivi che sono gestiti principalmente in Asia. Secondo un rapporto del Center for infectious disease research and policy, dell’università del Minnesota, la Cina produce quasi il 100% dei principi attivi utilizzati nella penicillina, nel paracetamolo e più di due terzi dei principi attivi di altri farmaci molto diffusi come gli antidiabetici, altri antibiotici carenti in questi mesi come l’amoxicillina e la claritromicina, gli antiipertensivi e gli antiretrovirali.
Non solo Cina, ma anche India. Le aziende asiatiche con una manodopera a basso costo e una regolamentazione ambientale meno stringente, producono farmaci non coperti da brevetto, conosciuti anche come generici, che arrivano al consumatore con un prezzo più basso rispetto a quelli di marca. È per questo che le aziende farmaceutiche per massimizzare il profitto si approvvigionano sul mercato asiatico. Ma come funziona tutta la catena della fornitura? Nelle fabbriche cinesi ogni giorno viene prodotta un’enorme quantità di sostanze chimiche che, una volta lavorate, divengono i principi attivi dei nostri farmaci di uso comune. Questi poi percorrono migliaia di chilometri, via terra o via mare per raggiungere le case farmaceutiche europee dove il prodotto viene confezionato e distribuito. Un tempo il primo produttore mondiale era proprio l’Europa, ma i vantaggi della bassa manodopera, dell’economia di scala e della scarsa regolamentazione ambientale in Asia, hanno fatto in modo che la manifattura si delocalizzasse quasi completamente ad Est. Infatti, secondo un report di Progenerika, tra il 2000 e il 2020, i produttori asiatici sono passati dal detenere 183 a 2.369 Cep (certificati di idoneità farmaceutica europea), mentre i produttori europei partendo da 348 Cep sono arrivati solo a 1.260. Una crescita decisamente meno sostenuta. Sempre secondo lo studio tedesco, la concentrazione di principi attivi in India e Cina può avere un impatto negativo sulla continuità dell’approvvigionamento nel caso in cui sopraggiungano sconvolgimenti, come in effetti sta avvenendo in questo periodo storico.
Non solo, la produzione in Cina ha portato diversi problemi anche sulla qualità del prodotto finito. È il caso della contaminazione dell’eparina avvenuta nel 2007 da parte di produttori cinesi che, per tagliare i costi, avevano optato per ingredienti più economici. L’adulterazione del prodotto ha portato gravi conseguenze a molti pazienti, in alcuni casi al decesso. Nel 2018, invece, l’Ema ritirò dal mercato il Valtarsan, medicinale generico per la pressione sanguigna. Fu riscontrato l’Ndma1 nel principio attivo prodotto da una fabbrica cinese, un’impurità cancerogena per l’uomo.
L’Italia intende sconfiggere il problema delle carenze principalmente tramite l’autorizzazione all’importazione dall’estero, non vedendo o non volendo vedere che si tratta di un problema globale. Anche in Francia, solo per fare un esempio, esiste un grosso problema di carenza di medicinali. In questi giorni la loro agenzia del farmaco, l’Ansm, ha inserito nella lista delle carenze il Clamoxil, un antibiotico ad ampio spettro a base di amoxicillina, lo stesso tipo che risulta carente anche in Italia.
La situazione è talmente seria che i francesi hanno previsto per legge che le aziende debbano disporre di una scorta minima di sicurezza destinata al mercato francese. Per i medicinali di grande interesse terapeutico (inseriti dalle autorità in una lista specifica) dovranno coprire i due mesi di fornitura, un mese per i farmaci che contribuiscono alla salute pubblica secondo il ministro della Salute francese e infine di una settimana per tutti gli altri. Insomma «prima i francesi», poi ci si penserà.
La crisi delle materie prime sta toccando tutti i settori, ma mentre in alcuni campi si sta facendo il possibile per slegarsi dalle dipendenze dei monopolisti, in altri settori si fa più fatica. L’Europa pensava di aver fatto un affare delocalizzando le produzioni più inquinanti e a minor valore aggiunto in Cina, mantenendo tutti i vantaggi della produzione a valle. Oggi ci rendiamo conto che tutto questo ha un prezzo e che a pagarlo, troppo spesso, sono solo i consumatori finali. Il Wall Street Journal si chiede cosa succederebbe se la Cina tagliasse gli accessi a tutto ciò che produce in regime di quasi monopolio: terre rare, semiconduttori o principi attivi farmaceutici. Nessuno è in grado di rispondere, perché si ha timore che avverrebbe l’apocalisse, mentre quello che viviamo oggi è solo un piccolo assaggio.