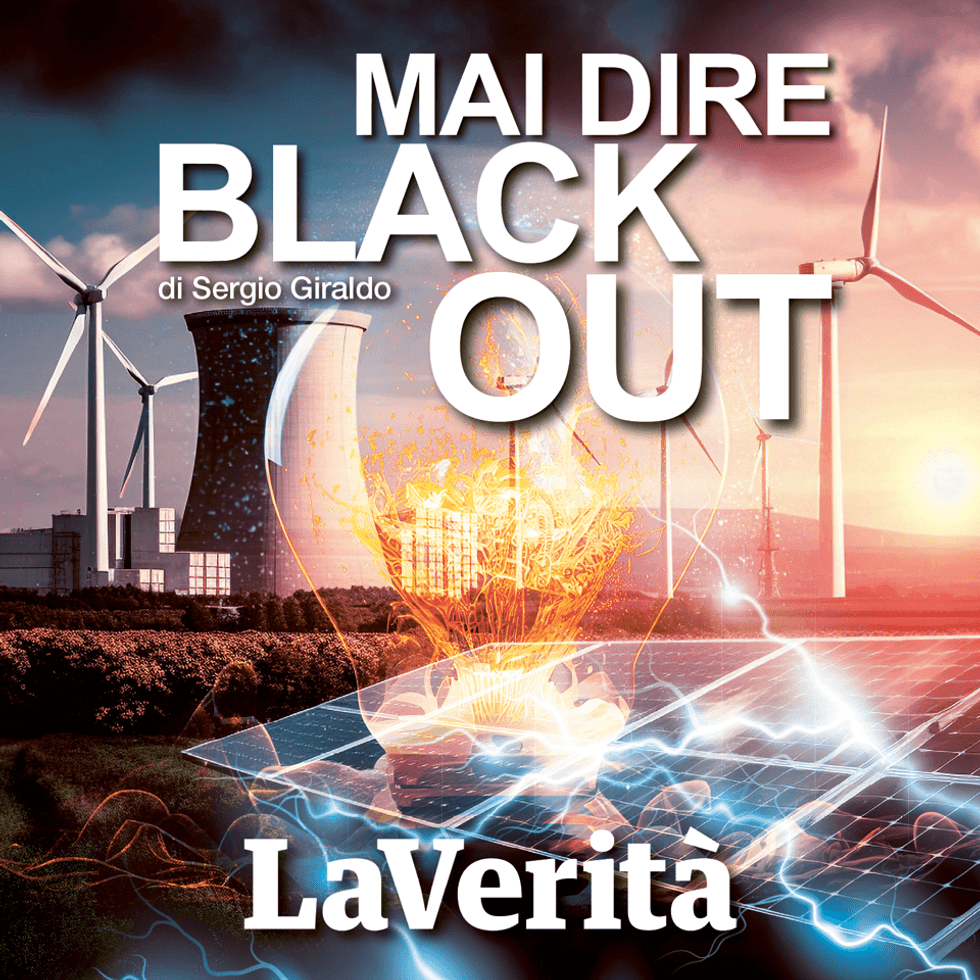Buoni pasto. «Grano a chi vigila sulla grana!» L'ultima guerra dei dirigenti di Bankitalia

I dirigenti di Bankitalia chiedono buoni pasto spendibili anche all'estero
La lettera è arrivata nelle mani del presidente del Cida (il sindacato dei dirigenti della Banca d'Italia) Edoardo Schwarzenberg, nella prima settimana di maggio. A firmarla per delega del direttore generale è stato Luigi Managò, caposervizio logistica della banca centrale italiana.
Ed è venuto il segnale atteso: l'istituto guidato da Ignazio Visco si farà in quattro per venire incontro al dramma che stavano vivendo i dirigenti Bankitalia: da tempo stavano lavorando da remoto, magari cogliendo l'occasione per farlo dalla seconda casa al mare o in montagna. Ma lì non sempre erano utilizzabili i buoni pasto contrattualmente dovuti perché spendibili solo nella Regione di residenza.
I dirigenti avevano esigenze anche più larghe, visto che nella lettera inviata ai vertici dal presidente del Cida il 22 febbraio scorso si premetteva che «l’accordo sul lavoro ibrido prevede la corresponsione del buono pasto per ciascuno dei giorni nei quali la prestazione lavorativa è resa da remoto, modalità questa che- come noto- non prescrive che il dipendente operi da un luogo specifico, potendo addirittura lavorare dall'estero».
Come non averci pensato prima che uno di questo top manager di Bankitalia magari la casa al mare ce l'aveva a Saint-Tropez e quella in montagna a Sankt Moritz, e in nessuno dei due casi avrebbero mai accettato i buoni pasto forniti attraverso un regolare appalto della Consip?
Sono problemi, e bisogna applicarsi senza dubbio per arrivare a una soluzione: mica si può fare mancare il grano così all'improvviso a chi deve vigilare sulla grana di tutti gli italiani. Non c'è proprio riconoscenza. Però i dirigenti della banca hanno teso una mano comprendendo le difficoltà in questo momento di reperire buoni pasto internazionalmente validi. Pace per Saint-Tropez, ma almeno si capisca l'incoerenza del fatto «che i buoni pasto in erogazione siano ancora limitati nell'utilizzo alla regione (o all'area territoriale) nella quale il dipendente è incardinato, dovendosi invece necessariamente prevedere la possibilità di utilizzo in tutto il territorio nazionale».
Vogliamo farli usare anche nella masseria in Puglia, nelle vicinanze della villetta sul Monte Argentario o a Cortina indipendentemente dalla stagione? I collaboratori di Visco hanno preso un po’ di tempo per rispondere e altro ce ne vorrà per esaudire in pratica, ma alla fine i benedetti buoni pasto spendibili nella casa vacanze arriveranno, sia pure cercando di fare il meno danno possibile alle casse di Bankitalia: «È stata condotta una analisi delle criticità segnalate», scrive infatti Managò, aggiungendo che «gli esiti di tale analisi sono in corso di approfondimento con le strutture interessate, anche per valutare i conseguenti aggravi operativi connessi con l'adozione di nuove modalità di distribuzione dei buoni».
Dietro questa corrispondenza, che mai potreste rintracciare nel settore privato dove i dirigenti si vergognerebbero pure di chiedere i buoni pasto alla loro azienda, c’è in realtà un braccio di ferro che dura ormai da due anni fra i vertici della banca centrale e quasi tutti i sindacati dei dipendenti. Perché questi ultimi dopo avere storto il naso sullo smart working (e ottenuto primi in Italia un bonus da 100 euro per quel motivo), se ne sono poi innamorati e ogni volta insorgono quando la banca chiede il rientro in presenza. In teoria dal primo aprile scorso avrebbero dovuto tutti rientrare in sede, abbandonando quelle “sedute ergonomiche” che avevano ottenuto per stare a casa dalla banca e che ancora si lamentava non fossero arrivate a tutti.
Ma alla fine la banca ha ceduto alle richieste sindacali immaginando un piano di smart working al di là delle emergenze con presenza in ufficio ridotta. È stato ribattezzato «lavoro ibrido» in un accordo sindacale del dicembre scorso e prevede che solo una piccola percentuale lavori in presenza che per tutti gli altri sarà alternata a un «lavoro da remoto diffuso e ampio». C’è però una condizione posta sia pure in via sperimentale dai vertici Bankitalia: chi lavora in presenza ha diritto al suo ufficio in genere singolo, con la sua scrivania, la sua cassettiera, il suo piccolo armadio dove conservare i documenti oltre a tutte le attrezzature informatiche previste.
Chi invece lavorerà essenzialmente a casa dovrà di volta in volta per il rientro in ufficio prenotare la sua postazione lavoro. Niente scrivania personale, niente armadietto, niente cassettiera. Però ambienti avveniristici (ci sono anche alcuni disegni in bozzetto con poltroncine per una chiacchiera protette da un cactus fonoassorbente, tavoli dove lavorare con il proprio pc e consumare anche un pasto veloce) per rendere piacevole quel tuffo in ufficio, prenotando di volta in volta postazioni di tutto attrezzate meno di una cosa: il personal computer.
Quello, assegnato a ogni dipendente, dovrebbe essere utilizzato sia a casa che in ufficio con il piccolo disagio di doverselo portare nel tragitto magari a spalle in uno zainetto. Cosa che è diventata un dramma. Per capirlo basta citare passaggi dei comunicati sindacali piovuti sull'argomento. Eccone uno del Sibc che profetizza per questo viaggio con pc casa-ufficio addirittura l'aggravio di «sedute fisioterapiche» per i poveri dipendenti chiedendo un intervento dei medici competenti della Banca di Italia: «A parte i profili di sicurezza connessi con il trasporto pubblico, infatti qualcuno ha mai effettuato una analisi sugli effetti a medio e lungo termine del trasporto di un computer di quasi due chili per magari due ore al giorno?
Se sì, ci piacerebbe poterne leggere i contenuti. Se no, come viene giustificata questa dimenticanza?». La Uil Bankitalia ammette che «il pc non pesa come lo zaino del soldato», ma aggiunge: «Ricordiamo però che non è del tutto peregrina l'ipotesi di essere rapinati o derubati durante i tragitti casa-lavoro-casa, con un aumento esponenziale del rischio al moltiplicarsi dei viaggi...».
Drammoni, quelli del buono-pasto-vacanza del pc che pesa sulle spalle di 6.629 dipendenti - di cui 3.532 in area manageriale e alte professionalità - in cerca di autore e di funzione, viste che le più importanti sono state perdute negli anni e trasferite alla Bce. Ma non sembra essere questa la loro preoccupazione.
Non si può ancora parlare di scampato pericolo, ma la netta presa di posizione di Giorgia Meloni intacca di sicuro le ambizioni degli eurosaggi, che predicano il superamento del requisito dell’unanimità nel Consiglio Ue. «Non sono d’accordo», ha detto il premier nell’intervista a Bloomberg uscita l’altro ieri. «Non credo che sia quella la soluzione, particolarmente non sulla politica estera, che è uno degli elementi fondamentali della sovranità degli Stati».
Il presidente del Consiglio ha ben chiari quali sono i paletti da fissare alle competenze dell’Unione: «Penso che l’Europa possa più agilmente superare la sua lentezza occupandosi di meno cose, facendolo molto meglio». Profondità del pensiero strategico, oppure semplice senso di realtà. Ma è esattamente questa la formula che ci consentirebbe di uscire da certe grottesche contorsioni: mentre qualcuno bofonchia di «ora dell’Europa», i fatti dimostrano che l’Europa è sempre dieci passi indietro, irrilevante in tutte le partite globali che contano. E - il che è peggio - votata a un masochismo oltranzista, sulla transizione ecologica come sulla reazione ai dazi, che ci sta trascinando verso accordi commerciali raffazzonati e insidiosi.
Fare meno, farlo meglio. Mettere in comune poche materie di importanza cruciale, liberandosi dall’ossessione di legiferare su tutto, che ha reso l’Ue malata cronica della patologia diagnosticata da un aforisma di ispirazione reaganiana: se qualcosa si muove, tassalo; se si muove ancora, regolamentalo; se non si muove più, sussidialo.
«Continuo a credere», ha spiegato la Meloni alla testata americana, «nell’unico principio dell’Unione europea che non è stato realmente costruito, che è il principio della sussidiarietà, cioè non si occupi Bruxelles di quello che Roma può fare meglio, non si occupi Roma da sola di quello che non può fare da sola e per cui ha bisogno di Bruxelles». Il premier segnala, pertanto, che abolire il diritto di veto non è sufficiente a garantire rapidità e qualità delle decisioni dell’Ue, in assenza di un radicale cambiamento della filosofia sulla quale si è basato il suo incompleto e maldestro progetto di integrazione. Archiviare l’unanimità non sarebbe «così risolutivo», ha osservato la Meloni, «rispetto a una dinamica […] nella quale c’è anche, diciamoci la verità, una burocrazia molto, molto, molto invasiva. Molto invasiva anche rispetto alle scelte della politica, perché vedo delle decisioni che vengono prese e poi vengono rallentate da una burocrazia che delle volte sembra avere una propria agenda». Mettere a dieta il Leviatano, peraltro, è uno degli elementi chiave dell’asse con la Germania di Friedrich Merz.
Pure qui, il pragmatismo la fa da padrone: in un contesto in cui sono le cancellerie a orientare l’operato della Commissione, la prospettiva è di sostituire, nel motore europeo, la componente francese con quella italiana, approfittando dell’agonia politica di Emmanuel Macron. Nondimeno, sollecitata da Bloomberg sugli attriti con Parigi, l’inquilina di Palazzo Chigi ha preferito minimizzare, rinfacciando ai media di descrivere i rapporti «con alcuni leader» «in maniera un po’ infantile». Invece, «Italia e Francia sono due grandi nazioni europee che condividono moltissimo, che lavorano insieme su moltissimi dossier e che non sono d’accordo su alcune cose». Conclusione: il vertice intergovernativo, saltato all’indomani della polemica per i commenti del premier sull’uccisione dell’attivista di destra transalpino, Quentin Deranque, ma ufficialmente rinviato «per una questione logistica», si terrà «prima dell’estate».
Se la Meloni non può archiviare la cooperazione con i francesi, sembra evidente che abbia spedito in soffitta il piano di Mario Draghi, l’eforo che fa coppia con Enrico Letta e che invoca da mesi la soppressione del criterio dell’unanimità. Paradossalmente, rimane uno spiraglio per il lodo Prodi: «Chi decide va avanti e gli altri si arrangino», aveva suggerito alla Stampa il Professore. Fintantoché ciò dovesse equivalere al meccanismo della cooperazione rafforzata - la procedura prevista dall’articolo 20 del Trattato sull’Unione europea, che permette a un gruppo di almeno nove Stati membri di collaborare in assenza di un accordo a 27 - la Meloni non si tirerebbe indietro.
Il punto è che, dinanzi a interessi nazionali divergenti, l’unanimità svolge la funzione di un pulsante d’emergenza che, di quando in quando, chiunque può avere necessità di premere.
È vero che se troppi galli cantano, non si fa mai giorno. Ma è vero pure che a nessuno conviene vivere in una fattoria in cui tutti gli animali sono uguali, però alcuni sono più uguali degli altri.
L’uomo zombie (sul divano con il reddito di cittadinanza sul conto corrente) era il sogno di Beppe Grillo. L’uomo senza coscienza, annullato dall’Intelligenza artificiale, è il costante incubo di papa Leone XIV. L’uomo sostituito dall’algoritmo è lo spunto più interessante dell’intervista del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bloomberg.
Da qualunque angolo la si osservi, la rivoluzione digitale portata al suo estremo dissimula la trappola della marginalizzazione dell’essere umano. Un problema che sorge nella Londra della prima rivoluzione industriale, passa attraverso le fabbriche disumanizzate di Metropolis, precipita nelle aberrazioni ideologiche marxiste, sembra risolto con l’equilibrio fra diritti e doveri nella seconda parte del secolo breve. Ma rispunta, carsico, al culmine del terziario avanzato con la resa dei conti attuale: cervello umano o microchip?
Per il premier Meloni «il rischio è che milioni di persone siano espulse dal mercato del lavoro, e non perché sostituite dalle macchine nel lavoro fisico che servì ad aiutare l’uomo ad elevarsi. Ma perché sostituite nel lavoro intellettuale, quello dei professionisti». Quello di oggi e di domani, con un corto circuito imminente nella società dei consumi senza più il denaro in tasca per consumare. Ci avviciniamo alla resa dei conti. Ed è ancora una volta la realtà a sorpassare le teorie da convegno. Dario Amodei, ceo di Anthropic (creatore dei modelli Claude, secondo lui non disumanizzanti), aveva lanciato un ulteriore allarme: nei prossimi cinque anni «i sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero interrompere o eliminare fino al 50% dei posti di lavoro entry level nel mondo forense, con un impatto significativo sulla professione degli avvocati». Se è bene che gli studenti di Giurisprudenza facciano un pensierino alle prospettive a breve termine, ancora più significativa è la notizia che arriva dal Belgio: l’operatore di telecomunicazioni Proximus ha annunciato che procederà a tagli di personale nell’ambito di una strategia di riduzione dei costi guidata dall’intelligenza artificiale. Proximus taglierà 1.200 posti di lavoro entro il 2030 a causa di misure legate all’Ia, pari al 15% della sua forza lavoro. L’ad Stijn Bijnens ha annunciato che «l’azienda mira a ridurre i costi della forza lavoro esterna di 25 milioni entro il 2028, nell’ambito di un più ampio programma di efficienza da 180 milioni di euro, trainato principalmente dal risparmio sul personale».
È il cuore del problema, via gli uomini e pure in fretta. Prima i collaboratori esterni, poi i consulenti, infine una quota di dipendenti. Una strategia che presuppone l’implementazione dell’algoritmo al potere, ritenuta una strada obbligata per continuare a distribuire dividendi agli azionisti, impegnati a moltiplicare i patrimoni e a giocare a golf. Proximus ha infatti annunciato nello stesso contesto di essere pronta a investire 1,25 miliardi in infrastrutture. L’annuncio ha avuto due prevedibili reazioni: il taglio dei dividendi oggi per tornare a scendere nei prossimi anni e il crollo in Borsa (-20%), ritenuto dagli esperti «emotivo», nella certezza che il gruppo - una volta chiusa la stagione degli esuberi - tornerà all’età dell’oro grazie all’Ia.
È la fotografia di una realtà in evoluzione rapidissima, che coinvolge quasi tutti i settori dei servizi. Block (ex Square) del guru in bermuda Jack Dorsey ha annunciato il licenziamento di circa 4.000 dipendenti (una parte significativa della sua forza lavoro) a inizio 2026, con l’obiettivo di diventare un’azienda «più piccola, più veloce e nativa dell’Ia», sfruttando i guadagni di produttività dell’algoritmo, che non ha pretese, rivendicazioni sindacali, ferie pagate. Amazon ha confermato tagli massicci (circa 30.000 posizioni corporate entro il 2026); Jeff Bezos chiama il piano «riduzione degli strati», manco si trattasse di una torta con meno ingredienti. La compagnia telefonica inglese Bt Group ha potato 55.000 posti di lavoro e ha annunciato con orgoglio «di volare in Borsa». Così anche Ibm e Duolingo. Il colosso assicurativo Accenture ha licenziato circa 11.000 dipendenti, citando il potenziale dell’Ia per automatizzare il lavoro. Meta ha mandato a casa centinaia di dipendenti in vari dipartimenti, inclusi curiosamente quelli legati alle infrastrutture Ia: neppure gli ingegneri servono più, l’importante è efficientare. L’esempio principale rimane la fintech svedese Klarna, che ha ridotto la sua forza lavoro del 40% tra il 2022 e il 2024 per investire nell’Ia. Con una conseguenza che resta una speranza: è stata costretta a riassumere personale in carne ed ossa «a causa di un calo della qualità dei servizi».
Mentre tutto ciò accade, la politica è ferma e i sindacati pensano alla Flotilla o all’allarme democratico. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, che già al G7 di due anni fa volle un focus dedicato: «La politica è troppo lenta ed è già costretta a inseguire la rapidità delle trasformazioni. Questo è il rischio più grande». Papa Leone è andato oltre: «La possibilità di accedere a vaste quantità di dati e di conoscenze non va confusa con la capacità di trarne significato e valore. Occorre una profonda inversione di rotta». Il problema è capire chi ha in mano il timone.
In effetti sentivamo proprio il bisogno di tornare a dibattere pubblicamente di deriva autoritaria, di pericoli per la democrazia e di fascismo di ritorno. A quanto pare, però, l’opposizione manca di argomenti più seri e, dunque, le tocca aggrapparsi ai grandi classici del piagnisteo progressista. I salotti che contano sono già in fibrillazione, lo studio di Lilli Gruber da qualche giorno è percorso da brividi freddi e timori feroci: la dittatura incombe. Ad alimentare l’ansia ci ha pensato l’altra sera Massimo Giannini, il quale ha sobriamente commentato il progetto di legge elettorale appena presentato dal centrodestra.
L’editorialista di Repubblica ha citato Giuseppe Conte spiegando che la nuova norma sarebbe peggiore della legge truffa e della legge Acerbo del 1923 che concesse la maggioranza alla lista di Benito Mussolini. «Stiamo virando dalle democrazie rappresentative alle autocrazie elettive», ha affermato in diretta un preoccupatissimo Giannini. A suo dire, esiste un piano di Giorgia Meloni che coincide con quello di Donald Trump in cui la riforma della giustizia, il premierato e, appunto, la legge elettorale si incastrano quali tasselli di un mosaico eversivo. Il centrodestra sarebbe, dunque, alla «ricerca di pieni poteri» e usa la legge elettorale come «scorciatoia per raggiungerli il prima possibile». Tale norma, infatti, «consente alla maggioranza di prendere tutto, dove tutto significa non solo il Parlamento, ma anche le nomine e le elezioni di tutti gli organi di garanzia, la Corte costituzionale, il Csm e la presidenza della Repubblica».
Ed eccolo qui il vero problema. La sinistra accusa Meloni di voler mettere le mani sul Colle e questo è semplicemente inaccettabile per un sola, cristallina ragione: il Quirinale è prerogativa progressista, non sia mai che vi salga qualcuno su cui il Partito democratico non abbia fatto calare la sua entusiastica benedizione. Per questo motivo i dem dichiarano ai quattro venti che il testo di legge è «inaccettabile» e «irricevibile». Elly Schlein ripete che «può essere molto distorsivo della rappresentanza e con premi alti e senza limiti. Quindi, da questo punto di vista», ribadisce il segretario del Pd, «rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il presidente della Repubblica».
Ovviamente, queste grida scomposte e allarmate sono strumentali e piuttosto pretestuose. Posto che, come notava qualcuno, questa legge potrebbe persino giovare alla Schlein, garantendole, in mancanza di altri leader credibili, di inchiodarsi alla guida del suo partito, non è affatto detto che una nuova norma avvantaggi la destra. Anzi, la storia recente insegna che le leggi elettorali pensate da una maggioranza per assicurarsi maggiore stabilità non hanno mai funzionato granché, rivelandosi più spesso un boomerang.
In ogni caso, è bene rinfrescarsi un poco la memoria a proposito di alchimie elettorali, premi di maggioranza e pieni poteri, anche solo per svelare l’ipocrisia democratica sul tema. Quelli che ora berciano di deriva autoritaria e si struggono per il premio di maggioranza abbondante, in passato hanno profittato eccome dei premi offerti dalle leggi elettorali vigenti. Nel 2006, per dire, si andò a votare con il famigerato Porcellum di cui va riconosciuta la paternità a Roberto Calderoli. Quella norma prevedeva un premio di maggioranza su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato. Il partito più votato risultò essere Forza Italia, ma vinse l’Unione di Romano Prodi con un margine risicatissimo, grazie ai famigerati voti esteri. Alla Camera, il centrosinistra prese il 49,81% dei voti contro il 49,74% del centrodestra. Grazie al premio, la sinistra prese 67 seggi in più e tanti saluti. Romano Prodi divenne presidente del Consiglio e, a stretto giro, la sinistra elesse Giorgio Napolitano al Quirinale. Nessuno si fece scrupoli, non ci furono pianti sulla deriva autoritaria e la legge elettorale pensata a destra alla fine fu un bel regalo per la sinistra. Altro giro e altro regalo nel 2013, di nuovo con il Porcellum. Il partito più votato alla Camera risultò essere il Movimento 5 stelle, che si era sempre opposto al Porcellum giudicandolo addirittura immorale. Il centrosinistra prese il 29,54% dei voti, il centrodestra il 29,18%, i grillini arrivarono al 25,5%. Grazie al premio previsto dalla legge, la sinistra ottenne 220 seggi in più e, dunque, la maggioranza alla Camera e, dato che Pier Luigi Bersani non fu in grado di trovare un accordo con i pentastellati, nacque il governo di larghe intese guidato da Enrico Letta. Il Pd, insomma, si prese senza restarci troppo male la presidenza del Consiglio e di lì a un paio di anni circa si avviò serenamente a scegliere Sergio Mattarella quale presidente della Repubblica.
In buona sostanza, quando c’è stato da prendere il potere, il Partito democratico non si è mai fatto troppi scrupoli, e non si è dato gran pena per il rispetto delle decisioni degli elettori, la concentrazione dei poteri. Come al solito, la deriva autoritaria non è deriva e non è autoritaria se favorisce il Pd.