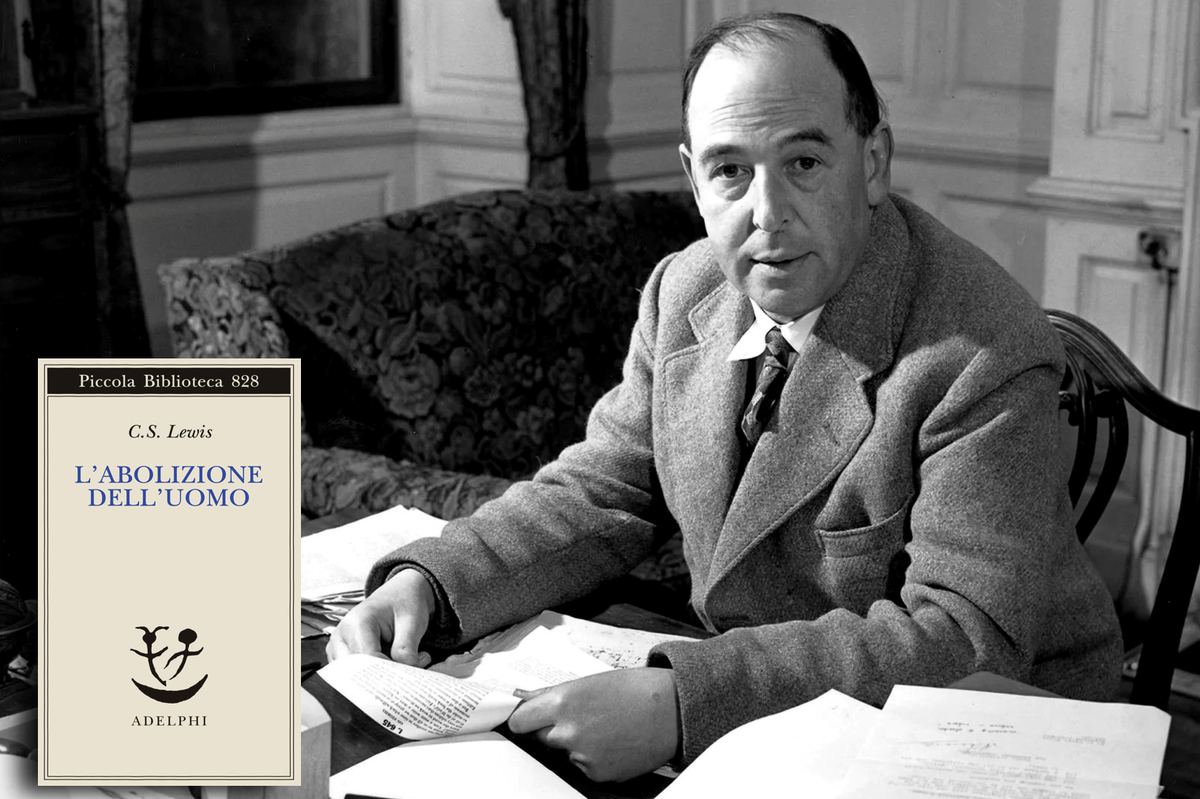Borgia, il «Principe» del sogno italico che venne sconfitto dalla cattiva sorte
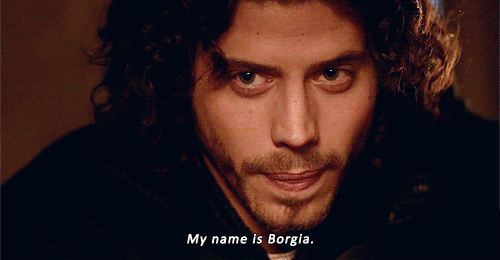
«Questo Signore è molto splendido et magnifico, et nelle armi è tanto animoso, che non è sì gran cosa che non gli paia piccola. Et per gloria et per acquistare stato, mai si riposa né conosce fatica o periculo; giugne prima in un luogo, che se ne possa intendere la partita donde si lieva; fassi benvolere dai suoi soldati; ha cappati i migliori uomini d'Italia. Le quali cose lo fanno victorioso e formidabile, adgiunto con una perfetta Fortuna». Parole tanto elogiative escono dalla penna di Niccolò Machiavelli in una lettera alla Repubblica di Firenze e si riferiscono a Cesare Borgia, detto il Valentino, in quanto duca di Valentinois per volere del re di Francia. È il giugno 1502 e Machiavelli ha appena conosciuto il figlio di papa Alessandro VI, perché Firenze lo ha spedito a Urbino per sondarne le intenzioni. Cesare, però, dichiara che la Repubblica deve scegliere da quale parte stare, senza porre condizioni. «Se non mi volete come amico», minaccia, «mi avrete come nemico».
Dopodiché, il Borgia prosegue nelle conquiste territoriali, perché è deciso a ritagliarsi uno Stato nel Centro Italia. Ha fretta: sa che il tempo a disposizione è misurato su quello che resta al padre, ed è ossessionato da una profezia, secondo cui egli stesso morirà giovane. Gode, comunque, della protezione del re di Francia, che gli dice: «Cugino mio, sta con la pace dell'Eterno Iddio e torna a godere ogni tuo potere, e sta di buona voglia, che io ti ho fatto grande e ti farò ancora maggiore».
I vari Signori sono terrorizzati dall'ascesa del «figlio di Dio» e dal credito che vanta presso Luigi XII. Da una parte, certo, Cesare è stato agevolato dalla fortuna - «arbitra di metà delle azioni umane« - dall'altra è stato aiutato dal genitore, ma non bisogna dimenticare la sua smodata ambizione e un'indubbia sapienza strategica e tattica. Secondo Machiavelli, proprio la combinazione di «fortuna» e «virtù» ha consentito al Borgia l'escalation. La parola virtù non ha il significato odierno, bensì indica tempestività nello sfruttare le circostanze favorevoli, sagacia nel prevedere i possibili scenari ed evitare i peggiori, spietatezza con i nemici. Per il segretario fiorentino, in Cesare si riassumono queste qualità, che ne fanno il princeps per eccellenza, modello del suo famoso e poco compreso libro.
Nel corso dei secoli, c'è chi si è stupito della scelta. In realtà, molte delle riflessioni di Machiavelli prendono le mosse dall'ideale di Francesco Petrarca di un'Italia unita, e vedono nel Borgia l'unico soggetto possibile per effettuare una sintesi. L'autore del Principe teorizza l'autonomia della politica da etica e morale, perché essa ha il compito di rispondere a un solo imperativo, la salvezza dello Stato, dal quale dipende il benessere di ognuno. Machiavelli, inoltre, spera nella nascita, se non di una nazione, almeno di una confederazione di Stati italiani, che dovrebbe porsi sotto l'egida di un «uomo forte» ed essere protetta dal pontefice. Per cinismo, intelligenza, bravura nello scegliere i collaboratori, magnificenza, durezza, parentele e fortuna, Cesare gli sembra la persona giusta.
Ma chi sono questi Borgia, che nell'Italia delle Signorie vengono guardati con paura e percepiti come parvenu, con cui pure occorre venire a patti? Le origini della famiglia sono spagnole, come testimonia il nome Borja (che si riferisce alla parola araba «torre del castello», o al paese da cui arriva la casata), italianizzato in Borgia. Dalla natia Spagna, il clan si è spostato nella penisola nel 1455, quando è asceso al soglio il vescovo di Valencia, Alfonso de Borja, che ha preso il nome di Callisto III. Grazie a lui il nipote Rodrigo, nato il 1° gennaio 1431, diventa giovanissimo cardinale e vicecancelliere del Vaticano.
Furbo, colto, ambizioso, avvolgente, privo di scrupoli, Rodrigo Borgia è appassionato del bel vivere e delle donne, tanto che i contemporanei lo definiscono «il più carnale homo». Il fatto di aver preso i voti non gli impedisce di avere amanti e figli illegittimi. I più noti nascono dalla relazione con Vannozza Cattanei e sono appunto Cesare, del settembre 1475; Juan, che arriva l'anno dopo; Lucrezia, che è dell'aprile 1480 e Jofré (la cui paternità non è certissima). Quando diviene papa, il 6 agosto 1492 (anno della morte di Lorenzo il Magnifico e della scoperta dell'America), sceglie il nome di Alessandro VI e comincia a impiegare la sua forza per restaurare il potere - soprattutto temporale - della Chiesa, nonché aiutare gli amati figli. Nella sua mente, vede delinearsi uno Stato borgiano: molte dinastie, d'altronde, si sono affermate grazie all'astuzia e alla violenza.
Colui che, nel disegno paterno, dovrebbe essere il «delfino» è il secondogenito, il vanesio e velleitario Juan duca di Gandia, che muore però in circostanze sospette nel giugno 1497. Il suo corpo viene ripescato nel Tevere, trafitto da nove coltellate: parecchi pensano che il colpevole sia il fratello. Bisogna anche dire, tuttavia, che nella ferocissima Lettera a Savelli - uno scritto anonimo contro i Borgia del 15 novembre 1501, nel quale si elenca «la lunga lista di uomini uccisi, feriti o gettati vivi nel Tevere» da Cesare - non c'è traccia di questo omicidio.
Passata la disperazione, Alessandro VI sposta sul primogenito le ambizioni che nutriva per Juan. Cesare lascia la porpora, sposa una nobildonna francese, Charlotte d'Albret, e comincia la scalata. Pur cambiando le alleanze a seconda degli eventi - all'inizio sono vicini agli Aragonesi, poi ai francesi - i Borgia sono fermi su un punto, cioè la creazione di una dinastia, stanziata su un territorio. A farne le spese sono una quantità di persone, fra cui il secondo marito di Lucrezia Borgia, il bellissimo Alfonso d'Aragona, che verrà ucciso (probabilmente su ordine di Cesare) da un sicario dei Borgia, don Michelotto Corella.
Il Valentino - che, ricorda Gustavo Sacerdote, «vagheggia la conquista dell'Italia centrale e meridionale», dichiara: Aut Caesar, Aut nihil, «O Cesare o nulla», e prosegue con i suoi obiettivi. Dopo qualche indecisione, si è orientato per il Centro Italia e soprattutto per la Romagna. Tale regione appartiene allo Stato della Chiesa, ma è governata da signorotti incapaci ed efferati ed è «un esempio di ogni scelleratissima vita». Cesare, «marciante alla sua liberazione», vede in essa il primo tassello di un mosaico più grande. Non si sa se pensi addirittura alla penisola intera, ma sembra sia stato lui, a dire che avrebbe mangiato l'Italia «come un carciofo, foglia a foglia».
Nel 1502, tuttavia, gli capita un incidente che potrebbe essere fatale. Alcuni dei suoi capitani più importanti stringono segreti accordi contro di lui, costituendo la Lega del Magione, perché temono che decida di invadere i loro statarelli. Addirittura, conquistano Urbino e fanno tornare il Montefeltro. Poi, però, cominciano a litigare e Cesare ha gioco facile nel dividerli e fingere una riappacificazione tutta apparente. Sa, infatti, che deve annientare il nemico per non essere annientato lui stesso e alla fine di dicembre convoca i capitani nella fortezza di Senigallia, dove ha luogo quello che verrà definito «il magnifico inganno». Invece della pace e dei festeggiamenti previsti, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, due degli Orsini, vengono presi prigionieri e strangolati nella notte dal solito Michelotto. Anche altri congiurati fanno una pessima fine, in quella che Machiavelli definisce «un'impresa rara e mirabile». Tutta Italia, del resto, si congratula con il Valentino, il quale sa che «chi si accinge a ottenere qualcosa non deve avere pietà».
Cesare parrebbe allo zenith, e invece è al tramonto. La scomparsa improvvisa del padre, che avviene nell'agosto 1503, e la sua contemporanea grave malattia, lo precipitano dalle altezze del potere al buio dell'oblio e del disprezzo. Dopo una sofferta prigionia, morirà abbandonato da tutti in battaglia in Spagna, nel marzo 1507. Per Machiavelli, la sua caduta è legata soprattutto all'accanimento della sorte, che si è rivoltata contro di lui, dopo avergli concesso ogni cosa. Se prima è stato tutto, insomma, ora è nulla. Così come aveva dichiarato lui stesso.