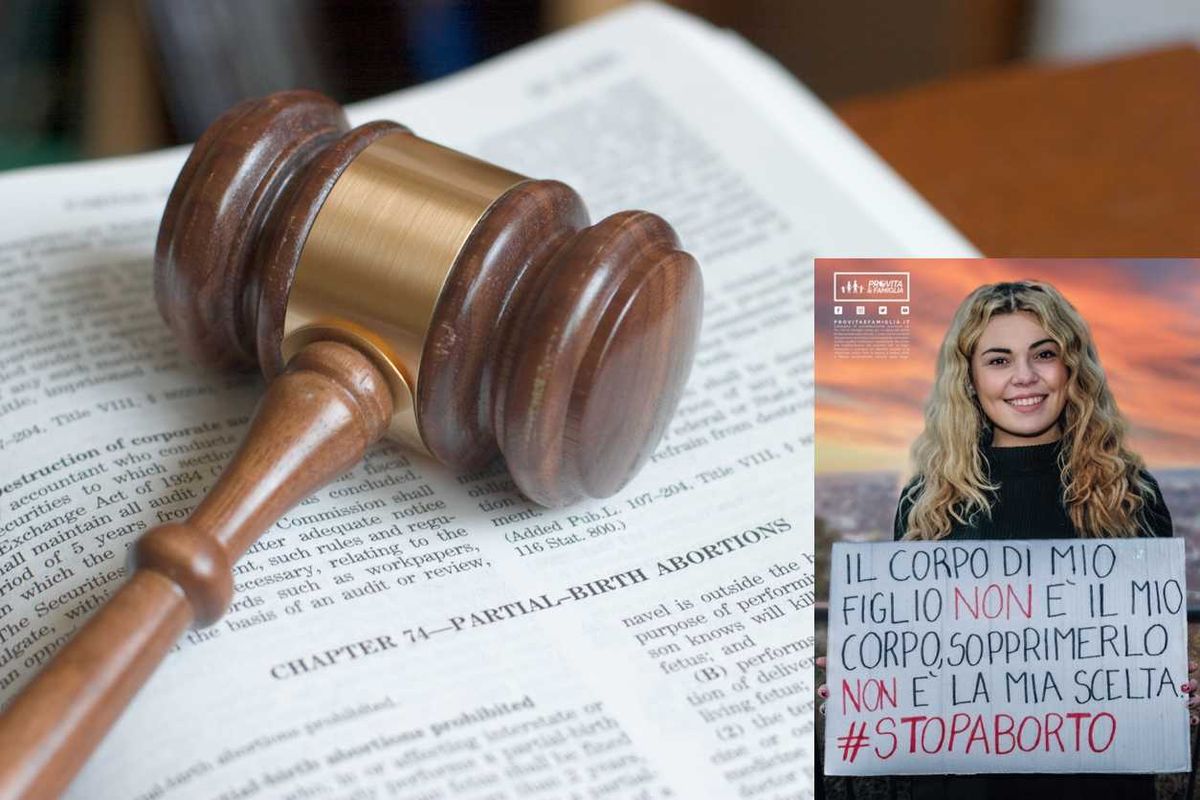Il booster altera gli anticorpi: «Si resta malati più a lungo e sale il rischio di infezione»

E se i plurivaccinati s’infettassero di più proprio perché sono plurivaccinati?
Un po’ di mesi fa, quando le statistiche avevano iniziato a rivelare che l’incidenza dei contagi era più alta tra chi s’era recato ripetutamente negli hub per la puntura anti Covid, qualche esperto, come Francesco Broccolo, aveva ipotizzato una «anergia» del sistema immunitario: a un’eccessiva stimolazione poteva seguire una minore efficienza nel contrasto al virus. Adesso, uno studio pubblicato su Science immunology dimostra che, a partire dalla terza dose di Pfizer (e in seguito all’infezione naturale, ma comunque in modo più sensibile se si è stati sottoposti al booster a Rna messaggero), si verifica un cambiamento nel tipo di anticorpi prodotti dai vaccinati. Un meccanismo che potrebbe essere collegato a una compromissione della capacità di eliminare il Sars-Cov-2 dall’organismo. Ergo, a una maggiore durata della malattia e, plausibilmente, a una ridotta efficacia nel prevenire l’infezione.
L’importanza della scoperta è accresciuta dalla rinvigorita psicosi per la variante cinese - di cui, beninteso, ancora non si trova traccia. Il caos in cui starebbe piombando il Dragone, in effetti, non è stato cavalcato soltanto per celebrare il ruolo salvifico dei vaccini occidentali. Qualcuno ne sta approfittando per rilanciare lo spot alla quarta dose.
Bastava leggere, sul Corriere di ieri, Giuseppe Remuzzi: l’ennesima siringata va somministrata urgentemente «agli over 60, poi al resto della popolazione». E nemmeno questa basterà: trascorsi 120 giorni, ci vorrà la quinta dose. È il famoso «richiamo annuale» di Riccardo Chiaberge - quello che si effettua ogni quattro mesi.
«La percentuale delle quarte dosi», ammoniva su Repubblica Franco Locatelli, «dovrebbe arrivare all’80% oltre i 60 di età». Un circo interminabile, che ormai lascia perplessi persino i camici bianchi: Pier Luigi Bartoletti, presidente dei medici di base, si è chiesto se valga la pena «continuare solo con i vaccini», o se si debba finalmente pensare «anche a farmaci e terapie specifiche per il Covid». E ovviamente, gli autori del paper, uscito sulla rivista dell’American association for the advacement of science, si sono resi conto che esso è rilevante ai fini dell «future campagne vaccinali contro il Sars-Cov-2», oltre che, in generale, per «gli sviluppi di nuovi vaccini basati sull’mRna contro altri patogeni».
Ma cos’hanno trovato, di preciso, i 23 scienziati che hanno vergato l’articolo, affiliati ad atenei e centri di ricerca tedeschi?
Esaminando i campioni prelevati da 29 sanitari, costoro hanno verificato che, eseguito il ciclo primario con il Comirnaty, i vaccinati avevano generato gammaglobuline (IgG) di tipo 1, cioè degli anticorpi associati alla stimolazione della fagocitosi cellulare e all’attivazione del complemento. In pratica, le IgG1 inducono le cellule a «divorare» gli intrusi e mettono in moto un meccanismo di mediazione umorale contro gli agenti infettivi. Fin qui, tutto nella norma. Soltanto che, già a sette mesi dalla seconda dose, iniziava ad aumentare anche la produzione di IgG di tipo 4. Il loro livello, però, raggiungeva il picco dopo il booster, «in pressoché tutti i vaccinati», nessuno dei quali aveva contratto il Covid. A 180 giorni dalla terza inoculazione, alcuni di loro, invece, avevano sperimentato infezioni postvaccinali. In questi ultimi, le IgG4 erano arrivate a costituire tra il 40 e l’80% degli anticorpi contro la proteina Spike. Occhio: chi s’era contagiato entro 70 giorni dal secondo shot non andava incontro a incrementi del livello di IgG 4. Il che significa che è la terza dose a giocare un ruolo essenziale nella stura a questa classe di anticorpi.
Le IgG4, che in teoria accrescono l’«avidità» del sistema immunitario nell’aggredire il virus e le barriere contro i legami tra i recettori cellulari e la Spike, sono altresì collegate a «un minor potenziale» di innescare le cosiddette funzioni effettrici. Meno fagocitosi, meno complemento, minor capacità di eliminazione del virus. Armi spuntate contro il Sars-Cov-2. Qui sta l’inghippo. Le IgG4, commenta il professor Mariano Bizzarri con La Verità, tendono a legarsi con più prontezza al patogeno, ma, paradossalmente, quasi lo «proteggono» dalla risposta immune. Un primo report su questo fenomeno, del resto, risaliva a un anno fa: in un articolo di Frontiers in immunology, l’aumento delle IgG4 veniva collegato a una prognosi peggiore.
In teoria, un anticorpo che impedisce alla proteina S di legarsi ai recettori delle cellule dovrebbe offrire all’organismo un qualche schermo. Ma nella variante Omicron, la Spike è mutata radicalmente. Dunque, il plurivaccinato non è protetto dall’infezione, quando incontra i ceppi mutati; e una volta che s’infetta, possiede un minor numero degli anticorpi utili a eliminare il virus.
Illustriamo il ragionamento con una metafora bellica. Mettiamo che il nostro sistema immunitario abbia eretto una muraglia con le prime due dosi. Il terzo shot equivale a un ulteriore strato di rocce, che eleva in altezza e solidità la barriera. Intanto, però, l’assediante s’è procurato delle palle di cannone in grado di bucare la fortificazione. Le sue truppe, dunque, penetrano nella cittadella. Ma all’inizio, dentro le mura, erano schierati dei soldati con pesanti armature e lance affilate. Ora, al loro posto, ci sono fanti con protezioni leggere e corti gladi. Cacciare l’invasore diventerà più difficile e richiederà più tempo.
In definitiva, l’aumento delle sottoclassi di IgG4 potrebbe portare a una persistenza virale più lunga - addirittura, correlabile al long Covid? - o favorire l’emergere di infezioni associate che beneficerebbero dello stato di relativa tolleranza indotto sul sistema immunitario. Così, come sottolinea ancora il prof Bizzarri, la «tolleranza indotta nei riguardi nel virus» spiegherebbe «perché chi ha fatto tre-quattro dosi tende a contagiarsi di più».
D’altronde, i dati dell’Iss sulla quarta dose, spacciata per una panacea, sono inequivocabili: essa conferisce un vantaggio nell’immediato, ma passati quattro mesi, chi l’ha ricevuta si contagia, finisce in ospedale e, addirittura, muore di più di tutti gli altri vaccinati a vario titolo. Seguendo la filosofia di Locatelli & c., il secondo richiamo diventerà semplicemente il preludio alla quinta dose. Come previsto da Remuzzi. Ma allora, quand’è che potremmo scendere dalla giostra delle punture?