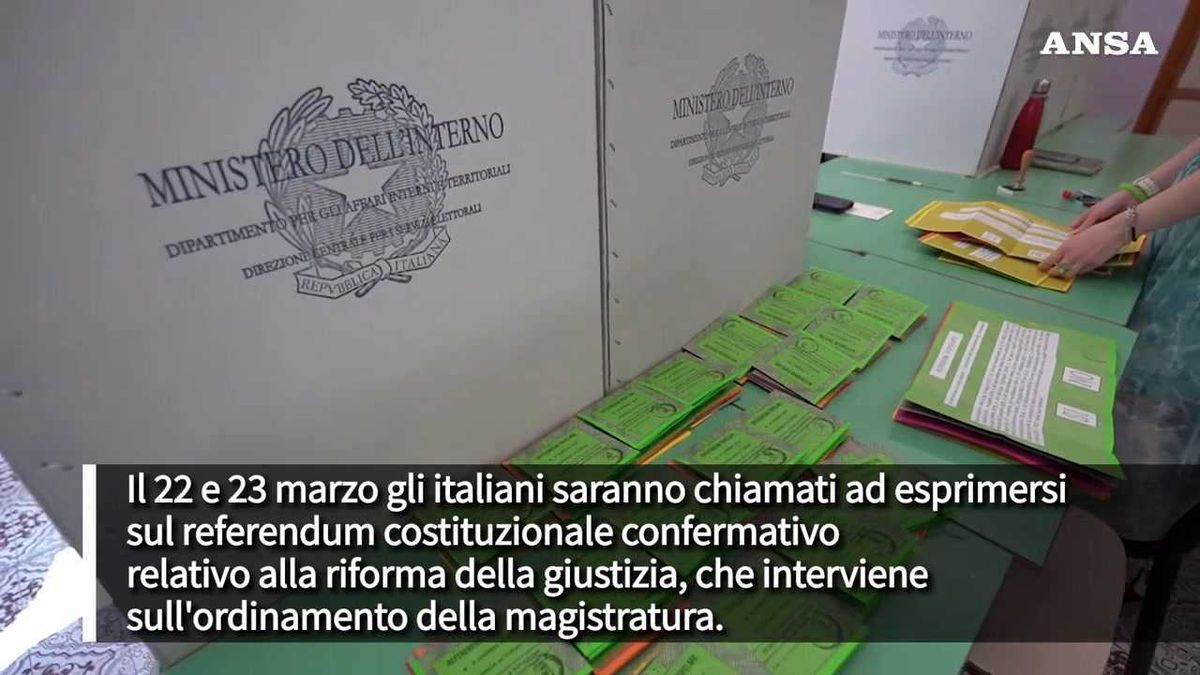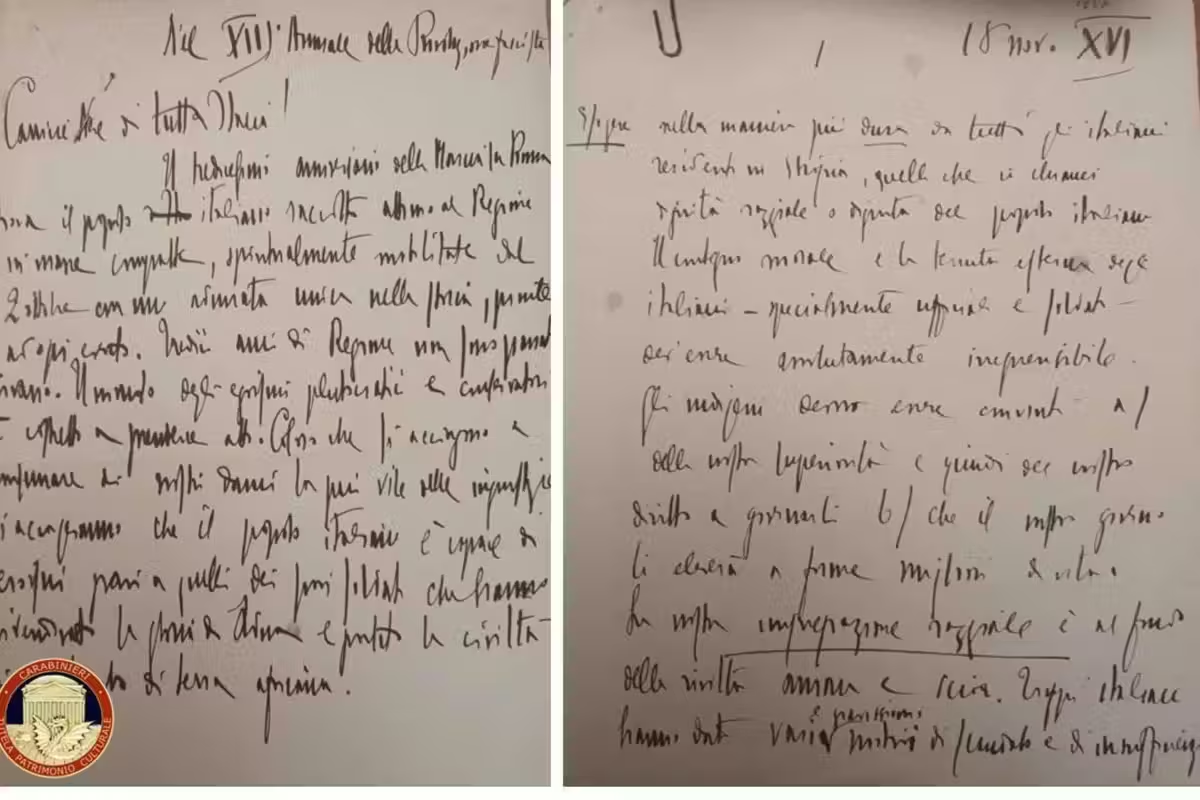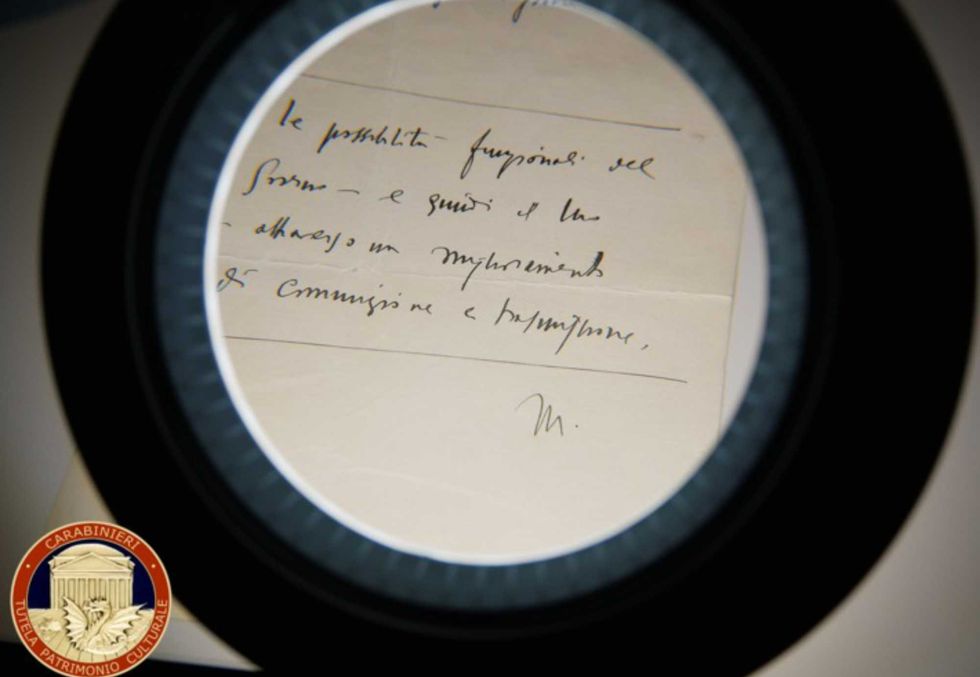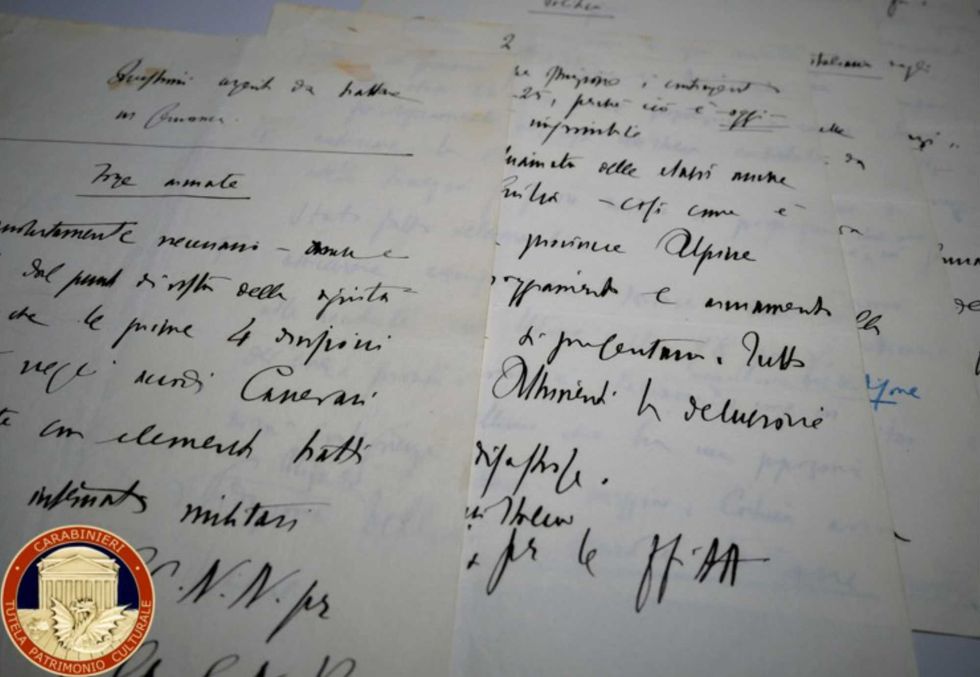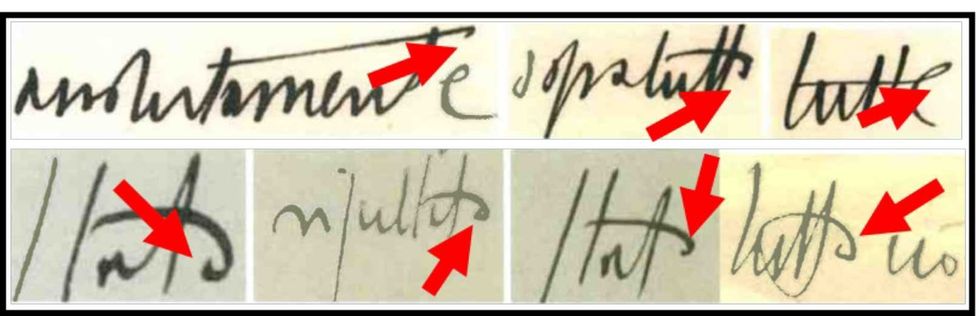Sapevate che tra poco comincia la stagione di produzione del Bitto? E già. Si tratta di un formaggio antico di un lembo di Valtellina un tempo occupata dai Celti, che si riversarono sui monti dopo esser stati cacciati dai Romani dalla Pianura Padana. Molti fanno risalire a quel tempo e a quel popolo, esperto anche di pastorizia, sia la prassi di caseificare il latte appena munto per conservarlo, anche perché poco altro potevano fare rifugiati sulle Alpi, sia il nome: in celtico, la parola «bitu» significa perenne e forse ci denominarono un formaggio con riferimento alla lunga conservabilità di un latte trasformato in cacio. Può anche darsi che il formaggio Bitto si chiami così, più semplicemente, per le due valli del Bitto di Albedo e Agerola e per il torrente Bitto, con un passaggio metonimico dal nome del territorio al prodotto del territorio, ma può anche essere che questi toponimi alludano essi stessi alla persistenza dell’originaria parola celtica, riferita al torrente, perenne - costante - nel suo scorrere o alle valli che stanziavano immobili. Chissà.
Il Bitto si produce d’estate, nel periodo della monticazione (la salita in alpeggio), che va dal primo giorno di giugno all’ultimo di settembre. E si produce esclusivamente in Valtellina. Il Bitto, infatti, rinomato formaggio lombardo, si prepara col latte prodotto negli alpeggi della provincia di Sondrio e di alcuni comuni limitrofi dell’Alta Valle Brembana in provincia di Bergamo (Averara, Carona, Cusio, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida e Valleve), oltre agli alpeggi denominati Varrone, Artino e Lareggio dei territori limitrofi nei comuni di Introbio e Premana in provincia di Lecco aggiunti all’area di produzione nel 2005. Il Bitto si prepara con solo latte crudo di mungitura quotidiana di razze vaccine tipiche della zona alimentate con le essenze spontanee e gli erbai dell’area in questione eventualmente affienati (cioè trasformati in fieno). Questo latte può essere eventualmente aggiunto di latte crudo caprino (massimo il 10%) sempre locale, poi va coagulato in giornata grazie allo sviluppo spontaneo della microflora casearia e al caglio di vitello. Nel 2005 sono stati aggiunti: la possibilità di integrare l’alimentazione da pascolo con sale pastorizio, poi 3 kg massimo al giorno di mais, orzo, frumento, soia, melasso fino al 3%, poi un’alimentazione di solo soccorso di fieno al 5% in caso di eventi eccezionali e l’uso di innesti selezionati di ceppi autoctoni di microflora.
Ma cosa è successo nel 2005? Nel 2005 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (la 168 del 21 luglio di quell’anno) le modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bitto, che è appunto un formaggio Dop, riconosciuto tale un decennio addietro, nel 1995. Tornando alla nostra produzione, dopo la coagulazione la cagliata viene cotta a una temperatura tra 48 e 52 °C per circa 30 minuti. Dopodiché la si rompe, fino ad ottenere grumi della dimensione di chicchi di riso. Questa cagliata in chicchi viene poi estratta e posta in fascera, tipicamente concava per favorire la salatura, perché inizi la cosiddetta sineresi, cioè l’espulsione del siero. A questo punto, la forma si sala e poi inizia la maturazione che dura almeno 70 giorni e dunque comincia in cima, nelle così chiamate «casere d’alpe», ma si conclude a valle. Dopo 70 giorni la forma si può marchiare e poi parte la stagionatura vera e propria, che si può protrarre non diciamo per la perennità di celtica memoria, ma anche per 10 anni, esattamente come avviene per altri preziosi formaggi nostrani, Dop o meno che siano. La forma di Bitto definitiva avrà il caratteristico scalzo (ossia il profilo verticale) concavo, con gli spigoli in alto e in basso vivi, le facce piane con crosta gialla da 2 a 4 mm, il tipico sapore insieme dolce, salato, importante ma non amaro, caratteristiche che si intensificheranno in misura direttamente proporzionale alla lunghezza della stagionatura. Se il Bitto contiene anche latte caprino, a questi sapori aggiungete anche un sentore appena e vagamente piccantino.
Il Bitto è formaggio estivo valtellinese e di alta quota, dunque da 1400 m in su fino a 2300, perché la monticazione consiste in un percorso a salire che prevede di arrivare in una stazione, fermarsi, operare, ripartire per salire un altro po’ e così via, fino a giungere in cima, per poi ridiscendere a valle.
Se il Bitto è il king locale, così direbbero alla Gillette, dei formaggi di alpeggio estivo, cosa facevano le sue lattifere nelle restanti stagioni? Riposo? No, facevano il Valtellina Casera. Anche questa dicotomia è antica e replica l’alternanza tipica dell’allevamento alpino. Cioè salita ai pascoli in alta quota in estate e discesa a fondovalle per autunno, inverno e primavera, col risultato di una differenza e di una complementarietà non solo pastorizia, ma anche in sede di risultato della caseificazione: il Bitto è un formaggio grasso di latte intero, il Valtellina Casera, un tempo prodotto soltanto in inverno, oggi protagonista di una produzione estesa lungo l’arco dell’anno, è un formaggio semigrasso di latte vaccino parzialmente scremato. La parola «casera», infatti, in valtellinese vuol dire latteria, che è il luogo dove si realizzano il formaggio e il burro, quest’ultimo col grasso asportato al latte, che quindi resta parzialmente decremato e perciò il Valtellina Casera è un formaggio semigrasso e non grasso. La casera è anche il luogo dove poi il formaggio si fa stagionare. La differenza tra Bitto e Valtellina Casera riguarda il contenuto di grasso, ma anche il colore: il Bitto è più giallo perché le erbe di alpeggio di cui le vacche si nutrono sono più ricche di betacarotene. Ed è più aromatico, sia al gusto, sia all’olfatto, mentre il Casera ha un gusto più delicato. In entrambi i casi, i due formaggi concentrano queste caratteristiche man mano che avanzano nella stagionatura, stagionatura che può essere anche una conservazione per sé: molti in quei luoghi, produttori o abitanti che siano, conservano delle forme anno dopo anno per occasioni speciali. La degustazione ideale del Bitto è in purezza: spezzando la fetta, annusando l’odore che si sprigiona, accompagnando magari con un vino, magari valtellinese, da meditazione. Tuttavia, le ricette che impiegano come ingrediente il Bitto, come d’altronde il Valtellina Casera, sono tante, anche accanto ad altri ingredienti tipicamente valtellinesi come il grano saraceno, per esempio nei pizzoccheri o negli sciàtt.
Il Bitto è un formaggio che può essere semistagionato, stagionato o molto stagionato, con conseguente pasta semidura o dura e poiché usa latte intero è un formaggio grasso. Ha almeno il 45% di materia grassa sulla sostanza secca. Non bisogna abusarne, come - ci teniamo a dirlo, non apprezzando quel doppiopesismo che a certi fa valutare le calorie solo di alcuni cibi - non si deve fare di nessun cibo troppo calorico (sono molto calorici anche i legumi secchi e la frutta secca e oleosa). Tuttavia, a fronte di una presenza importante di acidi grassi saturi, il Bitto presenta comunque Cla cioè percentuali di acidi grassi polinsaturi superiori a quelle dei prodotti di pianura, per la ricchezza di acido a-linoleico delle erbe fresche dei pascoli che poi si trasferisce nel latte e da questo nel Bitto, rendendolo adatto anche a chi è intollerante al lattosio (fonte Efsa). Il Bitto ha 410 calorie ogni 100 g: 26 g sono di proteine ad alto valore biologico, circa 35 sono di grassi. Inoltre, fornisce all’organismo importanti quote di calcio, fino a 1.200 mg ogni 100 g, fosforo e vitamina B2.
Da settembre 2016, quello che precedentemente era stato chiamato Bitto Storico, si chiama Storico Ribelle. Presenta alcune differenze rispetto al Bitto Dop, per esempio la nutrizione degli animali con sola erba fresca di alpeggio. Poi, solo caglio e nessun enzima. Poi, l’uso obbligatorio di latte caprino locale, dal 10 al 20%, da capre di razza Orobica. La trasformazione del latte avviene appena munto, nelle caratteristiche malghe alpine (dette in dialetto «calécc») e la stagionatura solo presso la casera del Bitto Storico di Gerola Alta. Lo Storico Ribelle è un Presidio Slow Food.
Ogni tanto si sente affermare, lo fa sovente anche lo storico Alberto Grandi, che il Dop sia «solo una questione di marketing». A ben guardare, tutto può avere un effetto marketing, anche il marchio del presidio Slow Food o il Nutriscore apprezzato da alcuni critici dei Dop. Quello che è accaduto tra Bitto Dop e Storico Ribelle, cioè la suddivisione di un formaggio in due filiere produttive, in soldoni, dimostra che il posto occupato dal Dop non toglie alcuno spazio a una versione diversa, sebbene proveniente dalla stessa matrice, del prodotto tutelato dal Dop. Questa dicotomia tra denominazione di origine protetta, per altro esistente ai sensi di regolamenti europei e perciò non attribuibile ad alcun «gastronazionalismo» (altra accusa che vediamo sfrecciare a vanvera nei cieli del discorso pubblico del cosiddetto food), e presidio Slow Food riguarda molti altri prodotti tipici che si sdoppiano in una versione che raggiunge più persone ad un prezzo accessibile e una che ne raggiunge di meno ma compensa con un prezzo di vendita maggiore, come la Mortadella Bologna Igp e la Mortadella Classica presidio Slow Food.Le cose, poi, possono anche essere meno duali di così. Esiste un Bitto Dop detto Bitto Dop Prodotto d’alpeggio che è una via di mezzo tra i già eccezionali Bitto Dop e Storico Ribelle: i produttori che non usano l’integrazione di 3 kg di sostanza secca per l’alimentazione delle vacche, che non usano fermenti durante la caseificazione e che iniziano a caseificare entro 30 minuti dalla mungitura possono stampare il nome dell’alpeggio per esteso sullo scalzo della forma.