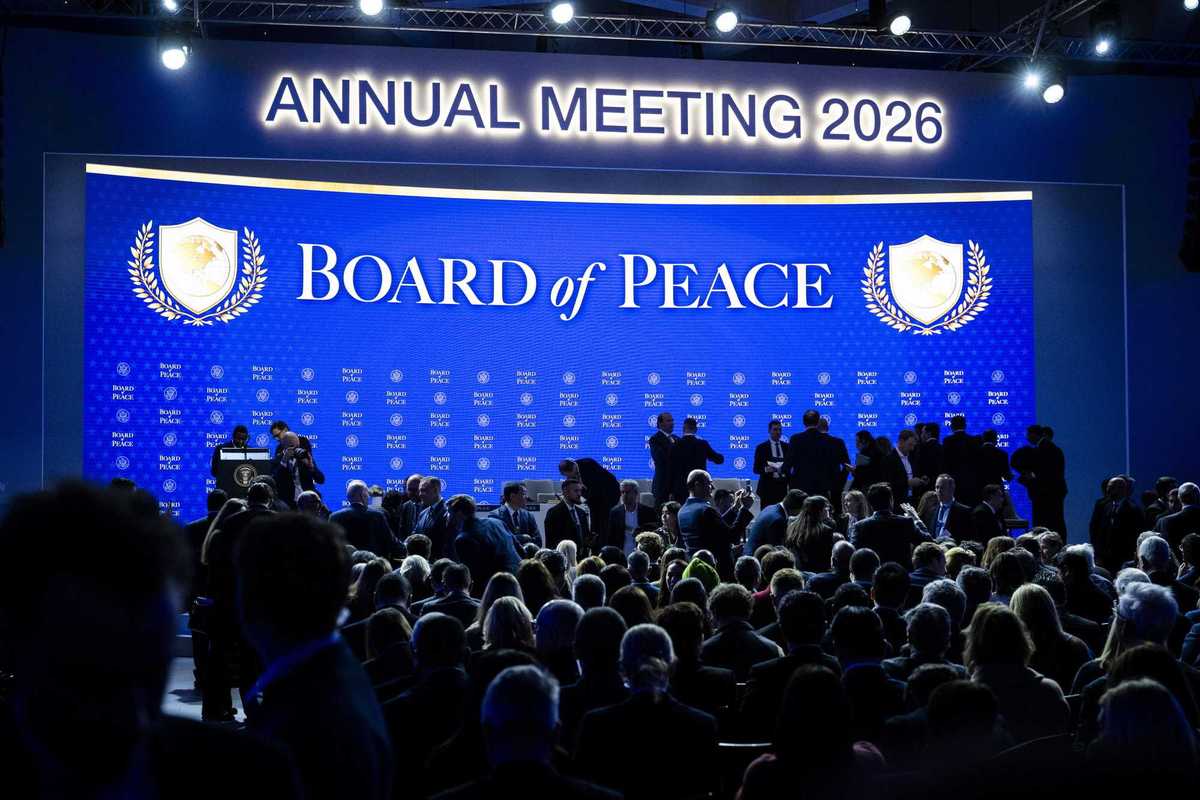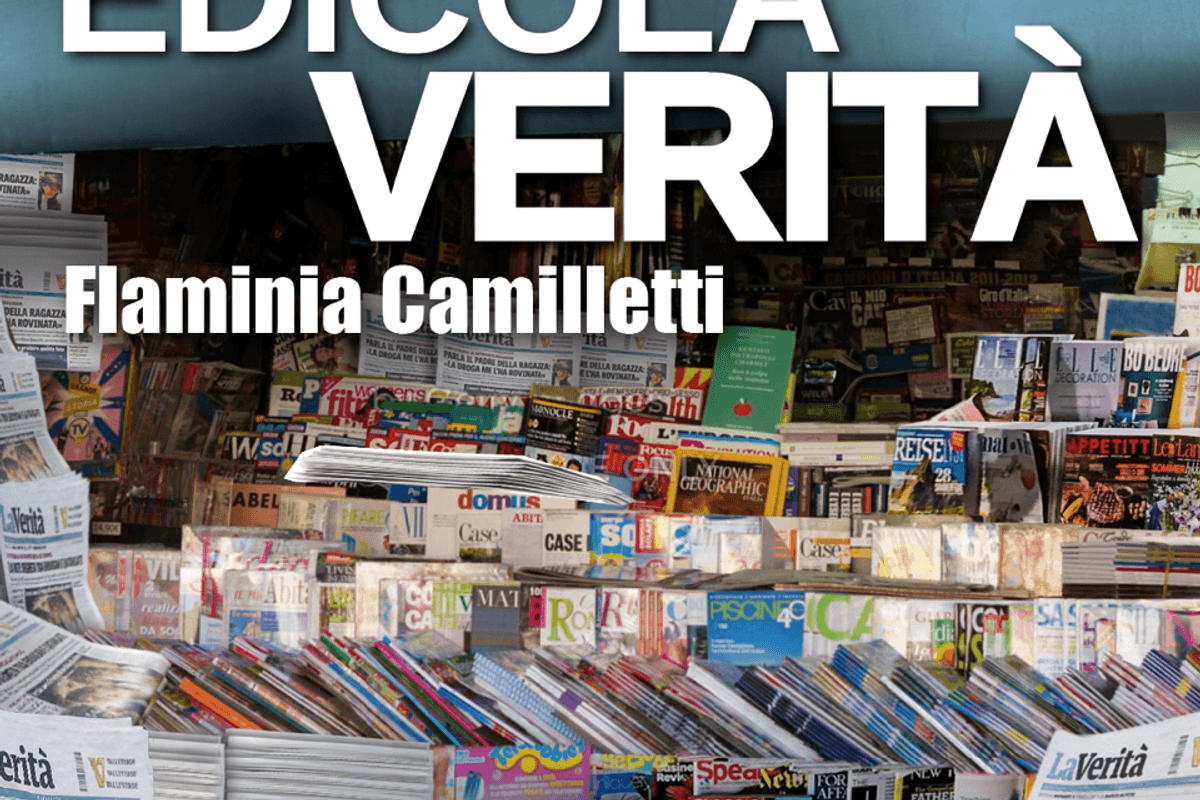Quando il (futuro) antifascista Croce applaudì Mussolini alla vigilia della marcia

Il più importante oppositore intellettuale al Regime fu in realtà un suo sostenitore almeno fino al 1925. E a chi gli parlava della volenza delle camicie nere, rispondeva: «È la levatrice della storia».
È il 24 ottobre 1922: al teatro San Carlo di Napoli, Benito Mussolini tiene un violento discorso che di fatto annuncia la marcia su Roma, che sarebbe avvenuta quattro giorni dopo. Nel palco assegnato ai senatori, uno spettatore si spella le mani per applaudire quell'incitamento all'insurrezione. È Benedetto Croce, il papa laico dell'antifascismo italiano. L'iniziale sostegno del filosofo a Mussolini è noto agli storici, ma viene per lo più taciuto come una circostanza imbarazzante. Pochi giorni prima, allo storico Giustino Fortunato che gli chiedeva se fosse disposto ad accettare le violenze delle camicie nere come prezzo da pagare per sconfiggere il comunismo, Croce rispose con una cinica e serafica sentenza destinata a rimanere famosa: «Ma don Giustino, vi siete scordato quello che dice Marx, che la violenza è la levatrice della storia?».
Salvatore Cingari, in un approfondimento dell'Enciclopedia Treccani alla voce «Croce e il fascismo», spiega che al movimento mussoliniano il filosofo «non ha mai la tentazione di concedere qualcosa dal punto di vista ideologico. Del tutto estranei e indigesti sono, per lui, nazionalismo, futurismo, tradizionalismo, sindacalismo rivoluzionario, dannunzianesimo. Egli sostiene però l’utilità di questo movimento politico negli anni cruciali del suo avvento e della presa del potere». Che Croce fosse distantissimo dal fascismo in termini di visione del mondo è vero. E tuttavia non bisogna neanche fermarsi all'immagine, assunta più in là negli anni, di Croce come «il più autentico teorico del conservatorismo del nostro secolo», come lo definì Augusto Del Noce, il bonario e paternalistico pensatore moderato che rimpiangeva l'Ottocento liberale. All'inizio del secolo, infatti, Croce era stato un protagonista di quel rinnovamento culturale italiano a cui attinsero in seguito anche i fascisti. Era stato lui a far tradurre le Considerazioni sulla violenza di Georges Sorel a Laterza, ed era stato sempre lui a dominare la prima stagione de La Voce, la rivista di Prezzolini che sarà così determinante nella formazione culturale di Mussolini. Con Labriola e Gentile aveva dato vita a un fondamentale dibattito sul marxismo da cui era scaturita quella «filosofia della praxis» che aveva caratterizzato tanto Gramsci che lo stesso Gentile, e tramite lui Mussolini.
Bisogna inoltre ricordare che, fra i due giganti del neoidealismo italiano, Croce e Gentile, inizialmente per il (futuro) capo del fascismo era stato più importante il primo che il secondo, come ha riconosciuto anche Marcello Veneziani: «Alle origini della formazione mussoliniana vi è più posto per Croce che per Gentile. Croce è un riferimento ricorrente per Mussolini nel dibattito sull’inveramento e il superamento del marxismo in Italia. Il suo nome, coniugato in un primo tempo a quello di Labriola, e in un secondo a quello di Sorel, è ricorrente negli scritti di Mussolini socialista [...]. La presenza di Croce nella formazione mussoliniana è determinata da varie circostanze: la comune provenienza dal marxismo e dintorni, la mediazione di Prezzolini, allora crociano e primo biografo di Croce; la lettura dell’idealismo crociano in chiave volontaristica, assimilato al sorelismo; la mediazione stessa di Croce (oltre che di Missiroli) nei riguardi del pensiero di Sorel, e anche la maggiore “accessibilità” del linguaggio e del pensiero crociano per un politico e un autodidatta come Mussolini, rispetto al carattere più rigorosamente filosofico del linguaggio e della teoria gentiliani».
Insomma, le cose, al solito, sono più complesse. Durante l'ascesa al potere delle camicie nere, in ogni caso, il sostegno di Croce fu puramente tattico. Nel novembre del 1922, a marcia consumata, sul Giornale d’Italia esaltò la figura di Mussolini come esempio di azione creatrice. Il 27 ottobre 1923, sulla stessa tribuna, difese il fascismo in quanto forza priva di alternative, unico soggetto capace di mantenere un governo. Alle elezioni del 6 aprile 1924, Croce sostenne il «listone» di appoggio ai fascisti, dichiarando che il cuore del nuovo movimento era costituito dal suo amore per la patria e dalla sua opera di salvezza dello Stato. Per lungo tempo, il pensatore continuò a sperare che il fascismo non si ostinasse più nel voler creare uno Stato nuovo, ma si limitasse a riportare l’ordine per poi riconsegnare le chiavi del Paese al solito liberalismo. Ancora durante la crisi relativa al rapimento di Matteotti, subito dopo un discorso di Mussolini alla Camera, fu proprio Croce a farsi promotore di un ordine del giorno a favore del governo e, una volta che esso fu approvato attraverso il voto, definì «prudente e patriottico» quel voto. La soppressione della libertà di stampa e il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini, in cui questi si assume la responsabilità del delitto Matteotti, portarono definitivamente Croce all’opposizione, che poi si concretizzerà nel «Manifesto degli intellettuali antifascisti», da lui redatto e pubblicato il 1° maggio 1925 sul quotidiano Il Mondo.