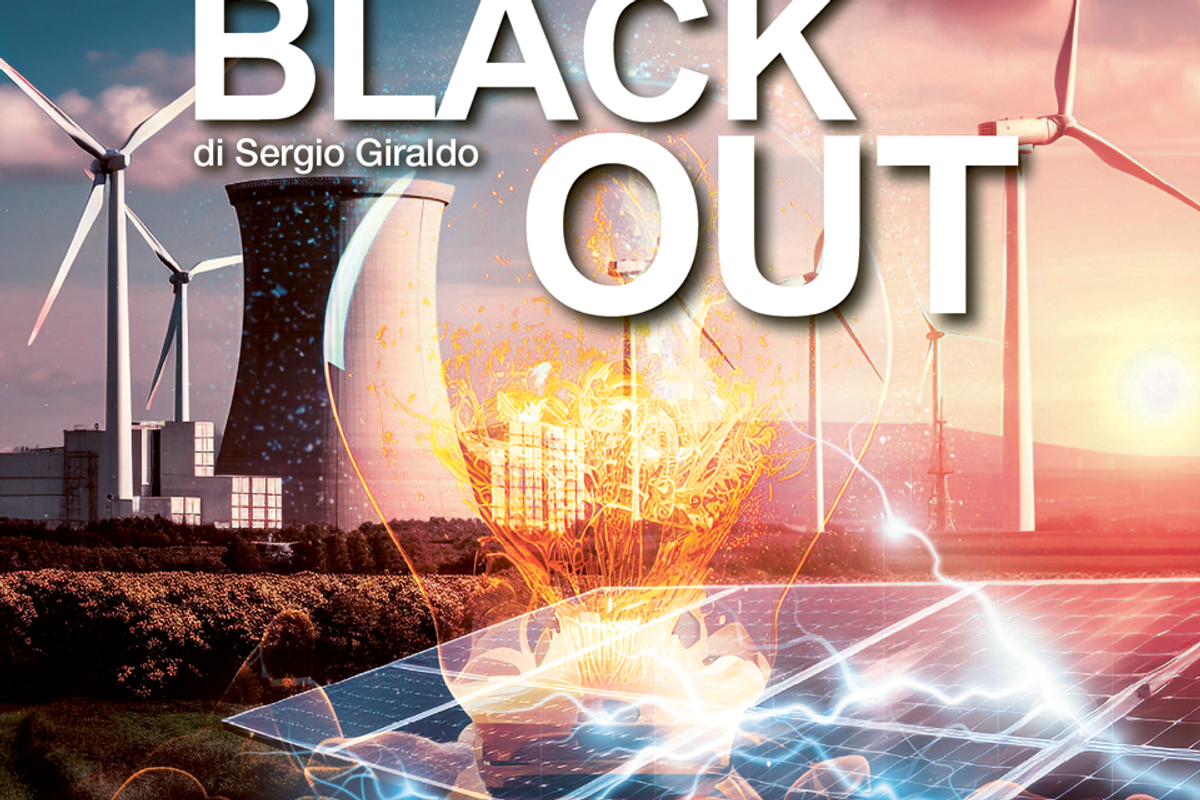«Basta tamponi a strascico. Investiamo sui medici e accorciamo le quarantene»

Con la scoperta di 14 positivi nella squadra del Genoa, tra giocatori e staff, un'ombra di incertezza si allunga sul campionato appena ricominciato. L'ombra del dubbio si allunga anche sul Napoli, contro cui la squadra ha giocato domenica. Osservatrici speciali, la Juventus, prossima avversaria della squadra partenopea, e il Torino, che dovrebbe sfidare i rossoblù. «Il tampone è un'istantanea, fotografa la situazione in un momento. Dopo alcune ore, come è successo al Genoa, il quadro può essere diverso», commenta, alla Verità, Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. In un post su Facebook, che ieri ha fatto il giro del web, il professore ha parlato di «Waterloo dei tamponi» e invocato un ritorno al ruolo del medico.
I tamponi non bastano?
«Bisogna tornare a fare i dottori. Stiamo prendendo una piega che non mi piace molto. Lo dico da medico. Non possiamo fare la medicina basata sul tampone, dobbiamo guardare il paziente, visitarlo. La mia critica è sull'uso fatto del tampone come una rete a strascico: non serve, perché nel giro di poche ore il negativo può essere positivo. La situazione di oggi è diversa da quella di Vo' Euganeo. Non siamo in un ambiente chiuso, ma dinamico. La gente si muove e il caso del Genoa calcio è un esempio paradigmatico di quello che succede nella società e di quanto funzionano i protocolli. La squadra di calcio dice se il metodo funziona. Da quando è ripreso il campionato, ogni squadra avrà fatto 2-3.000 tamponi. Fino ad allora avevamo solo i dati di realtà ospedaliere o comunque di un gruppo di contatti. Adesso il quadro è cambiato».
Però qualcosa non quadra. Nei campi da calcio si è giocato a giugno e tutta l'estate, praticamente. Cosa è successo al Genoa?
«Il problema è la circolazione del virus. A giugno, e durante l'estate, era bassa. Adesso, con la ripresa delle attività e della scuola, ha iniziato a circolare di più. I giocatori sono uno spaccato della società civile: sono padri, hanno contatto con lo staff, c'è il magazziniere, il fisioterapista. Il virus circola di più, ma questo non significa che ci siano più malati. Il protocollo attuale funzionava bene con una bassa circolazione del virus».
Cosa dovrebbe cambiare nella strategia di contenimento dell'epidemia da Covid-19?
«Si dovrebbe investire sui medici. Quanto abbiamo speso per fare tamponi? Siamo sicuri che abbiamo investito altrettanto per medici, infermieri e personale sanitario? Abbiamo una macchina eccezionale per fare i tamponi e poi, magari, non abbiamo abbastanza medici e personale per gestire questa mole di lavoro. La critica, è evidente, non è al tampone, che è il metodo migliore per la ricerca del virus. In caso di negatività però, il test può dare una falsa rassicurazione che potrebbe essere smentita a distanza di ore. Per questo il medico può fare la differenza. Anche in caso di positività: un conto è avere i sintomi, un altro essere positivo».
Certo, purtroppo però anche gli asintomatici possono trasmettere il virus…
«Appunto. È come per quello che è negativo al tampone. Questo si sente tranquillo e magari si toglie la mascherina, mentre invece è in fase di incubazione».
Insomma, il protocollo sull'uso della mascherina non cambia: va sempre indossata in luoghi chiusi e ogni volta che non si può rispettare una distanza di almeno un metro da un'altra persona. Ma per il tampone si deve cambiare...
«Se facciamo 300.000 tamponi al giorno, in 100 giorni abbiamo testato l'Italia, ma avremmo solo buttato soldi e risorse perché, due giorni dopo, il quadro potrebbe essere completamente diverso, come dimostra il caso del Genoa. Partiamo dalla quarantena. Ho il contatto con un caso certo? Sto in quarantena. Piuttosto accorciamo il tempo di isolamento da 14 a 7 giorni. Dopo una settimana si può fare il tampone: avrò più probabilità di fotografare una situazione reale: se il virus c'è lo trovo al 95%».
Il campionato di calcio potrebbe essere fermato?
«Questo non lo devo dire io. Certo, il quadro cambia velocemente e i tamponi rapidi hanno il rischio di dare falsi negativi».
Come se ne esce?
«La sfida è tornare a fare i medici, a investire sui medici e sul personale sanitario. Non nascondiamoci dietro a un test. Mettendo gli ospedali a fare tamponi, si è prolungato lo stato di emergenza, ma non si è aumentato e assunto il personale. La vera fase due è proprio nel fare in modo che il sistema sia pronto, mettendo il medico e il personale sanitario nella possibilità di svolgere il proprio lavoro. Anche nelle scuole: ci vuole il medico scolastico. I bambini difficilmente sono asintomatici se hanno il virus del Covid-19. Mi dispiace per il calcio, ma nel caso dovessimo fare a meno di qualcosa, non sarà certo della scuola o del lavoro, che devono andare avanti».