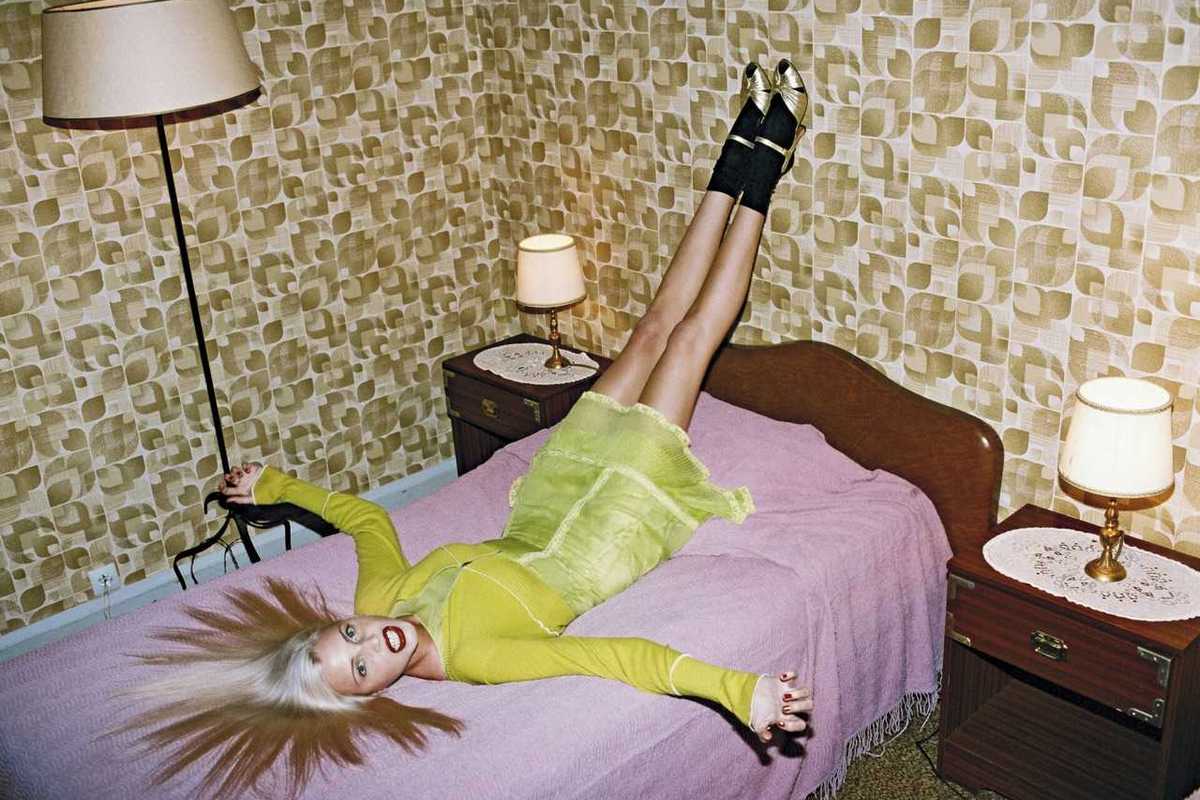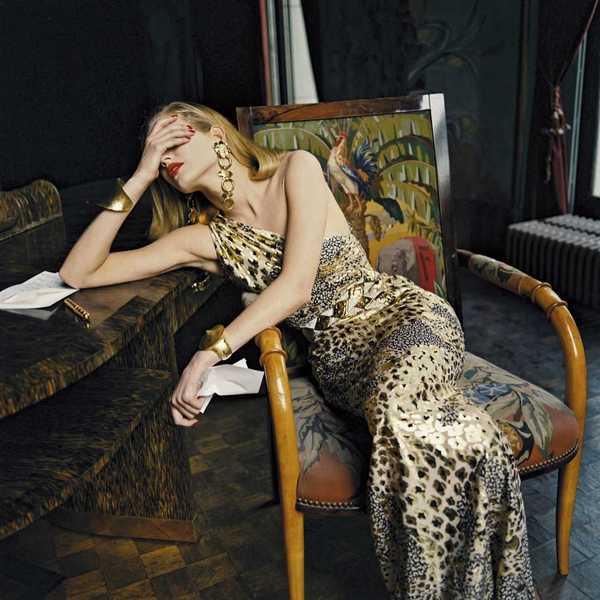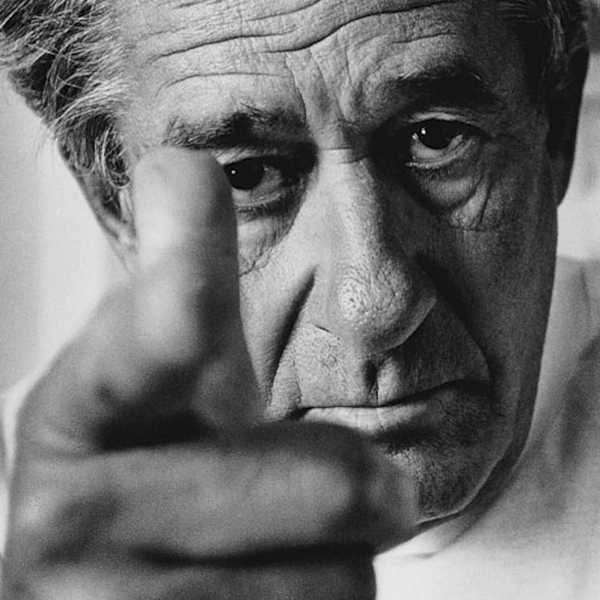Basta con la favola del poeta sfigato: Leopardi fu un genio identitario e ribelle

Se Alessandro Manzoni è «la Provvidenza» e Gabriele D'Annunzio è «l'irrazionalismo», per lo stupidario scolastico imposto da generazioni di professori svogliati, Giacomo Leopardi è sicuramente spiegabile con la vaga categoria del «pessimismo». Ricordiamo tutti la storia del poeta malinconico e un po' storto, affranto perché, par di capire, con Silvia non si batteva chiodo. Davvero un bel modo per neutralizzare quello che è stato il maggior poeta italiano, nonché, nella sua epoca, uno dei pensatori più originali e profondi dell'intera Europa.
Un fraintendimento che ha del resto qualche padre eccellente, dato che fu Benedetto Croce il primo a parlare della «vita strozzata» di Leopardi, la cui opera sarebbe solo «proiezione raziocinante del proprio stato infelice» (insomma, era gobbo, quindi cantava il pessimismo). Vecchiume ermeneutico che, nel duecentoventesimo anniversario dalla nascita (cade esattamente il prossimo 29 giugno), si potrebbe tentare di lasciarsi finalmente alle spalle. Magari insieme alle vere e proprie fantasticherie interpretative della critica marxista che, dal Leopardi progressivo di Cesare Luporini, fino a quello «disperatamente rivoluzionario» di Toni Negri, hanno trasformato il vate di Recanati un po' in Togliatti, un po' in un black bloc. Panzane inevitabilmente rimbalzate sui banchi scolastici grazie a un sistema educativo troppo pigro o troppo connivente per porre un freno allo scempio. Ecco, quindi, che a generazioni di studenti è completamente sfuggita l'incredibile attualità di un pensatore capace di mettere a fuoco, nel primo Ottocento, i temi relativi all'identità, al linguaggio, all'etica, persino alla globalizzazione, con cui noi ancora oggi continuiamo a romperci la testa.
Il filosofo Emanuele Severino, che al poeta ha dedicato due libri (Il nulla e la poesia e Cosa arcana e stupenda) ha non a caso sostenuto che «Leopardi è non solo il primo pensatore dell'età della tecnica, e apre la strada poi percorsa da tutta la filosofia contemporanea, ma vede il futuro essenziale dell'Occidente: l'approssimarsi del paradiso della civiltà della tecnica e l'inevitabilità del suo fallimento». Che cos'è, del resto, il tema leopardiano della «strage delle illusioni» se non l'anticipazione preveggente dei dibattiti sulla fine delle ideologie, la crisi della metanarrazioni, il pensiero debole e il nichilismo emersi nella filosofia contemporanea (e in maniera molto più confusa) solamente negli ultimi decenni del Novecento? Anche il cosiddetto linguistic turn, la svolta linguistica che ha portato la riflessione filosofica contemporanea a interrogarsi sul modo in cui il pensiero si dà necessariamente attraverso il linguaggio, ha illustri antecedenti in Leopardi, che nello Zibaldone ci torna sopra varie volte: «Ciascuno pensa nella sua lingua»; «Un'idea senza parola o modo di esprimerla, ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita e mal nota a noi medesimi che l'abbiamo concepita»; «Non si pensa se non parlando»; «Le idee sono inseparabili dalle parole». E se non mancano, in Leopardi, tematiche di stampo illuministico, a cominciare dall'importanza sociale e politica della «conversazione» e dell'opinione pubblica, si tratta pur sempre di quello che Franco Volpi, su Repubblica, definì «un illuminismo nero». Da qui gli arcinoti e amari riferimenti, ne La ginestra, alle «magnifiche sorti e progressive» e al «secol superbo e sciocco». Ma anche il suo rifiuto delle ingegnerie istituzionali che, con ottimismo bovino, vorrebbero dare la felicità agli uomini. Lo dice chiaramente il poeta stesso nella lettera a Pietro Giordani del 29 luglio 1828, in cui si scaglia contro «l'inutilità quasi perfetta degli studi fatti da Solone in poi per ottenere la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli» e vario altro «furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi».
Ma è soprattutto sulla critica alla globalizzazione che Leopardi sembra in anticipo di quasi due secoli sull'agenda politica odierna. Nello Zibaldone, forte è la critica all'«impulso moderno di uguagliare ogni cosa», perché «la tendenza dello spirito moderno è di ridurre tutto il mondo una nazione, e tutte le nazioni una sola persona». Una volta, dice, «le nazioni cercavano di superar le altre, ora cercano di somigliarle». Definisce poi «una chimera» l'ambizione di costruire «una lingua universale» e demolisce «la fola dell'amore universale, del bene universale, col qual bene ed interesse, non può mai congiungersi il bene e l'interesse dell'individuo». Nella Palinodia al marchese Gino Capponi ironizza su «universale amore, ferrate vie, moltiplici commerci, vapor, tipi e cholèra» che «i piú divisi popoli e climi stringeranno insieme». In un brano della Storia del genere umano, profetizza: «Mancherà dalla vita umana ogni valore, ogni rettitudine, così di pensieri come di fatti; e non pure lo studio e la carità, ma il nome stesso delle nazioni e delle patrie sarà spento per ogni dove; recandosi tutti gli uomini, secondo che essi saranno usati di dire, in una sola nazione e patria, come fu da principio, e facendo professione di amore universale verso tutta la loro specie; ma veramente dissipandosi la stirpe umana in tanti popoli quanti saranno uomini. Perciocché non si proponendo né patria da dovere particolarmente amare, né strani da odiare, ciascheduno odierà tutti gli altri, amando solo, di tutto il suo genere, se medesimo. Dalla qual cosa quanti e quali incomodi sieno per nascere, sarebbe infinito a raccontare».
Del resto, sempre nello Zibaldone, dichiara: «L'amore universale, distruggendo l'amor patrio, non gli sostituisce verun'altra passione attiva». E, anticipando il dibattito sullo ius soli con acume quasi profetico, tuona: «Quando tutto il mondo fu cittadino Romano, Roma non ebbe più cittadini; e quando cittadino Romano fu lo stesso che cosmopolita, non si amò né Roma né il mondo: l'amor patrio di Roma, divenuto cosmopolita, divenne indifferente, inattivo e nullo: e quando Roma fu lo stesso che il mondo, non fu più patria di nessuno, e i cittadini Romani, avendo per patria il mondo, non ebbero nessuna patria».
La patria è in effetti il vero antidoto all'omologazione universale. Infatti, «senza amor nazionale non si dà virtù grande». Non è un caso, del resto, che i suoi Canti si aprano esattamente con un'ode All'Italia: «O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi i nostri padri antichi».
E, affinché non sembri un vago slancio sentimentalistico, si lascia andare a uno slancio guerriero e patriottico decisamente estraneo allo stereotipo del poeta malaticcio e imbelle: «Nessun pugna per te? non ti difende nessun de' tuoi? L'armi, qua l'armi: io solo combatterò, procomberò sol io. Dammi, o ciel, che sia foco agl'italici petti il sangue mio». Che non si tratti di mera licenza poetica lo si capisce leggendo le pagine dello Zibaldone in cui spiega il declino italiano con il fatto che il Belpaese non ha «milizia propria». Si sentiranno venir meno, poi, i lettori buonisti che incappino in passaggi come questo: «Dovunque si è trovato amor vero di patria, si è trovato odio dello straniero». E ancora: «La società non può sussistere senz'amor patrio, ed odio degli stranieri». Ma non fatelo sapere agli studenti italiani: l'immagine del poeta sfigato potrebbe risentirne. A quel punto i professori svogliati sarebbero costretti a studiare.