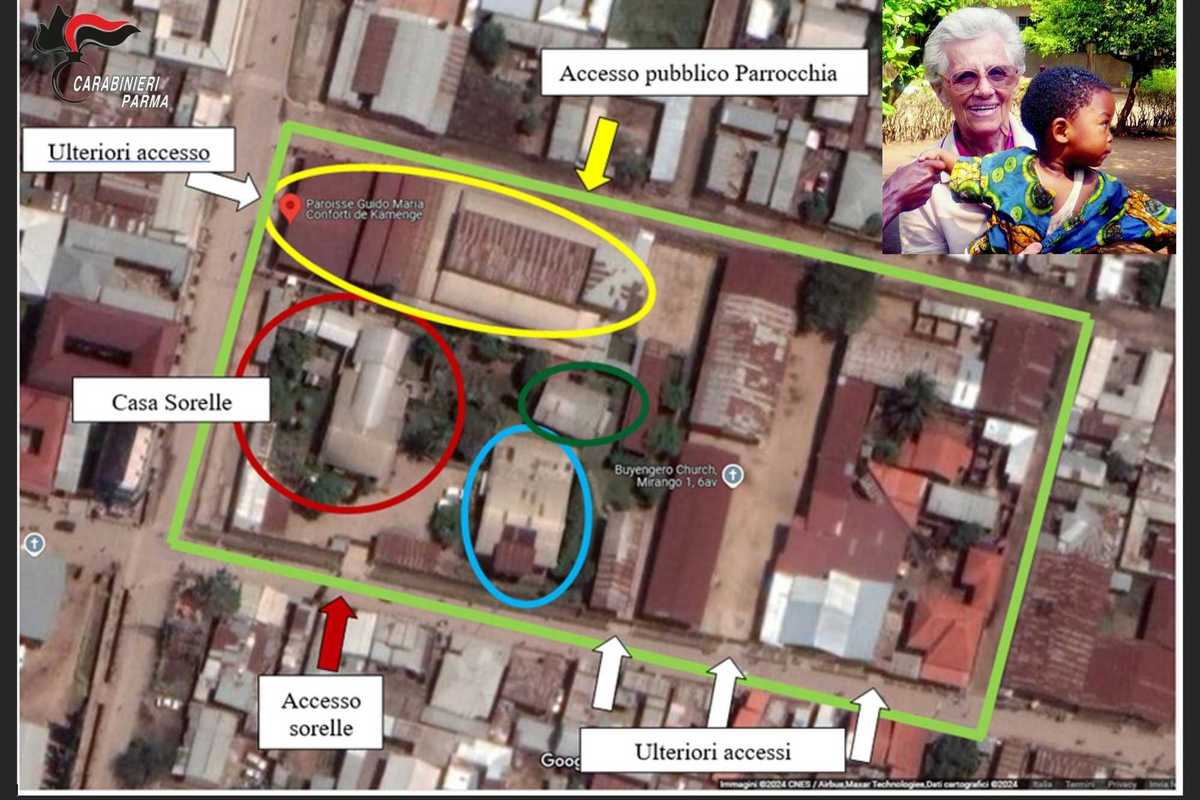Bakayoko perquisito, caos ridicolo. Chi grida al razzismo va in fuorigioco

Il razzismo immaginario continua, purtroppo, a farsi strada. Ieri ha invaso i social network il video girato da un automobilista che, all’alba dello scorso 3 luglio, aveva immortalato il controllo di polizia condotto a Milano da tre agenti su Tiémoué Bakayoko, giocatore ivoriano del Milan. Nel breve filmato, 42 secondi in tutto, si vedono tre agenti, due uomini e una donna, che sono appena scesi da due auto della Polizia di Stato e hanno bloccato un suv scuro da cui hanno fatto uscire un nero alto, barbuto, che indossa una maglietta verde e ha un cappello da pioggia calcato sugli occhi.
L’agente donna impugna la pistola e, senza parlare, la punta a due mani attraverso il finestrino anteriore destro del suv, verso il posto dove si presume sia ancora seduto il conducente. Nel frattempo, quello che s’intuisce sia il capo pattuglia dà le spalle al suv e con la mano sinistra perquisisce l’uomo con la maglietta verde, mentre con la destra appoggiata alla sua spalla lo tiene premuto contro un’auto. Il terzo agente, la Beretta d’ordinanza in mano, gira attorno all’auto bloccata e controlla la situazione da un altro punto di vista.
Insomma, siamo in presenza di un serio controllo di Polizia che, però, non ha assolutamente nulla di concitato o di violento, né di aggressivo: i poliziotti sono decisi ma calmi, professionali. La scena, soprattutto, dura pochissimo, una vera manciata di secondi. Perché quasi subito i due agenti ripongono le armi nelle fondine. Uno dei due, forse, ha parlato con il conducente del suv e rivolge poche parole al capo pattuglia, il quale a quel punto fa una faccia stupita, e dal labiale pare dica: «Chi è?!?». Quindi guarda in faccia il fermato, alza gli occhi al cielo, smette di perquisirlo e gli dà una leggera pacca sulla spalla.
Fine del video. E inizio di un’indegna bagarre. Perché ieri, su internet, queste poche immagini sono bastate a scatenare il partito degli antirazzisti in servizio permanente, sponda italiana dell’estremismo ideologico alla Black lives matter. Nemmeno avessero assistito a una replica milanese del fermo di George Floyd, il nero morto nel maggio 2020 a Minneapolis per la brutalità di un controllo di polizia, in tanti sui social network si sono messi a gridare alla «discriminazione» e al «razzismo istituzionale». Banalità del tipo: «Se hai la pelle chiara, certe cose non ti succedono», che in realtà denotano solo l’intimo razzismo di chi ha creduto che Bakayoko sia stato fermato solo perché nero. C’è chi ha protestato per il controllo «invasivo». Chi ha criticato «la violenza» degli agenti, mentre altri li hanno accusati al contrario di avere mollato la presa non appena hanno scoperto che il perquisito era un noto calciatore.
Il caso ha scomodato perfino Amnesty International, l’organizzazione che a livello globale dovrebbe occuparsi (seriamente) di diritti civili: «Le immagini del fermo di Bakayoko», ha scritto Amnesty in un proclama grondante indignazione, «fanno pensare a una profilazione etnica: una pratica discriminatoria che su una persona non famosa avrebbe potuto avere conseguenze gravi».
Profilazione etnica, nientemeno. Pratica discriminatoria, addirittura. In realtà, le cose sono andate in modo del tutto diverso. A Milano, domenica 3 luglio, sono quasi le 6 di mattina e nella zona tra piazza Gae Aulenti e corso Como, tra alcuni spacciatori senegalesi si accende una rissa violenta, pare con tanto di sparatoria. La nota radio della questura è chiara: i testimoni dello scontro indicano concordi «due uomini a bordo di un suv: uno dei due è centrafricano e indossa una maglietta verde». Le volanti accorrono e in via Luigi Sturzo (a poche centinaia di metri dal luogo della rissa) fermano il suv che a bordo ha Bakayoko con il cappello tondo che gli copre il volto e la maglietta verde. E nero è anche il conducente del veicolo.
Questa è la banale verità. Eppure, ieri mattina, la violenza del coro di critiche ha costretto la questura di Milano a un comunicato di risposta: «Il controllo effettuato da un equipaggio a carico del calciatore Bakayoko è avvenuto in un contesto operativo che giustificava l’adozione delle più elevate misure di sicurezza, anche in funzione di autotutela, e si è svolto con modalità assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme in atto. Identificata la persona, e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva, il servizio è ripreso regolarmente, senza alcun tipo di rilievo da parte dell’interessato».
A voce, gli agenti aggiungono che il controllo è scattato solo perché Bakayoko e l’altro passeggero del suv «corrispondevano perfettamente alle descrizioni, ed è terminato non appena ci si è resi conto di aver fermato una persona che non c’entrava nulla».
Poteva mancare a questa storia assurda l’inutile commento del sindaco, Giuseppe Sala? Certo che no. Al primo cittadino di Milano non è bastata nemmeno la nota della questura: «Ho visto il video, ma non ho parlato con il questore», ha opposto Sala ai giornalisti che lo interrogavano, «e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore…». Aspettiamo.