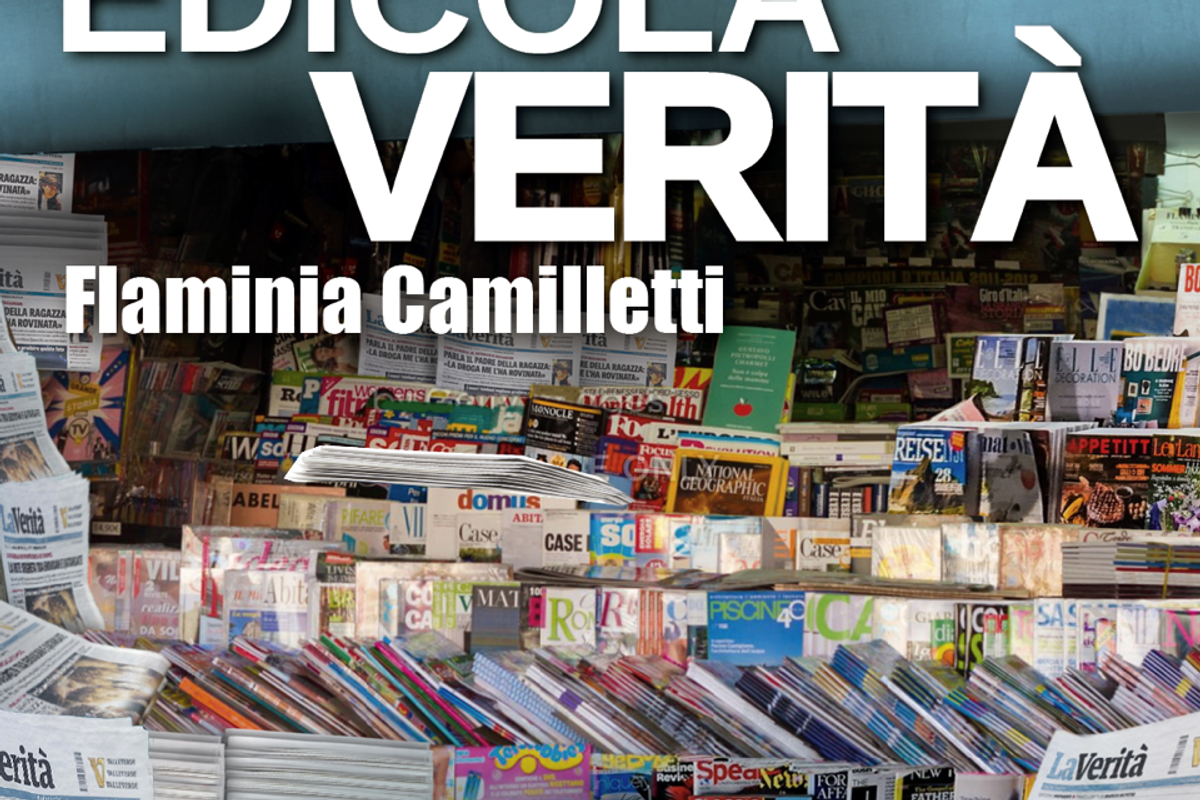2024-03-26
Dobbiamo difendere i nostri sepolcri dall’assalto nichilista del «lutto laico»
Ritratto di Ugo Foscolo (Getty Images)
L’Unione atei scorda Foscolo: vuole espellere la religione da arte e riti funebri. I radicali: la «dolce morte» sia diritto in tutta l’Ue.Ci era rimasta la morte; vogliono toglierci pure quella. Le altre tradizioni, religiose e parareligiose, le stanno già rimuovendo dallo spazio pubblico. A cominciare dalla scuola, cioè da dove si educano i bambini: niente preghiere, se no si offendono le confessioni diverse; niente San Giuseppe, alias festa del papà, se no si offendono le famiglie arcobaleno. E adesso, dalla culla, stanno arrivando alla tomba: vogliono «laicizzare» la morte.È la proposta dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar), che ha indetto un bando per selezionare opere d’arte finalizzate «alla costruzione di un immaginario laico legato alla rappresentazione del lutto e della morte». Con l’occasione, l’associazione ne approfitta per chiedere che siano «ben distribuite nel territorio nazionale» le sale del commiato, nelle quali svolgere esequie non religiose. Che dire: in certi casi, il funerale rischia di essere di una tristezza unica. Ma accantonati i dettagli sugli ultimi saluti, la questione è profonda. La civiltà umana ha sempre mantenuto, nei confronti della fine della vita, una postura spirituale. Del passaggio di tanti popoli antichi, non ci resta che questo: il modo in cui seppellivano i loro defunti, le credenze che avevano maturato sull’aldilà. Le necropoli: la cultura sedimentatasi intorno alla morte è l’unica testimonianza dell’esser stati in vita.L’età della ragione, che l’Uaar venera con una fede non meno dogmatica di quella dei cristiani, pensò di poter liberare le persone dal giogo della superstizione. E invece le ha piombate nell’oscuro sconforto del nichilismo.Agli atei razionalisti è consigliata la rilettura del carme Dei sepolcri (1807) di Ugo Foscolo. Un illuminista, materialista, meccanicista, al quale l’era dei lumi consegna soltanto l’angoscia dinanzi alla vertigine del «nulla eterno».Quando Napoleone - anche lui in nome dell’inclusione - vieta le iscrizioni sulle lapidi, applicando ai cimiteri lo spietato egualitarismo giacobino, il poeta reagisce. A chi servono le tombe? Ai cadaveri? No, ammette: il «sonno» di costoro, «dentro l’urne», non è «men duro». Il culto delle sepolture non aiuta chi va, ma chi resta. Quelle dei grandi ispirano: «A egregie cose il forte animo accendono». Quelle dei piccoli, almeno, proteggono una «corrispondenza d’amorosi sensi», l’ultimo, indissolubile, misterioso vincolo che unisce i vivi ai trapassati. Una «celeste dote», la chiama Foscolo; mica un’offesa alla sensibilità degli agnostici. Se ne fosse ricordato il Papa, che aveva evitato diligentemente il segno della croce alla «camera ardente laica» di Giorgio Napolitano.Ognuno affronta a modo suo la separazione dai propri cari; ognuno ha l’inalienabile facoltà di esprimere, coi dipinti, la fotografia, le sculture, la sua sensibilità. Però il «lutto laico» è una gigantesca negazione. Nega il fondamento dell’umanità stessa, se è vero che l’esistenza autentica è un «vivere per la morte», in un rapporto costante, forse morboso, con la consapevolezza della dipartita - parola del nichilista Martin Heidegger. Non c’è una morte che sia «laica», neutrale, asettica: possiamo solo prendere posizione dinanzi alla nostra finitudine, sia essa la speranza, la resa, o l’irreligiosità militante. È un paradosso dei nostri tempi che si domandino sacrifici per diventare ecologici, nell’interesse delle generazioni future, mentre si cerca di spezzare la catena che ci unisce a quelle precedenti. Invece aveva ragione Edmund Burke: «La società è un sodalizio tra i viventi, i morti e quelli che devono ancora nascere».La «rappresentazione del lutto e della morte», allora, non può essere «laica», per il semplice fatto che è rimarrà lo sforzo di relazionarsi a un abisso inconoscibile: la ragione può portarci fino al ciglio del precipizio, ma poi è di un’altra natura l’occhio interiore che si sporge oltre il confine. Chi adotta la teoria dell’interruttore che si spegne sta offrendo una prospettiva ugualmente ideologica. E perché, d’altronde, egli seppellisce un corpo che non dovrebbe essere più niente? Perché sente l’obbligo di onorarlo? È questo l’innato e ineludibile istinto religioso: religio, in latino, indica «rispetto», «scrupolo», «dovere sacro».Un analogo affronto alle radici dell’umano vogliono portarlo gli attivisti pro eutanasia (l’Associazione Luca Coscioni e altre 28 Ong), che lanciano una petizione al Parlamento Ue affinché «la morte assistita volontaria» sia inclusa nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Come Emmanuel Macron vorrebbe si facesse con l’aborto.Ritorniamo al cortocircuito. Noi siamo una civiltà che rimuove la morte: la morte è un tabù, non se ne parla, non ci si pensa, non la si vuol vedere nella sofferenza del malato da sopprimere pietosamente. Tuttavia, siamo anche una civiltà tanatocratica, che riduce la morte alla sua amministrazione burocratica e la mette in cima all’agenda politica. Sembrerebbe un sintomo allarmante dell’epoca del tramonto. Eppure, le difese dei sepolcri, della vita nascente, della dignità di quella morente, ancorché solitarie, sono fiammelle che ridanno chiarore alle tenebre. Forse, siamo ancora capaci di coltivare la dolce fiducia di una vecchia incisione, divenuta il motto dell’editore Loescher: «È bello doppo il morire vivere anchora».
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 17 novembre con Flaminia Camilletti
Benjamin Netanyahu (Ansa)