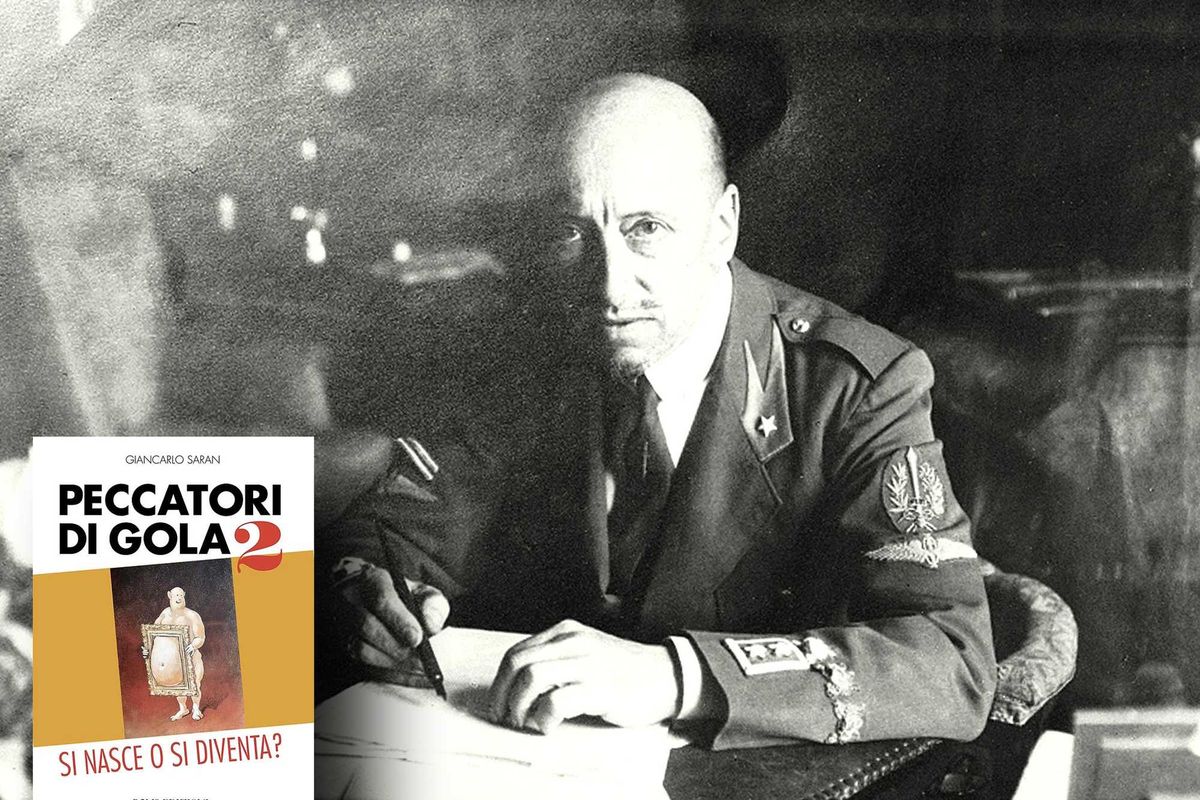«Attaccano la proprietà privata per togliere la libertà agli uomini»

- La durissima accusa dell’Osservatorio internazionale cardinale Van Thuan: «L’ecologismo esasperato e il pauperismo sono le armi per assoggettare gli individui. Lo Stato non può decidere della vita altrui».
- Il vicepresidente dell'Osservatorio Don Samuele Cecotti: «Anche il principio della solidarietà è stato deformato e strumentalizzato in chiave centralista. Bisogna salvaguardare i corpi intermedi».
Lo speciale contiene due articoli.
È in atto una guerra alla proprietà privata: condotta da un macro-capitalismo globalizzato, nasce dalla necessità di ridisegnare un sistema economico fallito e mira ad assoggettare gli individui, dopo averli spossessati non solo dei loro averi ma financo della loro dignità, rendendoli in tutto dipendenti dal sistema. Questo attacco si serve di ideologie travestite da valori - l’ecologismo presentato come cura dell’ambiente, il pauperismo camuffato da principio di condivisione - per ottenere i suoi scopi.
Ruota attorno a queste considerazioni l’ultimo bollettino dell’Osservatorio internazionale cardinale Van Thuan sulla dottrina sociale della Chiesa, rivista monografica trimestrale che propone una rassegna di contributi su argomenti di attualità e spin-off del Rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo che - sempre a cura dell’Osservatorio - dal 2009 annualmente analizza e sviluppa una tematica sociale emergente a livello mondiale attraverso studi e cronache di esperti dei cinque continenti.
In continuità con le precedenti riflessioni sul controllo sociale, che avanza servendosi di nuove modalità tecnologiche insinuantisi nei meccanismi psicologici (durante la pandemia erano gli stessi cittadini a sollecitare la verifica del green pass per fruire dei loro diritti, partecipando così a una forma di «totalitarismo consensuale»), nel primo bollettino del 2023 l’Osservatorio considera le sorti della proprietà privata in un contesto occidentale sempre più influenzato dal «modello cinese», per concludere che l’odio ideologico verso questo principio di diritto naturale è più vivo che mai.
Alla base vi sono motivazioni economiche, ma anche una certa visione antropologica: come nota nella sua analisi l’arcivescovo emerito Giampaolo Crepaldi, senza l’aggancio alla proprietà - un diritto naturale che le rende libere e permette loro di avere uno spazio vitale - la persona e le famiglie diventano solo dei terminali di una politica, statale o globale, che può manipolarle, condizionarle e ricattarle.
Quanto alle logiche economiche del grande reset in corso, come spiega Gianfranco Battisti (già docente universitario di Geografia politica ed economica) esse vanno ricercate nel collasso del sistema americano-centrico iniziato negli anni Settanta e continuato negli Usa con il progressivo disinvestimento dalle industrie e la finanziarizzazione dell’economia. A ogni crisi susseguitasi nel tempo si è reagito a colpi di conflitti in giro per il mondo per «ravvivare» l’economia, di ricapitalizzazione delle banche con denaro pubblico, di speculazioni finanziarie. Il Covid e la guerra in Ucraina sarebbero dunque eventi previsti e parte di una trasformazione per riorganizzare l’intera economia mondiale passando anche attraverso l’abolizione della proprietà privata e la sua concentrazione in pochissime mani. Dietro questo odio per la proprietà privata - osserva il saggista José Antonio Ureta - si cela l’odio per la signoria, di cui la proprietà privata è un’espressione: ciò che si odia è proprio il suo carattere di «dominio», termine che evoca dominus, cioè signore. Una società in cui la stragrande maggioranza è proprietaria, ha il dominio su se stessa e, quindi, condizioni migliori per formare un popolo dalle personalità vigorose e definite. L’opposto dell’uomo massa dei regimi totalitari o degli odierni volontari schiavi digitali dell’ultima moda planetaria.
Non siamo tanto davanti a un vero piano per abolire la proprietà privata - avverte il giornalista Stefano Magni - quanto piuttosto a «una cultura ad essa contraria e favorevole a una nuova economia circolare», che è diffusa in ambito Onu e fondazioni collegate (World Economic Forum in testa), viene paradossalmente portata avanti proprio dal gotha della finanza internazionale e si intravede nell’opera dei legislatori, anche in Italia. Vero che l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite non parla di espropri proletari, ma il documento clou della partnership Onu-Wef rivela una netta volontà dirigista: «da un lato si parla di allineamento dei sistemi finanziari a obiettivi dettati dalla politica, dall’altro si impone una rieducazione dei consumatori perché compiano scelte individuali sostenibili. Lo Stato potrà dunque indirizzare le scelte economiche dei suoi cittadini dettando le regole su come usare le loro proprietà». Proprio ciò che accade con la nuova direttiva della Commissione europea sull’efficienza energetica degli edifici: l’Europa non espropria gli immobili dei proprietari ma, di fatto, i proprietari di immobili dovranno seguire le indicazioni energetiche di Bruxelles se vorranno disporne ad un prezzo ragionevolmente equo sul mercato.
«Tutti oggettivi limiti al diritto di proprietà», argomenta l’ex politico Luca Volonté, per il quale «l’ideologia verde, sempre più rossa, che si è insediata a Bruxelles stravolge il significato della proprietà privata: quella dei cittadini europei è considerata un bene disponibile di cui il Super-Stato si può appropriare e sul quale può imporre i propri desideri».
Ad inquinare le acque gioca poi la mescolanza del discorso «etico» a quello economico, che trasforma il principio della condivisione in un feticcio: Magni osserva come l’economia fondata sulla proprietà privata sia considerata gretta, statica, egoista; e come l’economia della condivisione sia invece «fondata sul dono» e sull’aiuto, venendo dunque presentata come altruista e giovane. Con il risultato che «l’argomento ecologista rafforza quello altruista: se si compra e si consuma, si inquina, se si condivide, si inquina meno». Ma un’economia della condivisione, caratterizzata da un cambiamento continuo, è nemica di quella stabilità propria delle società fondate su famiglie che pianificano nel lungo periodo. Si risveglia così il sogno della «comune», tipica di tutte le società socialiste, e si afferma uno strano capitalismo anticapitalista che assume le tinte verdi del nuovo statalismo e parla con i suoi argomenti collettivisti.
«La famiglia è l’ultimo baluardo»
«Il cambiamento d’epoca che stiamo attraversando esige un obbligo di svolta», disse due anni fa papa Francesco. Quale contributo in questo senso può venire dalla dottrina sociale della Chiesa? Ne parliamo con il vicepresidente dell’Osservatorio Van Thuan, don Samuele Cecotti.
«La dottrina sociale è l’insegnamento, facente riferimento al diritto naturale illuminato dalla fede rivelata, che la Chiesa dà sulle questioni della vita associata degli uomini: in questa nostra epoca è particolarmente importante perché siamo in una fase complessa, di grandi mutamenti e di radicale scristianizzazione. Conoscerla e applicarla ci permette di attuare quell’opera di evangelizzazione del sociale che ci dovrebbe condurre, nel tempo, a veder rifiorire una societas cristiana, cioè un Cristianesimo non confinato nella dimensione puramente individuale ma che si fa cultura, società, istituzioni, leggi».
Oggi si tende ad affermare il carattere secondario della proprietà privata rispetto alla destinazione universale dei beni, laddove si tratta di principi che dipendono reciprocamente in un rapporto paritetico e complementare…
«Viviamo in un’epoca segnata dalla perversione dei termini più nobili. Il principio di solidarietà, ad esempio, viene deformato: non è più un rapporto libero tra esseri personali ma diventa imposto attraverso l’operato invasivo dello Stato. Pensiamo alla questione del welfare: per la dottrina sociale della Chiesa questo ambito dovrebbe rientrare nella libera iniziativa dei corpi sociali intermedi, in un’azione di mutua solidarietà. Gli Stati invece hanno assorbito queste funzioni, facendole diventare di propria competenza e quella che era una dinamica sociale libera diventa un obbligo di legge che ci costringe a partecipare con tasse, contributi pensionistici e altro. Lo stesso accade con la condivisione: una dinamica positiva all’interno di gruppi e famiglie diventa un principio ideologico che viene imposto attraverso agende politiche che poi dettano norme e leggi».
Si parla di un deep State globale, ovvero centri di potere transazionali non istituzionali che però condizionano le varie istituzioni determinandone le politiche: quanto è importante la resistenza dei corpi intermedi, in primis la famiglia?
«È cruciale. Come Osservatorio stiamo concentrando le forze sul tema della proprietà privata proprio perché qui si gioca buona parte della battaglia: essa è lo strumento che consente all’individuo e alle famiglie di essere liberi e autonomi perché dispongono di beni di sussistenza che consentono questa indipendenza. Lo stesso vale per altri corpi sociali intermedi: pensiamo a cosa erano le comunità locali, i municipi, le associazioni professionali… avevano un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse. Questo è stato via via assorbito dallo Stato e oggi nemmeno da quello nazionale ma da entità sovrastatali che decidono e gestiscono denari, svuotando le famiglie e i corpi sociali delle loro funzioni. Per ogni uomo di buona volontà, cattolico o meno, diventa importante un’azione di resistenza, prima di tutto culturale e poi compiendo delle scelte concrete: sul bollettino, l’imprenditrice Benvenuta Plazzotta sottolinea proprio il valore delle imprese a conduzione famigliare, dell’artigianato, del piccolo commercio, della imprenditorialità diffusa che si basa in maniera più diretta sulla proprietà privata. Quella che ha generato il tessuto economico e sociale che ha fatto grande l’Italia».