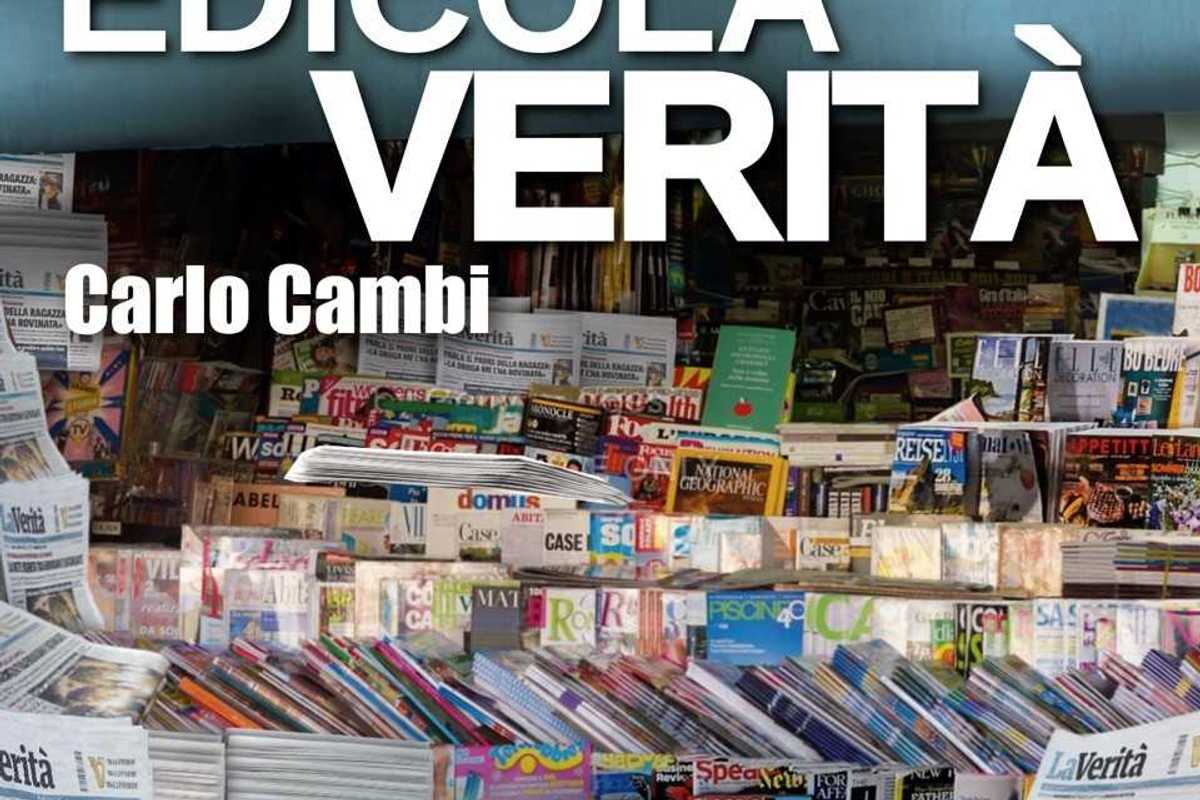Gli ateniesi «nati dalla terra»: le origini etnocentriche della democrazia antica
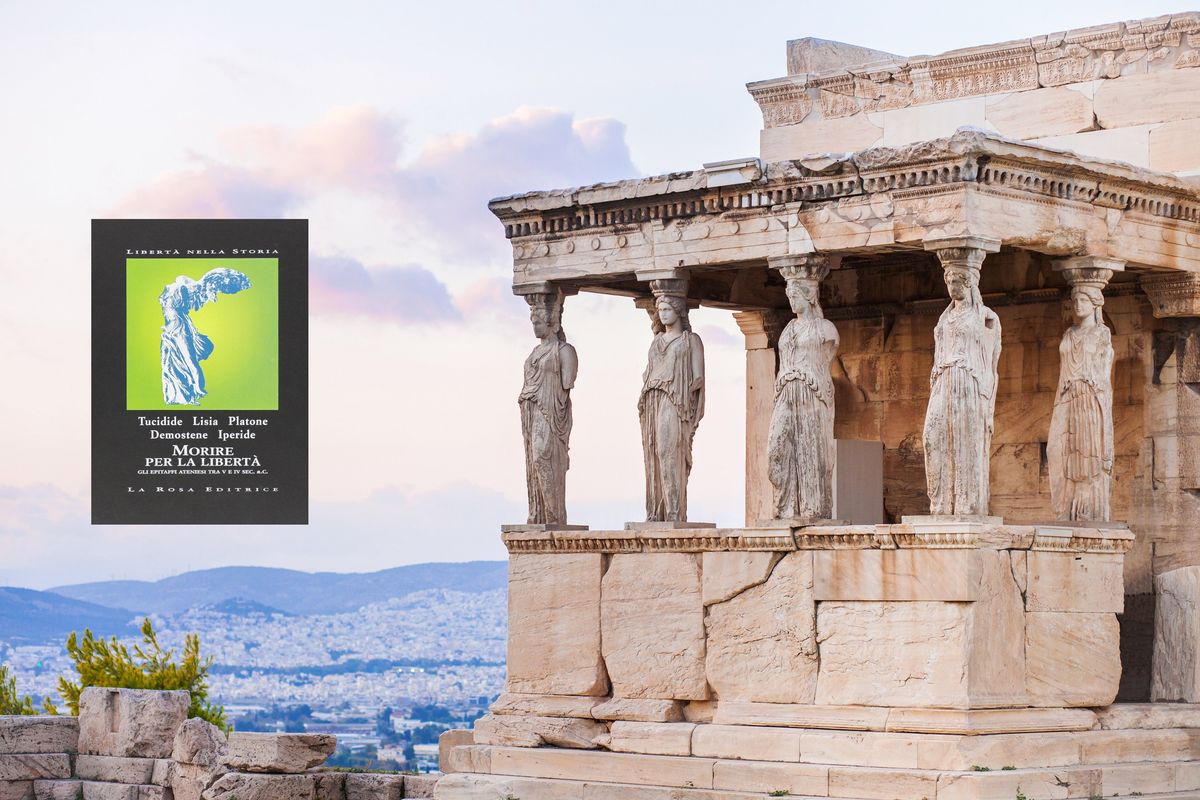
In certi resoconti storici, l’Atene classica sembra quasi una sede del Pd. La realtà era ben diversa: la capitale ellenica si basava sul mito «politicamente scorretto» dell’autoctonia.
Spartani fascisti, ateniesi democratici. Sin dai banchi del liceo, la storia greca ci è arrivata più o meno secondo queste categorie basilari. Da una parte una struttura militare, spietata, in cui la cultura non è onorata in alcun modo, dall’altra una polis in cui filosofi e cittadini coscienziosi si vedono continuamente nell’agorà per discettare del bene comune. Come spesso accade, tuttavia, lo schemino manicheo non regge alla prova di un esame storico più approfondito.
Per avere una idea meno condizionata da stereotipi moderni di quella che doveva essere l’Atene classica bisogna dare un’occhiata a un libro uscito diverso tempo fa: Morire per la libertà. Gli epitaffi ateniesi tra V e IV secolo a.C. (La Rosa editrice), a cura di Francesco Ingravalle. L’epitaphios logos, specialità retorica che la tradizione vuole esclusivamente ateniese, era un’orazione che veniva recitata da un individuo scelto dalla polis, al Ceramico, il cimitero di Atene, di fronte alla stele che si era soliti dedicare alle tombe collettive dei caduti in una battaglia. Ai cittadini che tornavano alla terra si ricordava che quella terra li aveva generati. Era il mito (che con linguaggio moderno definiremmo etnocentrico e xenofobo) dell’autoctonia. Ovvero la credenza che gli ateniesi fossero letteralmente nati dalla terra della loro città.
Nel suo epitaffio per i caduti in difesa dei Corinzi, Lisia spiega che gli antenati degli ateniesi «non abitavano una terra straniera a loro dopo averne cacciato altri ed essersi raccolti da ogni dove, come molti, ma, autoctoni, ebbero la stessa terra come madre patria» (17-18). Così, invece, Demostene parla dei caduti di Cheronea: «La nobile nascita di costoro è riconosciuta da parecchio tempo da tutti gli uomini. Non solo, infatti, è possibile per loro risalire, caso per caso, lungo la linea paterna e dei remoti antenati dal punto di vista naturale, ma perché hanno la patria in comune, tutti sono d’accordo nel sostenere che sono autoctoni. Tra tutti gli uomini essi solo nacquero da essa, la abitarono e la tramandarono ai loro discendenti, sicché si potrebbe giustamente sostenere che coloro che sono emigrati e sono giunti nella città e sono denominati cittadini siano simili ai bambini adottati; questi, invece, sono cittadini della loro terra naturale» (1390, 4). Iperide si limita ad affermare che «parlando degli Ateniesi, la loro autoctonia, la loro comune origine, garantisce l’insuperata bontà della stirpe» (IV, 7).
E, seppur venato di intenti satirici, anche l’epitaffio immaginario riportato da Platone merita di essere menzionato: «La loro buona nascita, anzitutto, derivò dall’origine dei loro antenati che non erano immigrati, né i loro discendenti furono dei meteci nella terra ove sarebbero venuti dal di fuori, ma autoctoni, abitanti e viventi davvero nella loro patria e nutriti non da una matrigna, come gli altri, ma dalla terra madre in cui abitavano e ora giacciono, dopo la morte, nei luoghi familiari in cui essa li generò, li nutrì, li ospitò» (Menesseno, 237 b).
Come si vede, l’autoctonia delinea una sorta di nobiltà di massa, in quanto estende i natali nobili a tutto un popolo di cittadini. È questo il senso della «democrazia ateniese», che pure di tanto in tanto qualcuno tira fuori oggi nell’ambito di discorsi politicamente corretti che avrebbero fatto inorridire i Greci del V secolo a.C. «Si pensi», scrive Francesco Ingravalle nella introduzione, «a come, nell’epitaffio, il mito democratico dell’autoctonia ateniese sia il corrispettivo dell’eugeneia (“nobiltà”) aristocratica: come dall’autoctonia deriva l’arete del demos, così dall’eugeneia deriva la virtù dell’aristocratico. C’è addirittura chi, come Demostene, democratico, non differenzia per nulla autoctonia e eugeneia. L’autoctonia fa degli ateniesi i soli elleni autentici, costituisce il fondamento del loro diritto all’egemonia e spiega l’odio contro i barbari».
È questo mito, quindi, a fondare la democrazia ateniese, che può essere vera democrazia solo se è veramente ateniese, dato che gli ateniesi sono democratici in quanto autoctoni, nati proprio da quella terra: non genericamente gheghenéis, nati dalla terra, ma da un «suolo» straordinario. Solo gli ateniesi, quindi, possiedono l’areté, la virtù politica perfetta, perché l’Attica è la terra dalla quale è nato il loro antenato diretto, il figlio della Parthénos. Ad Atene, è ugualmente il mito dell’autoctonia che giustifica la stretta sulla cittadinanza, voluta dalla legge di Pericle del 451/50, che limitava l’accesso al corpo dei cittadini di pieno diritto ai soli figli di padre e madre ateniese. «Un solo génos», commenta Nicole Loraux, «ma di razza pura. Un génos a misura di città, dal quale tutti i membri ereditano allo stesso titolo la nobiltà propria alle famiglie aristocratiche».