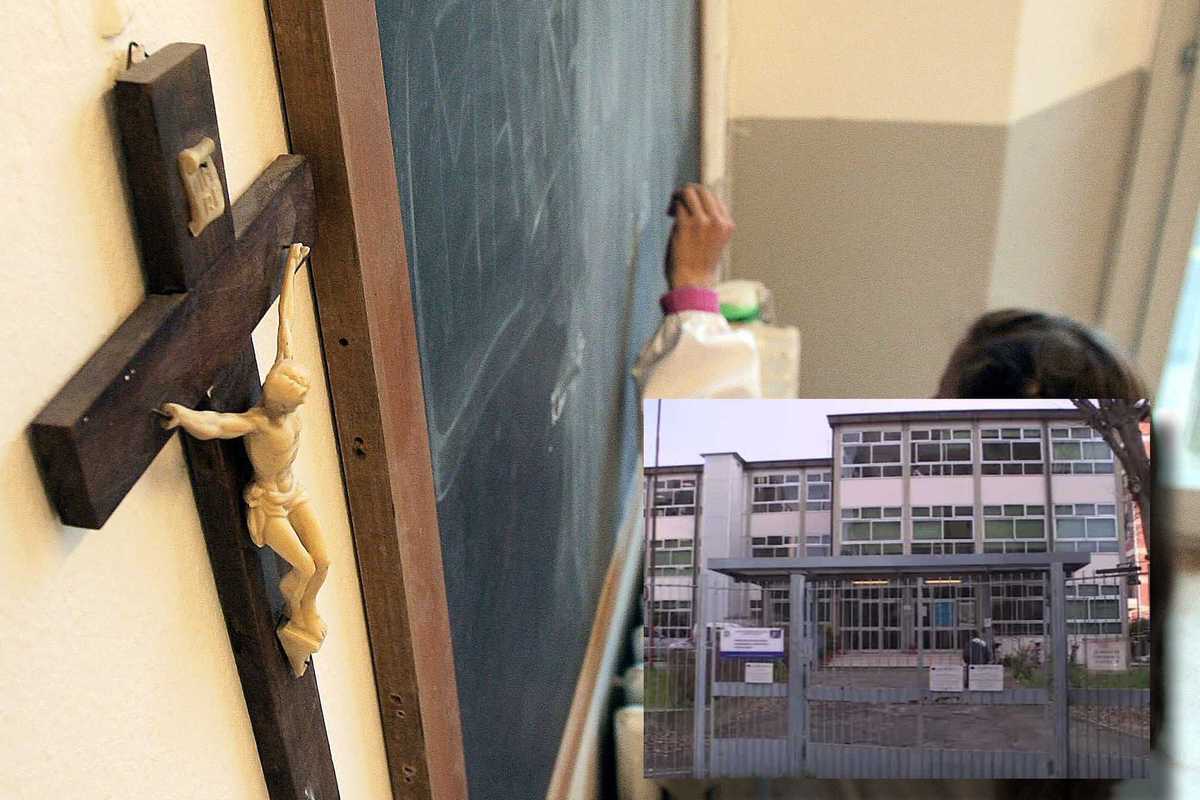True
2022-05-23
Quando le «brigate rosse giapponesi» colpirono in Italia
True
Napoli: il luogo dell'attentato dell'aprile 1988. Nel riquadro la terrorista rossa giapponese Fusako Shigenobu (Ansa)
A Calata San Marco, a due passi da Piazza del Municipio nel cuore di Napoli, erano le 19.56 del 14 aprile 1988 quando si scatenò l’apocalisse di fronte all’ingresso dell’USO, il centro ricreativo delle truppe americane di stanza nella città partenopea. Doveva esserci ancora luce quella sera, ma dopo una violentissima esplosione l’aria si fece scura per la polvere e i detriti sollevati dalla deflagrazione di un’autobomba. Sul terreno rimasero cinque morti e quindici feriti, di cui quattro cittadini italiani che si trovavano a transitare in quel momento, oltre ad una soldatessa americanai. L’attentato, subito rivendicato dalla jihad filopalestinese, in realtà presentava un indizio che portava altrove. Se da una parte la pista che indirizzava al terrorismo mediorientale era supportata dai numerosi attentati seguiti al bombardamento americano di Tripoli del 1986, già nelle ore successive si capì che la mano era asiatica. Un marinaio della Sesta flotta americana aveva visto il sospetto attentatore: un uomo sui quarant’anni dalla pelle olivastra, che si era allontanato furtivamente dopo aver lasciato in sosta l’auto che poco dopo sarebbe esplosa. Durante la notte gli investigatori ricevettero foto segnaletiche di terroristi dai tratti asiatici e poco dopo la verità venne a galla. A piazzare la bomba era stato un cittadino giapponese, già protagonista di altri attentati negli anni precedenti. Aveva soggiornato in un albergo modesto nei vicoli del ventre di Napoli e aveva noleggiato sotto falso nome due auto, la prima usata come autobomba e la seconda usata per lasciare subito la città. Si trattava del maxiricercato Junzo Okudaira, uno dei capi del gruppo terroristico comunista «Armata Rossa Giapponese». Okudaira aveva agito l’anno prima in Italia, contemporaneamente contro l’Ambasciata americana e quella Britannica. Da una stanza dell’hotel Ambasciatori il terrorista nipponico aveva colpito con un mortaio a tempo Villa Margherita. Con un arma identica nascosta in uno scatolone aveva fatto partire due granate contro l’Ambasciata del Regno Unito. Infine aveva fatto saltare l’auto presa a noleggio imbottita con due chili di tritolo e soltanto per un caso l’attentato non fece vittime. A Napoli invece morirono oltre alla soldatessa Angela Santos, tre passanti ed un venditore ambulante conosciuto da tutto il quartiere, Antonio Gaezza detto «Popeye». Gli altri tre morti erano dipendenti della società Italgrani, di ritorno da una riunione: Assunta Capuano, Maurizio Perrone, Guido Scocozza. Alle origini di quel massacro, una storia partita da lontano, sia nel tempo che nello spazio.
Per meglio comprendere il legame tra una serie di attentati in Italia associati al terrorismo arabo e perpetrati da un gruppo che si firmava «Armata rossa giapponese» è necessario tornare indietro negli anni, nell’ambiente dei campus universitari nipponici della fine degli anni Sessanta. Qui il vento della contestazione in corso nelle università occidentali era arrivato a soffiare su un fuoco mai estinto dalla fine della seconda guerra mondiale, che ardeva sotto le ceneri dell’Impero del sole tramontato e annichilito dalle bombe atomiche. Gli Americani avevano occupato il Paese la cui capitolazione era costata più che in ogni altro fronte in termini di vite umane e resistenza dell’avversario e avevano imposto clausole durissime e l’occupazione militare del generale Douglas MacArthur. Durante gli anni successivi la secolare società giapponese basata sull’onore, il nazionalismo e la gerarchia fu così intaccata dall’introduzione obbligata dei princìpi democratici sul modello americano contenuti nei trattati postbellici. Demilitarizzato e occupato, il Giappone fu spettatore della Guerra Fredda in Asia e dell’avanzata del comunismo cinese risultata nella guerra di Corea. La situazione internazionale fece guadagnare al piccolo partito comunista giapponese (fondato nel lontano 1922 e poi represso negli anni di Hirohito) numerosi seggi nelle prime elezioni libere, destando non poca preoccupazione negli Americani, che dal 1950 al 1960 videro crescere le manifestazioni e le proteste di piazza contro la loro presenza e la nuova società capitalistica, spesso sfociate in episodi di notevole violenza. Alla fine del decennio la nuova generazione di origine borghese degli universitari fu investita da nuove forti motivazioni per la divulgazione del verbo marxista all’interno dei gruppi di studenti. La situazione del Sudest asiatico era esplosa con la guerra del Vietnam e del Laos, con la Cambogia e la Corea del Nord, mentre in Europa le bandiere rosse riempivano le piazze delle città. Nella terra del «nemico capitalista» era inoltre esplosa la questione razziale, che i comunisti giapponesi lessero come un segno di declino del vincitore e un appiglio per un esito rivoluzionario della società americana. Fu in questo clima che gli studenti filomarxisti accrebbero la loro presenza nelle assemblee e nelle piazze di Tokyo e di altre città universitarie. Quella iniziale fu la storia di un grande «blocco comunista», sul modello dei movimenti studenteschi occidentali. L’attività avveniva attraverso grandi assemblee programmatiche alle quali prendeva parte il gruppo dal quale trassero origine i terroristi rossi, la «Lega comunista giapponese». Da questo schieramento mosse i primi passi quella che sarà la futura leader dell’Armata Rossa Giapponese, Fusako Shigenobu. Figlia della piccola borghesia, di bella presenza, Fusako iniziò a frequentare i gruppi marxisti della Lega comunista già nel 1966 iscritta come studentessa lavoratrice. Nel campus conoscerà un «compagno» che diventerà più tardi suo marito e fondatore del gruppo terroristico, Tsuyoshi Okudaira (fratello di Junzo, autore della strage di Napoli). Il nucleo originario di quello che sarà il gruppo delle «brigate rosse» nipponiche, battezzato Sekigun-ha, si fece notare subito dalla polizia per i toni estremamente violenti dei comizi, durante i quali i militanti spesso annunciavano azioni illegali. Più volte le forze dell’ordine fecero irruzione nei campus dove furono rinvenute numerose bottiglie molotov con spranghe e bastoni pronti all’uso. Dal 1969 il Sekigun-ha organizzò anche campi paramilitari nella cittadina montana di Daibosatsu, mentre la crescita della pressione della polizia sulle attività cittadine del gruppo extraparlamentare giapponese iniziò a far maturare nei leader l’idea della clandestinità e della guerra di guerriglia sul modello del generale nordvietnamita Nguyen-Van Giap. Durante lo stesso 1969 l’allora leader e ideologo del Sekigun-Ha Shiomi Takaya delineò gli intenti programmatici del movimento, che consistevano in una forte spinta all’azione dopo la fase fallimentare delle grandi assemblee popolari. L’idea era ambiziosa, utopistica, e si basava sull’idea trotzkista della rivoluzione globale con il coinvolgimento delle forze comuniste di tutti i Paesi. Fu da queste basi ideologiche che nacque una delle caratteristiche peculiari dell’Armata rossa giapponese: la lotta senza frontiere. Fu deciso pertanto che una parte del movimento avrebbe dovuto addestrarsi con gli altri gruppi armati rivoluzionari del mondo (una sorta di legione straniera comunista o come vengono chiamati oggi «foreign fighters»). Per organizzare la nuova fase della lotta armata, dall’inizio del 1970 il gruppo portò a termine numerose rapine per autofinanziamento e sequestri di persona. Il 31 marzo di quell’anno l’Armata rossa giapponese si fece conoscere in tutto il mondo quando dirottò un Boeing 727 delle linee aeree giapponesi JAL. Il sequestro fu rocambolesco e mostrò da una parte le determinazione dei terroristi rossi, dall’altra una certa immaturità nella gestione degli eventi. Sul volo interno 351 da Tokyo a Fukuoka salirono nove membri del gruppo di terroristi rossi. A venti minuti dal decollo estrassero le spade katana e intimarono all’equipaggio di volare fino a Cuba. Informati del fatto che l’autonomia di volo del 727 non permetteva di coprire la distanza, i dirottatori con a bordo 108 passeggeri atterrarono a Fukuoka per rifornirsi e proseguire il dirottamento verso uno scalo alternativo: la capitale della Corea del Nord Pyongyang. Convinti a far sbarcare i passeggeri più deboli, i membri dell’esercito rosso giapponese caddero quindi nella trappola tesa dalle autorità. Come in una fiction, i piloti ebbero l’ordine di atterrare invece a Seoul dove fu preparata una messinscena degna di un set. L’aeroporto della capitale della Corea del Sud fu spogliato di ogni simbolo dell’economia capitalista e al posto delle bandiere di tutto il mondo furono issate quelle della Corea comunista. Sulla pista dello scalo di Kimpo però, i nove terroristi si accorsero dell’inganno in quanto le autorità aeroportuali si erano dimenticate di mostrare un dettaglio fondamentale: mancavano i ritratti dell’allora dittatore comunista Kim-Il Sung. Armati di candelotti di dinamite i militanti dell’esercito rosso giapponese iniziarono una estenuante trattativa per ripartire alla volta di Pyongyang. Fu necessario il gesto volontario del viceministro dei trasporti giapponese Shinjiro Yamamura, che salì sull’aereo scambiandosi con i passeggeri ormai senza cibo da due giorni. Il 727 ripartì alla volta della Corea del Nord dove fu fatto bersaglio da colpi di avvertimento della contraerei comunista. Liberato l’equipaggio e il viceministro, i nove «samurai rossi» trovarono tutt’altro che l’Eden nell’asilo politico, in quanto le autorità nordcoreane non avevano apprezzato il gesto clamoroso di una banda di «trotzkisti» provenienti da un paese considerato nemico.
Il dirottamento del jet rappresentò un punto di svolta per l’organizzazione delle cellule terroristiche giapponesi: da quell’episodio dall’esito negativo per gli obiettivi del gruppo è possibile delineare quelle che furono le caratteristiche peculiari dell’Armata rossa nipponica. Molti aspetti organizzativi derivarono dalla cultura nazionale trasformata dalle influenze occidentali del dopoguerra. Nei mesi successivi al dirottamento si delinearono due storie distinte: quella fallimentare delle cellule operanti sul territorio giapponese e quella che operò in contesto internazionale, molto più agguerrita e efficace. La crisi derivata degli arresti del 1970 fece declinare rapidamente i vertici nazionali dell’ Arg, decimati anche dall’interno da una ferocissima «purga» sul modello stalinista che risultò in un confronto mortale tra le correnti in un rifugio di montagna sequestrato dai terroristi. Il nucleo destinato all’azione terroristica all’estero trovò invece terreno fertilissimo in Medioriente. In quest’ultimo militavano Fusako Shigenobu e il marito Tsuyoshi Okudaira, stabiliti in Libano e addestrati dai palestinesi del Fronte di Liberazione della Palestina. Con la protezione del terrorismo arabo, i giapponesi alzarono il tiro e il 30 maggio 1972, provenienti da Roma, attaccarono l’aeroporto di Tel Aviv-Lod (oggi Ben Gurion). Vestiti da occidentali, Okudaira e compagni estrassero dalle custodie di violino i fucili mitragliatori e uccisero 26 persone, ferendone altre 78. Okudaira, braccato dalla reazione della polizia, si suicidò con una delle bombe a mano. Colpito dalle forze dell’ordine sarà anche uno dei compagni, mentre un terzo complice ferito, fu arrestato e condannato in seguito all’ergastolo.
La strage dell’aeroporto di Tel Aviv fu uno choc che colpì il mondo intero. Anche se l’Armata rossa giapponese fu falciata al vertice con la perdita del leader militare, il suo posto fu preso dalla consorte Fusako Shigenobu, che rimarrà a capo del gruppo fino alla fine. Per tutti gli anni Settanta per proseguire nel decennio successivo, l’Armata rossa giapponese sarà una delle formazioni armate d’élite nel contesto del terrorismo arabo. Questo grazie anche alla sua gestione particolare, di tipo quasi manageriale mutuata dalla storia del Giappone postbellico: la revisione attenta degli errori dai quali trarre insegnamento, lo studio attentissimo delle comunicazioni, le simulazioni (per i dirottamenti aerei i terroristi ricostruirono fedelmente la cabina passeggeri per potersi allenare), lo studio delle coperture e delle residenze affittate prima degli attentati. La scia di dirottamenti e sequestri fu lunga. Nel 1974 fu assaltata l’ambasciata francese all’Aia per ottenere la liberazione di militanti in carcere, nel 1977 il volo Malaysian 653 fu dirottato da un membro dell’Arg e l’azione finì in tragedia: il terrorista uccise i membri dell’equipaggio e fece precipitare l’aereo causando 100 vittime.
La pasionaria rossa Fusako Shigenobu fu arrestata soltanto nel 2000, quando il mondo era cambiato dopo il crollo del muro di Berlino e le «brigate rosse» nipponiche erano ormai in crisi profonda. Per oltre vent’anni la leader terrorista pianificò azioni in costante contatto con le più attive organizzazioni terroristiche: oltre a quelle palestinesi, la giapponese ebbe contatti con gli Armeni separatisti, i Turchi e con le Br italiane. Venuto meno l’appoggio del terrorismo arabo, non senza rimpianto la Shigenobu decise il rientro in clandestinità nel suo Giappone. Qui fu catturata in un albergo e condannata a 20 anni di carcere, senza mai mostrare l’ombra del minimo pentimento. E’ considerata dalla giustizia italiana come il mandante della strage di Napoli il cui esecutore materiale, suo cognato Junzo Okudaira, è ad oggi latitante.
Continua a leggereRiduci
Nata nelle università nipponiche nel 1969, l' «Armata rossa giapponese» fu protagonista di attentati e dirottamenti. Alleato del terrorismo arabo, nell'aprile 1988 il gruppo fece esplodere un'autobomba a Napoli facendo cinque morti. Ebbe come leader una donna. A Calata San Marco, a due passi da Piazza del Municipio nel cuore di Napoli, erano le 19.56 del 14 aprile 1988 quando si scatenò l’apocalisse di fronte all’ingresso dell’USO, il centro ricreativo delle truppe americane di stanza nella città partenopea. Doveva esserci ancora luce quella sera, ma dopo una violentissima esplosione l’aria si fece scura per la polvere e i detriti sollevati dalla deflagrazione di un’autobomba. Sul terreno rimasero cinque morti e quindici feriti, di cui quattro cittadini italiani che si trovavano a transitare in quel momento, oltre ad una soldatessa americanai. L’attentato, subito rivendicato dalla jihad filopalestinese, in realtà presentava un indizio che portava altrove. Se da una parte la pista che indirizzava al terrorismo mediorientale era supportata dai numerosi attentati seguiti al bombardamento americano di Tripoli del 1986, già nelle ore successive si capì che la mano era asiatica. Un marinaio della Sesta flotta americana aveva visto il sospetto attentatore: un uomo sui quarant’anni dalla pelle olivastra, che si era allontanato furtivamente dopo aver lasciato in sosta l’auto che poco dopo sarebbe esplosa. Durante la notte gli investigatori ricevettero foto segnaletiche di terroristi dai tratti asiatici e poco dopo la verità venne a galla. A piazzare la bomba era stato un cittadino giapponese, già protagonista di altri attentati negli anni precedenti. Aveva soggiornato in un albergo modesto nei vicoli del ventre di Napoli e aveva noleggiato sotto falso nome due auto, la prima usata come autobomba e la seconda usata per lasciare subito la città. Si trattava del maxiricercato Junzo Okudaira, uno dei capi del gruppo terroristico comunista «Armata Rossa Giapponese». Okudaira aveva agito l’anno prima in Italia, contemporaneamente contro l’Ambasciata americana e quella Britannica. Da una stanza dell’hotel Ambasciatori il terrorista nipponico aveva colpito con un mortaio a tempo Villa Margherita. Con un arma identica nascosta in uno scatolone aveva fatto partire due granate contro l’Ambasciata del Regno Unito. Infine aveva fatto saltare l’auto presa a noleggio imbottita con due chili di tritolo e soltanto per un caso l’attentato non fece vittime. A Napoli invece morirono oltre alla soldatessa Angela Santos, tre passanti ed un venditore ambulante conosciuto da tutto il quartiere, Antonio Gaezza detto «Popeye». Gli altri tre morti erano dipendenti della società Italgrani, di ritorno da una riunione: Assunta Capuano, Maurizio Perrone, Guido Scocozza. Alle origini di quel massacro, una storia partita da lontano, sia nel tempo che nello spazio. Per meglio comprendere il legame tra una serie di attentati in Italia associati al terrorismo arabo e perpetrati da un gruppo che si firmava «Armata rossa giapponese» è necessario tornare indietro negli anni, nell’ambiente dei campus universitari nipponici della fine degli anni Sessanta. Qui il vento della contestazione in corso nelle università occidentali era arrivato a soffiare su un fuoco mai estinto dalla fine della seconda guerra mondiale, che ardeva sotto le ceneri dell’Impero del sole tramontato e annichilito dalle bombe atomiche. Gli Americani avevano occupato il Paese la cui capitolazione era costata più che in ogni altro fronte in termini di vite umane e resistenza dell’avversario e avevano imposto clausole durissime e l’occupazione militare del generale Douglas MacArthur. Durante gli anni successivi la secolare società giapponese basata sull’onore, il nazionalismo e la gerarchia fu così intaccata dall’introduzione obbligata dei princìpi democratici sul modello americano contenuti nei trattati postbellici. Demilitarizzato e occupato, il Giappone fu spettatore della Guerra Fredda in Asia e dell’avanzata del comunismo cinese risultata nella guerra di Corea. La situazione internazionale fece guadagnare al piccolo partito comunista giapponese (fondato nel lontano 1922 e poi represso negli anni di Hirohito) numerosi seggi nelle prime elezioni libere, destando non poca preoccupazione negli Americani, che dal 1950 al 1960 videro crescere le manifestazioni e le proteste di piazza contro la loro presenza e la nuova società capitalistica, spesso sfociate in episodi di notevole violenza. Alla fine del decennio la nuova generazione di origine borghese degli universitari fu investita da nuove forti motivazioni per la divulgazione del verbo marxista all’interno dei gruppi di studenti. La situazione del Sudest asiatico era esplosa con la guerra del Vietnam e del Laos, con la Cambogia e la Corea del Nord, mentre in Europa le bandiere rosse riempivano le piazze delle città. Nella terra del «nemico capitalista» era inoltre esplosa la questione razziale, che i comunisti giapponesi lessero come un segno di declino del vincitore e un appiglio per un esito rivoluzionario della società americana. Fu in questo clima che gli studenti filomarxisti accrebbero la loro presenza nelle assemblee e nelle piazze di Tokyo e di altre città universitarie. Quella iniziale fu la storia di un grande «blocco comunista», sul modello dei movimenti studenteschi occidentali. L’attività avveniva attraverso grandi assemblee programmatiche alle quali prendeva parte il gruppo dal quale trassero origine i terroristi rossi, la «Lega comunista giapponese». Da questo schieramento mosse i primi passi quella che sarà la futura leader dell’Armata Rossa Giapponese, Fusako Shigenobu. Figlia della piccola borghesia, di bella presenza, Fusako iniziò a frequentare i gruppi marxisti della Lega comunista già nel 1966 iscritta come studentessa lavoratrice. Nel campus conoscerà un «compagno» che diventerà più tardi suo marito e fondatore del gruppo terroristico, Tsuyoshi Okudaira (fratello di Junzo, autore della strage di Napoli). Il nucleo originario di quello che sarà il gruppo delle «brigate rosse» nipponiche, battezzato Sekigun-ha, si fece notare subito dalla polizia per i toni estremamente violenti dei comizi, durante i quali i militanti spesso annunciavano azioni illegali. Più volte le forze dell’ordine fecero irruzione nei campus dove furono rinvenute numerose bottiglie molotov con spranghe e bastoni pronti all’uso. Dal 1969 il Sekigun-ha organizzò anche campi paramilitari nella cittadina montana di Daibosatsu, mentre la crescita della pressione della polizia sulle attività cittadine del gruppo extraparlamentare giapponese iniziò a far maturare nei leader l’idea della clandestinità e della guerra di guerriglia sul modello del generale nordvietnamita Nguyen-Van Giap. Durante lo stesso 1969 l’allora leader e ideologo del Sekigun-Ha Shiomi Takaya delineò gli intenti programmatici del movimento, che consistevano in una forte spinta all’azione dopo la fase fallimentare delle grandi assemblee popolari. L’idea era ambiziosa, utopistica, e si basava sull’idea trotzkista della rivoluzione globale con il coinvolgimento delle forze comuniste di tutti i Paesi. Fu da queste basi ideologiche che nacque una delle caratteristiche peculiari dell’Armata rossa giapponese: la lotta senza frontiere. Fu deciso pertanto che una parte del movimento avrebbe dovuto addestrarsi con gli altri gruppi armati rivoluzionari del mondo (una sorta di legione straniera comunista o come vengono chiamati oggi «foreign fighters»). Per organizzare la nuova fase della lotta armata, dall’inizio del 1970 il gruppo portò a termine numerose rapine per autofinanziamento e sequestri di persona. Il 31 marzo di quell’anno l’Armata rossa giapponese si fece conoscere in tutto il mondo quando dirottò un Boeing 727 delle linee aeree giapponesi JAL. Il sequestro fu rocambolesco e mostrò da una parte le determinazione dei terroristi rossi, dall’altra una certa immaturità nella gestione degli eventi. Sul volo interno 351 da Tokyo a Fukuoka salirono nove membri del gruppo di terroristi rossi. A venti minuti dal decollo estrassero le spade katana e intimarono all’equipaggio di volare fino a Cuba. Informati del fatto che l’autonomia di volo del 727 non permetteva di coprire la distanza, i dirottatori con a bordo 108 passeggeri atterrarono a Fukuoka per rifornirsi e proseguire il dirottamento verso uno scalo alternativo: la capitale della Corea del Nord Pyongyang. Convinti a far sbarcare i passeggeri più deboli, i membri dell’esercito rosso giapponese caddero quindi nella trappola tesa dalle autorità. Come in una fiction, i piloti ebbero l’ordine di atterrare invece a Seoul dove fu preparata una messinscena degna di un set. L’aeroporto della capitale della Corea del Sud fu spogliato di ogni simbolo dell’economia capitalista e al posto delle bandiere di tutto il mondo furono issate quelle della Corea comunista. Sulla pista dello scalo di Kimpo però, i nove terroristi si accorsero dell’inganno in quanto le autorità aeroportuali si erano dimenticate di mostrare un dettaglio fondamentale: mancavano i ritratti dell’allora dittatore comunista Kim-Il Sung. Armati di candelotti di dinamite i militanti dell’esercito rosso giapponese iniziarono una estenuante trattativa per ripartire alla volta di Pyongyang. Fu necessario il gesto volontario del viceministro dei trasporti giapponese Shinjiro Yamamura, che salì sull’aereo scambiandosi con i passeggeri ormai senza cibo da due giorni. Il 727 ripartì alla volta della Corea del Nord dove fu fatto bersaglio da colpi di avvertimento della contraerei comunista. Liberato l’equipaggio e il viceministro, i nove «samurai rossi» trovarono tutt’altro che l’Eden nell’asilo politico, in quanto le autorità nordcoreane non avevano apprezzato il gesto clamoroso di una banda di «trotzkisti» provenienti da un paese considerato nemico. Il dirottamento del jet rappresentò un punto di svolta per l’organizzazione delle cellule terroristiche giapponesi: da quell’episodio dall’esito negativo per gli obiettivi del gruppo è possibile delineare quelle che furono le caratteristiche peculiari dell’Armata rossa nipponica. Molti aspetti organizzativi derivarono dalla cultura nazionale trasformata dalle influenze occidentali del dopoguerra. Nei mesi successivi al dirottamento si delinearono due storie distinte: quella fallimentare delle cellule operanti sul territorio giapponese e quella che operò in contesto internazionale, molto più agguerrita e efficace. La crisi derivata degli arresti del 1970 fece declinare rapidamente i vertici nazionali dell’ Arg, decimati anche dall’interno da una ferocissima «purga» sul modello stalinista che risultò in un confronto mortale tra le correnti in un rifugio di montagna sequestrato dai terroristi. Il nucleo destinato all’azione terroristica all’estero trovò invece terreno fertilissimo in Medioriente. In quest’ultimo militavano Fusako Shigenobu e il marito Tsuyoshi Okudaira, stabiliti in Libano e addestrati dai palestinesi del Fronte di Liberazione della Palestina. Con la protezione del terrorismo arabo, i giapponesi alzarono il tiro e il 30 maggio 1972, provenienti da Roma, attaccarono l’aeroporto di Tel Aviv-Lod (oggi Ben Gurion). Vestiti da occidentali, Okudaira e compagni estrassero dalle custodie di violino i fucili mitragliatori e uccisero 26 persone, ferendone altre 78. Okudaira, braccato dalla reazione della polizia, si suicidò con una delle bombe a mano. Colpito dalle forze dell’ordine sarà anche uno dei compagni, mentre un terzo complice ferito, fu arrestato e condannato in seguito all’ergastolo. La strage dell’aeroporto di Tel Aviv fu uno choc che colpì il mondo intero. Anche se l’Armata rossa giapponese fu falciata al vertice con la perdita del leader militare, il suo posto fu preso dalla consorte Fusako Shigenobu, che rimarrà a capo del gruppo fino alla fine. Per tutti gli anni Settanta per proseguire nel decennio successivo, l’Armata rossa giapponese sarà una delle formazioni armate d’élite nel contesto del terrorismo arabo. Questo grazie anche alla sua gestione particolare, di tipo quasi manageriale mutuata dalla storia del Giappone postbellico: la revisione attenta degli errori dai quali trarre insegnamento, lo studio attentissimo delle comunicazioni, le simulazioni (per i dirottamenti aerei i terroristi ricostruirono fedelmente la cabina passeggeri per potersi allenare), lo studio delle coperture e delle residenze affittate prima degli attentati. La scia di dirottamenti e sequestri fu lunga. Nel 1974 fu assaltata l’ambasciata francese all’Aia per ottenere la liberazione di militanti in carcere, nel 1977 il volo Malaysian 653 fu dirottato da un membro dell’Arg e l’azione finì in tragedia: il terrorista uccise i membri dell’equipaggio e fece precipitare l’aereo causando 100 vittime. La pasionaria rossa Fusako Shigenobu fu arrestata soltanto nel 2000, quando il mondo era cambiato dopo il crollo del muro di Berlino e le «brigate rosse» nipponiche erano ormai in crisi profonda. Per oltre vent’anni la leader terrorista pianificò azioni in costante contatto con le più attive organizzazioni terroristiche: oltre a quelle palestinesi, la giapponese ebbe contatti con gli Armeni separatisti, i Turchi e con le Br italiane. Venuto meno l’appoggio del terrorismo arabo, non senza rimpianto la Shigenobu decise il rientro in clandestinità nel suo Giappone. Qui fu catturata in un albergo e condannata a 20 anni di carcere, senza mai mostrare l’ombra del minimo pentimento. E’ considerata dalla giustizia italiana come il mandante della strage di Napoli il cui esecutore materiale, suo cognato Junzo Okudaira, è ad oggi latitante.
Ditonellapiaga e Tony Pitony si esibiscono sul palco del teatro Ariston (Ansa)
La serata delle cover, con i duetti tra concorrenti e ospiti, è la più attesa del Festival. A incuriosire sono gli abbinamenti e la scelta dei brani. L’Ariston risponde con entusiasmo: tra omaggi, energia e qualche azzardo, ecco le pagelle della serata.
Elettra Lamborghini con Las Ketchup 6,5 Aserejé, tormentone primi Duemila, è perfetta per tenere vivo il clima di festa creato dal medley di Laura Pausini. L’Ariston ha voglia di divertirsi. Fasciate in uno sgargiante abito lungo trasmettono spensieratezza. Frizzanti.
Alessandro Siani 6,5 Arriva da Napoli, come cinque dei cantanti in gara e chissà se c’entra la caccia all’audience. Il ping-pong con Carlo Conti sui motivi, istituzionali e giocosi, perché Sanremo è Sanremo è una bella idea, ma è appena abbozzata. Timido.
Bianca Balti 8 Un anno dopo, con i capelli, elegante e sorridente. «Sono qua per godermela, non solo per me, ma per tutte le persone che hanno sofferto come me». E «sono innamoratissima». Entusiasta.
Malika Ayane con Claudio Santamaria 4,5 Quando si sceglie Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina bisogna pensarci 10 volte. Inevitabile balzi all’orecchio ciò che manca. E lo scoppio floppa. Temerari.
Bambole di pezza con Cristina D’Avena 6 per l’impegno Sembrano copiare i Maneskin senza riuscirci e questo la dice tutta. Infatti, il meglio lo danno quando citano Whole lotta love dei Led Zeppelin. Ma perché non hanno proposto quella? Confuse.
Tommaso Paradiso con Stadio 7,5 Una sferzata di rock visionario e apocalittico atterra all’Ariston con L’ultima luna di Lucio Dalla. Gaetano Curreri non ha la voce giusta, Tommaso sì. Di culto.
Michele Bravi con Fiorella Mannoia 5 Per la scelta di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni vale quanto detto per il brano di Mina: si sente il vuoto. Non c’è il carisma, non c’è la drammaticità, non c’è la voce piena dell’interprete originale. Pazienza.
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & The Band 8,5 Il figlio d’arte cresce e si muove meglio ogni sera. Figurarsi se spunta papà Gianni che Vita la cantava con Lucio Dalla. Chissenefregadeimoralisti.
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas 8 la voce di Colombre si avvicina a quella di Jimmy Fontana di Il mondo e il confronto con una delle più belle canzoni della musica italiana non è penalizzante. Plausibili.
Fulminacci con Francesca Fagnani 6,5 Qui è più teatro che musica, ma citare Mina e Alberto Lupo di Parole parole dà i brividi. Si può accettare solo in un copione scanzonato e autoironico. Coraggiosi.
LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo 7,5 A 80 anni l’energia e il feeling di De Piscopo sono intatti. E fa tutta la differenza cantare la cover con il suo inventore. L’Ariston continua a fare festa. Andamento veloce.
J-Ax con Ligera County Fam 8 All star de Milan: Cochi Ponzoni (senza Renato Pozzetto) Paolo Rossi, Paolo Jannacci, Ale & Franz accompagnano il rapper. Felicemente sgangherati.
Ditonellapiaga con Tony Pitony 8,5 Parrucca rosa e maschera di plastica. Cabaret anni Quaranta, jazz americano, Broadway, Quartetto Cetra. Con The Lady is a tramp un’altra scarica di energia. E si balla.
Caterina Caselli 9 Emozionata. Ancora con la sua voce metallica e contundente. Non smette di ringraziare le persone dalle quali ha imparato. Interprete, scopritrice di talenti, produttrice discografica, artista completa. Magnetica.
Continua a leggereRiduci
I veicoli dei talebani controllano la sicurezza a un posto di blocco vicino al confine tra Pakistan e Afghanistan a Nangarhar (Ansa)
L’aviazione pachistana la settimana scorsa aveva condotto una serie di attacchi aerei in Afghanistan, colpendo alcuni campi di addestramento per terroristi. Il bilancio era stato di 18 morti e 7 feriti secondo il governo talebano, che aveva convocato l'ambasciatore del Pakistan a Kabul. Era così iniziata quella che in gergo si definisce come una guerra a bassa intensità con continue «scaramucce» sul confine che avvevano comunque provocato morti e feriti. Il governo del primo ministro Shehbaz Sharif ha deciso per un attacco in grande stile con missili terra-aria su uffici, caserme e centri di addestramento del regime talebano che non ha una contraerea in grado di difendere il territorio. Gli studenti coranici avevano «ereditato» dagli americani, al loro abbandono dell’Afghanistan, una serie di aerei ed elicotteri, molti dei quali danneggiati e ormai inservibili. Sul confine si sono moltiplicate le battaglie fra le truppe di terra, ma le cifre di morti e feriti divergono sensibilmente. Islamabad ha dichiarato di aver colpito 22 obiettivi militari e che sono stati uccisi 274 funzionari e militanti talebani. Stando a quanto dichiarato dal portavoce delle forze armate pachistane sarebbero stati solamente 12 i militari caduti negli scontri. Il ministro della Difesa dei talebani ha detto che l’aeronautica militare del ministero della Difesa nazionale ha condotto attacchi aerei coordinati contro un accampamento militare vicino a Faizabad, a Islamabad, una base militare a Nowshera, posizioni militari a Jamrud, mentre Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano, ha subito indetto una conferenza stampa per annunciare che 55 soldati pachistani erano stati uccisi e 19 postazioni conquistate, mentre 8 combattenti talebani erano caduti. Numeri ovviamente incontrollabili, ma appare difficile credere che la cadente aviazione dell’Afghanistan possa aver ottenuto questi risultati. Zabihullah Mujahid, ha aggiunto di voler subito ricorrere al dialogo per risolvere il conflitto con il vicino Pakistan, sottolineando la necessità di una soluzione pacifica e continuando a sperare che il problema venga risolto senza altra violenza. Il portavoce talebano ha respinto le accuse di Islamabad di essere coinvolti negli attacchi terroristici, rispondendo che sono invece loro che sostengono lo Stato islamico che combatte, sotto il nome di Isis K, per abbattere l’emirato dei talebani. Se proseguisse, lo scontro militare sembrerebbe avere un esito certo, perché le forze armate pachistane dispongono di oltre mezzo milione di uomini e di una forza aerea efficiente, oltre ad un arsenale atomico. L’Afghanistan dichiara di avere 150.000 combattenti, ma non si tratta di un vero e proprio esercito, bensì di milizie abituate soltanto alla guerriglia irregolare. Il fronte però è più ampio di quello che potrebbe sembrare perché il ministro della Difesa di Islamabad ha accusato l’India di avere influenza politica sui talebani. Nuova Delhi ha respinto le accuse, denunciando un piano pachistano per destabilizzare il subcontinente indiano. La Cina e la Russia, unica nazione che ha ufficialmente riconosciuto l’emirato dell’Afghanistan, sono al lavoro per una soluzione diplomatica di un conflitto che potrebbe destabilizzare l’intera Asia centrale.
Continua a leggereRiduci
Matteo Del Fante (Ansa)
L’amministratore delegato sorride tra numeri e strategie, mentre la stima per il 2026 promette ulteriori crescite: «Abbiamo rafforzato la nostra politica dei dividendi», dice, e non è un dettaglio da poco: la cedola proposta sale del 16%, arrivando a 1,25 euro per azione, a testimonianza di un’azienda che non vuole solo correre, ma premiare chi le ha dato fiducia. A dare contenuto a questo risultati soprattutto la finanza e la logistica, con il primato nella consegna dei pacchi.
Il futuro, però, non sono solo conti e percentuali: è anche digitale, innovativo e strategico. Del Fante non si limita a parlare di numeri, ma racconta un percorso di trasformazione che intreccia Poste con Tim, «una partnership che non è mirata a un guadagno immediato ma alla creazione di valore durevole e sostenibile per entrambi i gruppi». Il filo conduttore? Sinergie, integrazione e visione a lungo termine. E per dare concretezza alle parole, la riorganizzazione di gruppo in corso prevede un hub finanziario integrato, dove PostePay e BancoPosta dialogheranno fianco a fianco attraverso la fusione delle rispettive attività. Business come energia e telecomunicazioni saranno distribuiti dalla rete degli sportelli Poste. E non si tratta di semplice fantasia digitale: la nuova super-app di Poste, fiore all’occhiello del 2025, è diventata un fenomeno nazionale, con oltre quattro milioni di utenti giornalieri, la più utilizzata tra gli algoritmi proposti da un’azienda italiana. L’Intelligenza artificiale non è un concetto fumoso: Del Fante la indica come «un acceleratore di crescita chiave» del piano strategico pluriennale che verrà presentato entro il 2026, pronto a inaugurare una nuova stagione dopo nove anni di evoluzioni continue.
I numeri del bilancio restano sotto i riflettori: i ricavi di gruppo hanno raggiunto 13,1 miliardi, in crescita del 4% rispetto al 2024. Il margine operativo tocca i 3,2 miliardi, con un balzo del 10%, e l’utile netto segna 2,2 miliardi, anche questo con un +10%, in anticipo sui target del piano 2024-28. Dalle parole di Del Fante emerge che Poste non solo cresce, ma lo fa stabilmente, costruendo le basi per guardare oltre, fino al 2026: i ricavi sono previsti a 13,5 miliardi, il margine operativo superiore a 3,3 miliardi e l’utile netto (esclusa la partecipazione in Tim) a 2,3 miliardi. Anche i dividendi resteranno generosi, con una percentuale di assegnazione ai soci superiore al 70% degli utili. Da aggiungere un piccolo extra legato all’arrivo del dividendo Tim stimato in cento milioni di euro a partire dal 2027.
Proprio dal gruppo telefonico arriva una novità nella governance. Adrian Calaza, ex direttore finanziario di Tim, è il nuovo presidente di Tim Brasil dove già ricopriva il ruolo di consigliere. Prende il posto di Nicandro Durante. In consiglio entra anche Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane. Nell’illustrazione dei conti da parte di Matteo Del Fante manca, naturalmente, il capitolo «grandi manovre»: tra le priorità c’è l’acquisizione del 20% del Polo strategico nazionale da Cdp, un investimento contenuto ma strategico per supportare Tim nella migrazione della pubblica amministrazione italiana verso il cloud. Insomma, tra numeri da record e strategie a lungo termine, Poste italiane si conferma un gigante in movimento: non solo un’azienda di servizi postali e finanziari, ma un ecosistema digitale in piena espansione, pronto a cavalcare la tecnologia, l’Intelligenza artificiale e le sinergie industriali. Matteo Del Fante lo annuncia a tutta la comunità finanziaria che l’ascolta durante la conference call: il 2025 è stato eccezionale, ma l’avventura è appena all’inizio.
Il riflesso dell’uso dell’Ia si vedrà anche sul fronte dei dipendenti: le assunzioni annuali nei centri aziendali nel 2026 si stimano in calo del 15% rispetto alla media degli ultimi quattro anni. Con Tim, di cui è primo socio, Poste ha aperto vari tavoli. I risparmi attesi si aggirano sui cento milioni.
A inizio del prossimo anno, Poste attende, inoltre, completare la riorganizzazione con la creazione di un hub finanziario e la fusione di BancoPosta con PostePay. «A seguito di questa fusione deterremo il business energia e tlc a livello di capogruppo», ha detto l’ad, spiegando il progetto di creazione dell’hub finanziario. L’Intelligenza artificiale sarà cruciale nello sviluppo previsto. Nel servizio clienti ha permesso la riduzione dei costi del 30%. Sono attesi altri 30 milioni entro i prossimi quattro anni. Inoltre, sono stimati fino a circa 100 milioni di euro di risparmio annuo sui costi It.
Continua a leggereRiduci