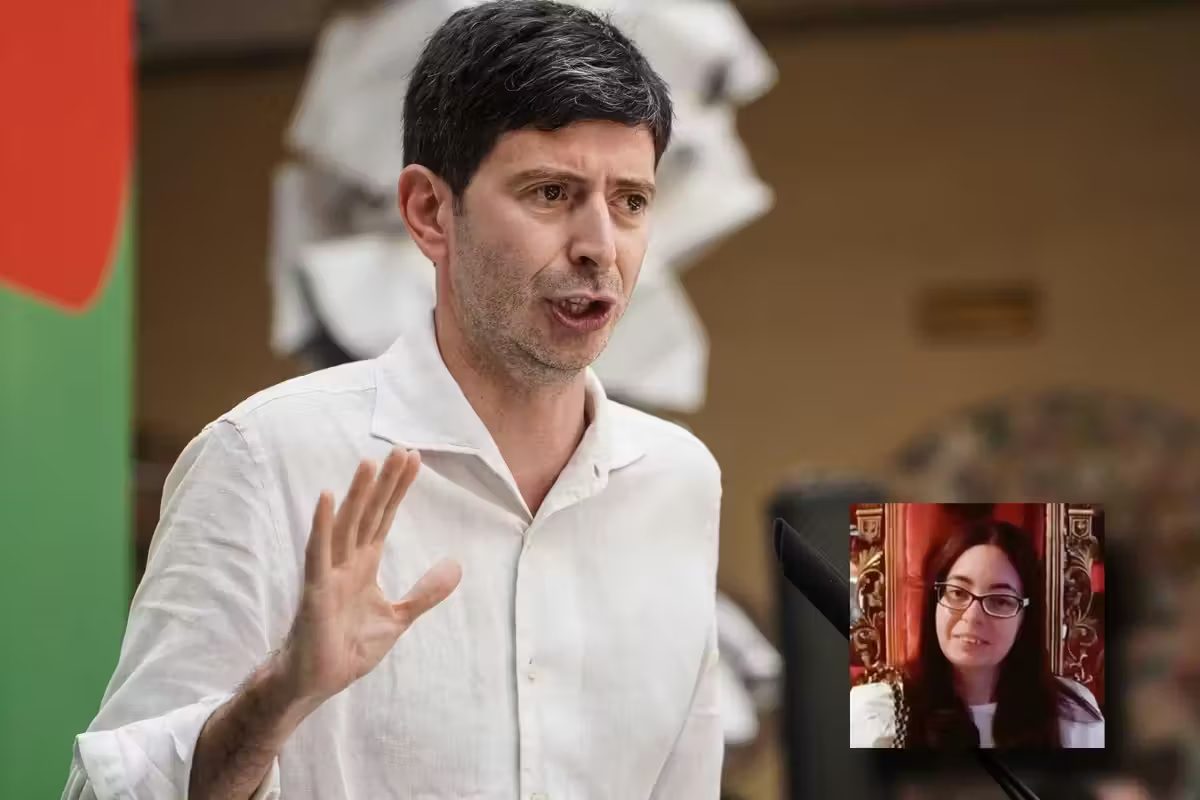Il fanatismo green è dannoso. Per il clima che muta servono più nucleare e desalinizzatori

Finalmente l’Ue ha fatto un primo passo verso l’ecorealismo ammettendo la neutralità tecnologica per scopi di decarbonizzazione e rinviando i tempi per il bando dei motori termici. La spinta è stata data dalla necessità di armonizzare le politiche sia ambientale sia industriale, divergenti a causa di un ecofanatismo più ideologico che tecnico, con grave danno per l’economia. Ma il passo è ancora molto lento. Per accelerarlo, ritengo necessario un cambio di paradigma: dall’ecologia conservativa all’ecologia artificiale.
Il punto è: il cambiamento climatico c’è ed è misurabile oggettivamente dall’aumento delle temperature del pianeta. Ma che la decarbonizzazione forzata sia la sola soluzione è messo in dubbio da dati che mostrano la difficoltà di abbandonare in tempi brevi l’economia basata sui combustibili fossili che producono (parte del) l’effetto serra riscaldante senza distruggere l’economia stessa. Inoltre, i dati glaciologici fanno vedere momenti di riscaldamento del pianeta in epoche decarbonizzate.
Ci sono altre cause per il cambiamento climatico? Nelle scienze fisiche dedicate ho notato un varietà di opinioni non ben riportate dalla stampa, con l’eccezione di questo quotidiano. Quindi, come economista, devo prendere atto che c’è un’ambiguità che suggerisce il disegno di sistemi umani non vulnerabili al cambiamento climatico e conseguenti fenomeni estremi, producendo gradualmente un’ecologia artificiale adattiva. Ne parlai tanto con il professor Vladimir Isaacovich Keilis-Borok nel 1988-90, ai tempi membro dell’Accademia sovietica delle scienze (e poi docente all’Università della California a Los Angeles) quando fummo entrambi parte del gruppo di consulenza al Segretario generale dell’Onu per la generazione di una politica mondiale di prevenzione dei disastri naturali (Un-Idndr). Egli era specializzato in geofisica matematica e scoprimmo una comune passione per gli scenari probabilistici.
Un giorno mi disse: «Anche se decarbonizziamo sul piano industriale, poi il solo disgelo del permafrost in Siberia e nel Circolo artico produrrà gas serra più che compensativi, senza dimenticare le emissioni animali e umane da miliardi di fisiologie e senza escludere un contributo riscaldante del moto planetario e delle dinamiche del Sole». Simulammo un rischio di aumento del livello del mare che avrebbe reso inabitabili le aree costiere dove abitava circa il 70% della popolazione mondiale entro due secoli, senza escludere rischi di desertificazione estesa. Per inciso, le previsioni attuali dei glaciologi stimano un aumento di 7 metri dei mari nel lungo termine. Alzando gli occhi dai fogli pieni di numeri che stavo inserendo nell’intervallo probabilistico 0-1, mi chiese: «Ma voi economisti cosa cavolo pensate di fare per prevenire il rischio catastrofico qui emerso, spostare miliardi di persone? Oppure?». Lì pronunciai per la prima volta i termini«ecoadattamento», «terraformazione», «ecologia artificiale».
Nei tanti decenni di insegnamento presso la University of Georgia (fino al 2015, poi presso Unimarconi, Roma) dove c’era l’obbligo in ogni disciplina di inserire temi ambientali (Environmental literacy), ogni anno ho chiesto agli studenti: volete salvare quello specifico bosco oppure salvare la possibilità che un bosco ci sia? Mediamente, il 30% era per l’ecologia artificiale-adattiva mentre il 70% per quella conservativa. Test più recenti mostrano la continuità di questa proporzione nella popolazione di parecchie democrazie. Ciò mi fa sospettare che la politica, vedendo i dati di consenso, abbia preferito l’illusione di una decarbonizzaizone rapida come soluzione pensando, soprattutto, che il suo costo sarebbe stato minore degli investimenti ecoadattivi.
Ma non è così, in realtà, ed è in atto, appunto, una correzione dell’ambientalismo troppo semplificato. Per l’affermazione di un ecorealismo, dobbiamo considerare il rischio di lungo termine se il riscaldamento globale dovesse continuare: i dati correnti mostrano che difficilmente verrà contrastato. Quindi, la soluzione economica realistica, considerando che il cambiamento climatico, pur rapido, non è velocissimo e lascia tempo per contromisure, è quella di iniziare l’ecoadattamento nei punti più vulnerabili dei sistemi umani. Per esempio, desalinizzatori nelle aree in via di desertificazione, modifiche del territorio contro alluvioni, ecc.
Sarà chiave la disponibilità di energia pulita più abbondante e meno costosa. Il mio gruppo di ricerca ha simulato la sostituzione dei combustibili fossili con l’energia nucleare, sia minireattori a fissione sia grandi a fusione, con lo scopo di dare più spazio temporale alle fonti fossili o combustibili equivalenti, tipo biocarburanti, per non creare crisi economiche grazie al fatto che, poi, la diffusione del nucleare produrrà una decarbonizzazione rapida e un costo dell’energia minore: circa 30/40 anni. Ma va considerato che servirà moltissima energia per climatizzare gli ambienti urbani, costruire argini e nuove infrastrutture contro l’innalzamento del livello del mare e delle acque di foce. E servirà, probabilmente, tanta energia per una nuova agricoltura basata su serre climatizzate.
In sintesi, l’ecorealismo o ecopragmatismo prevede passi successivi di ecoadattamento attivo correlati all’evidenza del cambiamento climatico. Tale ecostrategia non implica solo un costo, ma uno stimolatore di sviluppo tecnologico con guadagni superiori al costo stesso di investimento. In conclusione, dal primo passo nell’Ue per una politica ambientale realistica bisognerebbe passare a un cambiamento completo dell’ecopolitica conservativa verso quella ecoadattiva. Non c’è ancora un consenso sufficiente? Penso sia compito della ricerca generare soluzioni innovative per aumentarlo.
www.carlopelanda.com