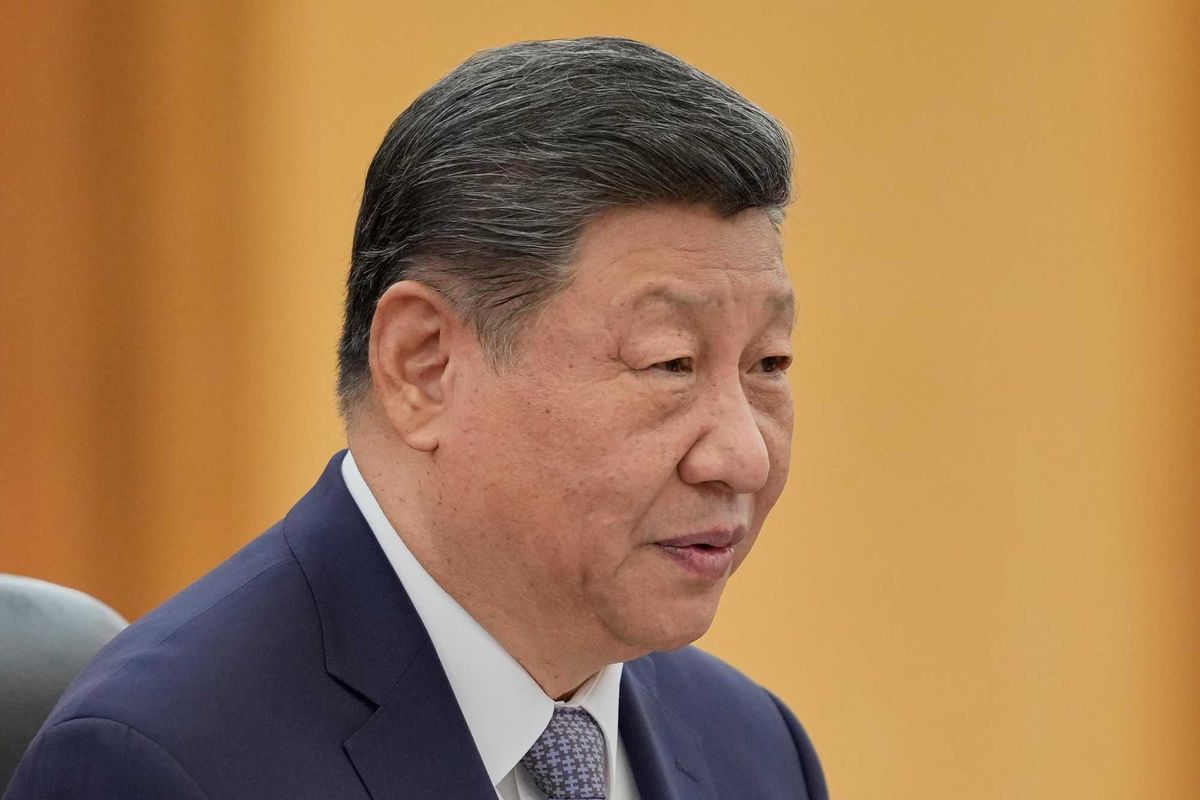Altro che «bamboccioni»: la colossale balla dei lavori che gli italiani non vogliono fare

- Dai nostri connazionali che si mettono a servizio dei cinesi a quelli che vengono trattati come schiavi e pagati 1,8 euro l'ora. Gli immigrati fanno i mestieri che noi evitiamo? No, servono a spingere sempre più in basso salari e standard di sicurezza.
- Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone (Gorizia): «Con l'invasione di bengalesi subappalti e paghe da fame. Ora si cambia».
Lo speciale contiene due articoli.
Lo scorso luglio, il presidente dell'Inps Tito Boeri ci regalava l'ennesimo luogo comune immigrazionista: «Sono tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere». Quali? Quelli evocati da Emma Bonino, ad esempio: «Se non ci fossero immigrati nessuno raccoglierebbe pomodori e olive». E come dimenticare l'affondo di Elsa Fornero? «I giovani devono trovare un'occupazione e non essere troppo “choosy"», cioè «schizzinosi». I «competenti», di solito allo scopo di giustificare l'invasione, da anni ci martellano con il solito ritornello: voi italiani siete bamboccioni, vi lamentate della disoccupazione ma se uno vi offre un lavoro vi tirate indietro, perché certi mestieri ormai vi fanno schifo.
È la tesi dell'imprenditore emiliano Maurizio Sassi, che due settimane fa, a Piazzapulita, lamentava le sue difficoltà nel trovare mungitori tra i giovani della sua zona. «Alla fine è dovuto venire un ragazzo dalla Calabria». In studio era presente il senatore grillino Gianluigi Paragone, che in diretta aveva comunicato il suo indirizzo email a chi volesse candidarsi per l'impiego proposto da Sassi. Peccato che, a telecamere spente (ma a videocamera dello smartphone accesa), Paragone abbia dimostrato, riprendendolo, che quell'imprenditore non aveva alcun lavoro da offrire. «La mia email non la do», si era schermito Sassi. Ma i posti di lavoro? «Quando si liberano». Tanto rumore per nulla: i lavativi italiani non vogliono mungere le vacche, ma anche se volessero l'imprenditore che li fustiga non ha mammelle disponibili.
Questi nostri connazionali sono o non sono «choosy»? Davvero non vogliono più fare certi lavori umili e faticosi, per i quali si rende necessario deportare dall'Africa milioni di semischiavi? Ci sono storie che sembrano smentire questa narrazione. E che, lette alla luce dei freddi numeri, rivelano come stanno veramente le cose: gli italiani di voglia di lavorare ne hanno eccome, ma in certi settori la concorrenza della manodopera straniera scarsamente qualificata ha determinato una tale pressione al ribasso sui salari (nonché sugli standard di sicurezza), da rendere quei mestieri, dall'agricoltore all'operaio dell'edilizia, del tutto indesiderabili.
Cominciamo proprio dalle storie di due degli aspiranti mungitori che avevano contattato l'onorevole Paragone, convinti che il posto di lavoro offerto non fosse un espediente da salotto tv per accrescere il senso di colpa degli italiani. Cornuti, mazziati e manipolati affinché si convincano di essere causa del loro male. C'è Giovanni (nome di fantasia, preferisce non rendersi riconoscibile), che vive in un paesino della Sicilia in provincia di Trapani. Giovanni ha una laurea specialistica in economia e sogna di vivere a Roma, ma attualmente cerca «un qualsiasi lavoro» che gli consenta «un po' di indipendenza economica dai genitori». E il motivo non è che lo disturba chiedere i soldi per andare in discoteca: «È che ritengo un fallimento essere ancora alle loro dipendenze alla soglia dei 30 anni». Così, pur di reagire a quella che considera una sconfitta personale (farsi mantenere da mamma e papà, impiegati pubblici), Giovanni sarebbe disposto a rinunciare al sogno capitolino e ad accantonare la sua laurea per mungere le vacche nella Pianura Padana.
Simile a quella di Giovanni è la storia di Marco Pisano, che rispetto a Giovanni ha qualche anno in più (è del 1975), ma pure lui ha una laurea in economia. Marco è abituato ai sacrifici. Alla Verità racconta di aver lavorato, dopo essere emigrato nella City da Oristano, «nelle cucine di alcuni ristoranti o nelle caffetterie londinesi, per poi», migliorato il proprio inglese, «iniziare a lavorare nell'amministrazione di una società anglo-italiana che si occupava della gestione di svariati ristoranti» nella capitale britannica. «Per me», ci spiega Pisano, «un lavoro, anche se umile, è un'occasione per farsi conoscere, conoscere l'azienda, i suoi processi produttivi e la qualità delle persone coinvolte. Più in generale è un'occasione per mettersi alla prova». Ecco perché anche lui, come Giovanni, lascerebbe nuovamente la natia Sardegna per improvvisarsi mungitore nel Reggiano. «Non ho mai voluto ritenere la distanza dal posto di lavoro un ostacolo o un limite alla mia crescita personale e professionale. Pazienza per la laurea. Pazienza se stavolta si sarebbe trattato di raccogliere il latte, «una posizione aliena rispetto alle mie conoscenze e precedenti esperienze».
Altro che bamboccioni. Altro che schizzinosi. Questi farebbero fagotto direttamente dalle isole per raccogliere il latte. Quanto ai giovani emiliani, una spiegazione alla Verità la propone lo stesso Paragone: se hanno fatto tanto penare l'imprenditore Sassi, è perché «in quella zona la disoccupazione è molto bassa. E poi sono gli allevatori i primi a preferire gli stranieri. Specialmente quelli che, per motivi religiosi, hanno una particolare cura delle mucche, poiché le considerano animali sacri».
C'è comunque da dire che se altri italiani non mostrano la stessa propensione a rimboccarsi le maniche di Giovanni e Marco, non è perché siano degli scioperati in attesa del reddito di cittadinanza. È sufficiente dare un'occhiata a certi annunci di lavoro per capire per quale motivo la gente si guardi bene dal candidarsi. Una «campionessa» nello scovare le offerte più deliranti è la giornalista di Fanpage Charlotte Matteini. L'anno scorso, la Matteini mise alla berlina un'azienda torinese e il suo «cercasi ingegnere» laureato a pieni voti, poliglotta, con esperienza Erasmus e disponibilità a trasferte all'estero, per un contratto da 6 mesi a 600 euro. Però netti. Un affare. Sempre la Matteini aveva pizzicato inoltre il concorso di Carpisa: compra una borsa e vinci uno stage nel reparto comunicazione e marketing, con rimborso spese di 500 euro. Ci sono zone del nostro Paese in cui addirittura gli italiani vengono assunti, a condizioni tutt'altro che vantaggiose, dai cinesi. A Prato, la Chinatown d'Italia, questa non è una novità. Ma a luglio, un'inchiesta del Quotidiano Italiano aveva svelato la ghiotta, si fa per dire, proposta di un discount cinese a Bari: 8/9 ore di lavoro al giorno, inclusi sabato e domenica, per 450 euro.
Eppure non è raro trovare italiani che accettano di farsi spremere, pur di mantenere le famiglie. A giugno era stato denunciato il titolare di un'officina di Catania, dove la polizia aveva scoperto un gommista sessantenne, senza contratto, che lavorava per 1 euro e 80 centesimi l'ora. Sì, 1 euro e 80 centesimi. Quando gli andava bene, perché per le giornate di scarsa affluenza non era prevista alcuna paga. E sempre nel capoluogo siculo, a febbraio, quattro commercianti cinesi erano stati beccati a impiegare in nero alcuni dipendenti, tra cui una ragazza italiana, per 2,77 euro l'ora. Che dire dal caporalato? Quest'estate, gli incidenti mortali accaduti in Puglia avevano rinfocolato il dibattito sullo sfruttamento degli immigrati nell'agricoltura. Ma non dimentichiamo che in questa spirale finiscono pure gli italiani. Nel 2015, ad esempio, Repubblica aveva pubblicato una lunga inchiesta dal titolo eloquente: «Sono italiane le nuove schiave dei campi». Si parlava, per la sola Puglia, di 40.000 braccianti retribuite con miseri 30 euro per 10 ore sotto il sole. E si sottolineava che i caporali non volevano più stranieri: quelli si ribellavano, mentre le donne italiane obbedivano in silenzio. Lo stesso silenzio che copre una verità troppo spesso derisa come fosse, quella sì, un luogo comune: gli immigrati ci rubano il lavoro. Stando a uno studio che suscitò vivaci polemiche un paio di anni fa, questa non è esattamente una sciocchezza. Due economisti, Stefan Collignon e Piero Esposito, avevano sviluppato un ragionamento di perfetto buon senso. In Italia gli immigrati sono prevalentemente poco qualificati. Stando ai dati Eurostat, il 50% di loro ha un livello di istruzione basso, poco più del 40% un livello medio. Un record europeo negativo che si incrocia con quello dei nativi: solo il 15% degli italiani, infatti, ha un livello d'istruzione elevato. La parte restante si divide tra livello medio e livello basso.
Dunque, da una parte c'è un'ampia platea di manodopera italiana che può essere impiegata solo in settori «low skilled»; dall'altra ci sono i concorrenti immigrati, tra i quali non spiccano sicuramente ingegneri indiani e medici siriani. Questo fenomeno comporta di per sé una tendenza ribassista sul livello dei salari: a parità di competenze, gli stranieri costano meno. Il fenomeno è stato aggravato dalla crisi: la contrazione della domanda interna, non compensata dalle esportazioni, ha ridotto ulteriormente l'offerta di posizioni lavorative. Quindi, in un mercato del lavoro sul quale impattano consistenti flussi di immigrati scarsamente qualificati, agli italiani che concorrono per mestieri «low skilled» restano due alternative: accontentarsi di salari più bassi e condizioni di lavoro peggiori oppure restare a casa. Ce la sentiamo di definire «choosy» chi sceglie la seconda opzione? Di mezzo c'è pure l'incolumità fisica. E non è un'esagerazione.
Prendiamo il caso di Monfalcone. I cantieri navali della cittadina che affaccia sulla baia di Panzano erano sempre stati un fiore all'occhiello del Friuli Venezia Giulia. E gli operai che ci lavoravano erano ben pagati e ben tutelati. Poi anche lì arrivò la crisi. Fincantieri accettò di non trasferire all'estero la produzione, ma finì con l'attuare una delocalizzazione al contrario. Cioè, iniziò a ricorrere massicciamente ai subappalti e lasciò che le altre ditte importassero migliaia di bengalesi. Così, mentre i dipendenti diretti di Fincantieri si riducevano, quelli dell'indotto erano arrivati a 14.000. Le società subappaltatrici impiegano i «bangla» a 3 euro l'ora. Perché mai Fincantieri dovrebbe assumere decine di migliaia di lavoratori con tutti i crismi? Certo, poi succede che le aziende che operano in subappalto, per contenere le spese, contengano anche gli standard di sicurezza. E magari ci scappa il morto: come a maggio 2018, quando un diciannovenne è finito schiacciato da un carico di cemento di 700 chili mentre lavorava nell'azienda di famiglia. Pure quella in subappalto per Fincantieri. Non è esattamente la biografia di un bamboccione. Al contrario, è la tragedia di un giovanissimo, forse imprudente, o fore vittima di un sistema che costringe a comprimere sempre di più i costi di produzione, ossia le retribuzioni, i diritti e la sicurezza.
Non manca chi teorizza esplicitamente il ricorso alla leva salariale come strumento di contrasto alla disoccupazione, portando proprio l'esempio della manodopera immigrata. Tra i tanti studi, che non fanno altro se non ribadire un principio economico elementare (se non puoi svalutare la moneta, svaluta i salari!), ne citiamo uno di cui si parlò due anni fa sul Sole 24 Ore. Si tratta di un paper del Centre for economic policy research, in cui si mostrava che dopo la recessione del 2008 nel «mercato del lavoro informale e non regolamentato» i salari erano calati del 32%, specialmente nel caso dei «lavoratori con occupazioni semplici, in cui c'è alta sostituibilità tra immigrati e nativi», allo scopo di compensare il rischio di licenziamento. La conclusione della ricerca era che «se i salari del settore formale fossero stati del tutto flessibili, il calo dell'occupazione sarebbe stato inferiore» anche del 4,5% rispetto al tasso effettivamente registrato. Ecco la ricetta che ci hanno venduto gli aedi della globalizzazione. Meno tutele e paghe «flessibili», ovvero stipendi liberi di fluttuare (rigorosamente verso il basso).
Non sarà un caso se la tendenza degli ultimi anni, mentre l'immigrazione fa registrare numeri crescenti, è a un impoverimento delle famiglie. Dai dati Ocse si evince che la ricchezza disponibile dei nuclei familiari italiani è sostanzialmente stagnante dal 1996, a voler sorvolare sulla brusca picchiata di circa 5 punti percentuali avvenuta nel 2011, dalla quale fatichiamo ancora a riprenderci. E non è un mistero che i salari reali in Italia siano cresciuti meno che nel resto d'Europa. Dal picco dei primi anni Ottanta, la crescita delle retribuzioni è andata costantemente rallentando, fino a toccare il fondo dal 2009 in poi. Contemporaneamente, i flussi migratori si sono intensificati. Nel 1995 gli stranieri residenti in Italia erano 729.159; nel 2000, 1.379.749; nel 2005 erano arrivati a oltre 2 milioni; a gennaio 2018 erano più di 5 milioni. Uno dei mantra delle scienze sociali è che una «covariazione» non indica per forza un rapporto di causalità. Però, se si considera che (dato 2014) gli immigrati si accontentano di percepire in media 7.530 euro in meno all'anno rispetto agli italiani, ci si rende conto che il problema non è la neghittosità dei nostri connazionali. Non è la loro ambizione a posti di lavoro socialmente più prestigiosi rispetto al coltivatore di pomodori, all'operaio edile o al mungitore di vacche. Il vero problema è la concorrenza al ribasso delle orde di stranieri scarsamente qualificati che abbiamo lasciato entrare nel nostro Paese. Il cui effetto è amplificato nei settori occupazionali nei quali, per citare lo studio del Cepr, c'è «alta sostituibilità tra immigrati e nativi».
Ci hanno raccontato che la piaga dell'Italia è la produttività del lavoro. Che gli italiani, al contrario degli operosi teutonici, per ogni ora lavorata generano troppo poco valore aggiunto. In pochi hanno fatto notare che se la produttività è bassa, è perché il nostro Paese, ancorato alla gloriosa locomotiva europea, si è tuffato nella globalizzazione al suono di progressiva contrazione del costo del lavoro, di riduzione dei salari reali, delle tutele e persino della sicurezza. Non proprio un incentivo all'innovazione e all'efficientamento per le aziende, o all'incremento della produttività per i dipendenti. In pochi hanno osservato che gli italiani non sono né bamboccioni, né «choosy», né troppo ambiziosi per accontentarsi di lavori umili. Hanno semplicemente sgamato l'inganno. Chi può, come forse i giovani emiliani poco attratti dalle vacche di Sassi, reclama dignità. Non si piega agli stage da ingegnere poliglotta per 600 euro o alle settimane lunghe al discount cinese per 450 euro. E probabilmene, per rabbia, vota per i populisti, i «fascisti» che almeno si rivolgono agli «ultimi», dimenticati dalla sinistra. Chi ha bisogno di mettere insieme pranzo e cena, invece, china la testa. Si spacca la schiena nei campi. Si imputridisce di olio in un'officina. Muore schiacciato in un cantiere navale. Tanto l'italiano è solo carne da macello. E alla bisogna può essere «sostituito» da uno schiavo d'importazione.
«Chi vuole capire studi il caso di Monfalcone»

Anna Maria Cisint è il sindaco di Monfalcone (Gorizia). Leghista, la prima a strappare alla sinistra quello che per settant'anni era stato un feudo rosso, «figlia di cantierini», come lei stessa racconta alla Verità: «Mio padre è morto per aver respirato l'amianto». Oggi ha il difficile compito di far rinascere Monfalcone, i cui cantieri navali erano diventati un discount di operai asiatici.
Sindaco, anni fa lavorare nei cantieri navali di Monfalcone significava essere operai d'élite. Poi cosa è successo?
«Poi, dagli anni Novanta, è partita la corsa ai subappalti, per ragioni di abbassamento dei costi di produzione».
Mi spieghi meglio.
«C'è stata una specie di delocalizzazione al contrario. Fincantieri iniziò ad affidare i lavori ad altre aziende, che assumevano operai soprattutto asiatici a bassi salari».
Questo che conseguenze ha avuto?
«Ha generato problemi sociali, scolastici, abitativi. E ovviamente il dumping salariale».
Sulle condizioni di lavoro che mi dice?
«Le condizioni di sicurezza sono peggiorate».
A maggio è morto un ragazzo di 19 anni in una ditta subappaltatrice.
«Sì, ma sarò onesta: si è trattato di un tragico incidente. La sicurezza c'entra poco».
Di chi è la colpa di questa involuzione? Della globalizzazione?
«I mercati ultracompetitivi hanno fatto la loro parte. Ma le giunte di sinistra sono state totalmente prone alle dinamiche della globalizzazione».
Cioè?
«Pensi solo a questo: nel 2005 gli stranieri a Monfalcone erano poco più del 5%. Siamo arrivati al 22».
Quindi colpa della sinistra.
«Guardi, io ho provato tante volte a confrontarmi con la ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani e con l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda».
E…
«E ho ricevuto solo porte in faccia».
Porte in faccia?
«Sì. Alla Serracchiani e a Calenda chiedevo di lavorare insieme, perché Fincantieri fa parte di un sistema produttivo che non può non tenere conto del ruolo della politica».
Sia sincera. Il problema è davvero il dumping salariale, o gli italiani non hanno più voglia di spaccarsi la schiena nei cantieri?
«A Monfalcone siamo tutti orgogliosi dei cantieri navali. La nostra identità si è strutturata insieme a loro e quando una nave va in mare la sentiamo sempre un po' nostra. Ma le racconto un altro episodio che le fa capire quanta voglia di lavorare abbiano gli italiani».
Mi racconti.
«Con la Regione guidata da Massimiliano Fedriga, Confindustria e Fincantieri abbiamo organizzato il primo recruiting day. Sono arrivate 34 ditte di navalmeccanica, quelle dell'indotto sano, che non campa di manodopera a basso costo, disponibili a reclutare personale tra i 6.000 disoccupati della provincia idonei a svolgere questo lavoro».
E cosa è successo?
«In un solo giorno si sono presentate 850 persone».
Quindi gli italiani di lavorare hanno voglia...
«Certo. Il tema è come si lavora».
E voi che state facendo per migliorare le condizioni di lavoro?
«Con Fincantieri e Fedriga abbiamo organizzato il tavolo della filiera».
A cosa serve?
«Glielo spiego in modo semplice. Oggi i dipendenti diretti di Fincantieri sono 800. Io vorrei arrivare a fissare una quota 1.000. E vorrei che si facesse sempre meno ricorso al subappalto».
Fincantieri che ne pensa?
«Come le dicevo, le cose sono migliorate molto, anche perché il nuovo governo ci ascolta. Adesso Fincantieri mostra la chiara volontà di applicare il principio della responsabilità sociale d'impresa».
Mi faccia un esempio.
«Be', Fincantieri si è impegnata a realizzare una scuola materna per i dipendenti, tipo asilo aziendale. E fornirà ai suoi lavoratori un oculista interno. Stiamo tornando alle origini…».
In che senso?
«Quando i Cosulich avviarono i cantieri, ai primi del Novecento, costruirono un quartiere, una scuola, un campo sportivo, un teatro…».
Erano altri tempi...
«So che c'è la globalizzazione, che ci sono i costi serrati. Ma sono sicura che quel modello possa essere il nostro faro».