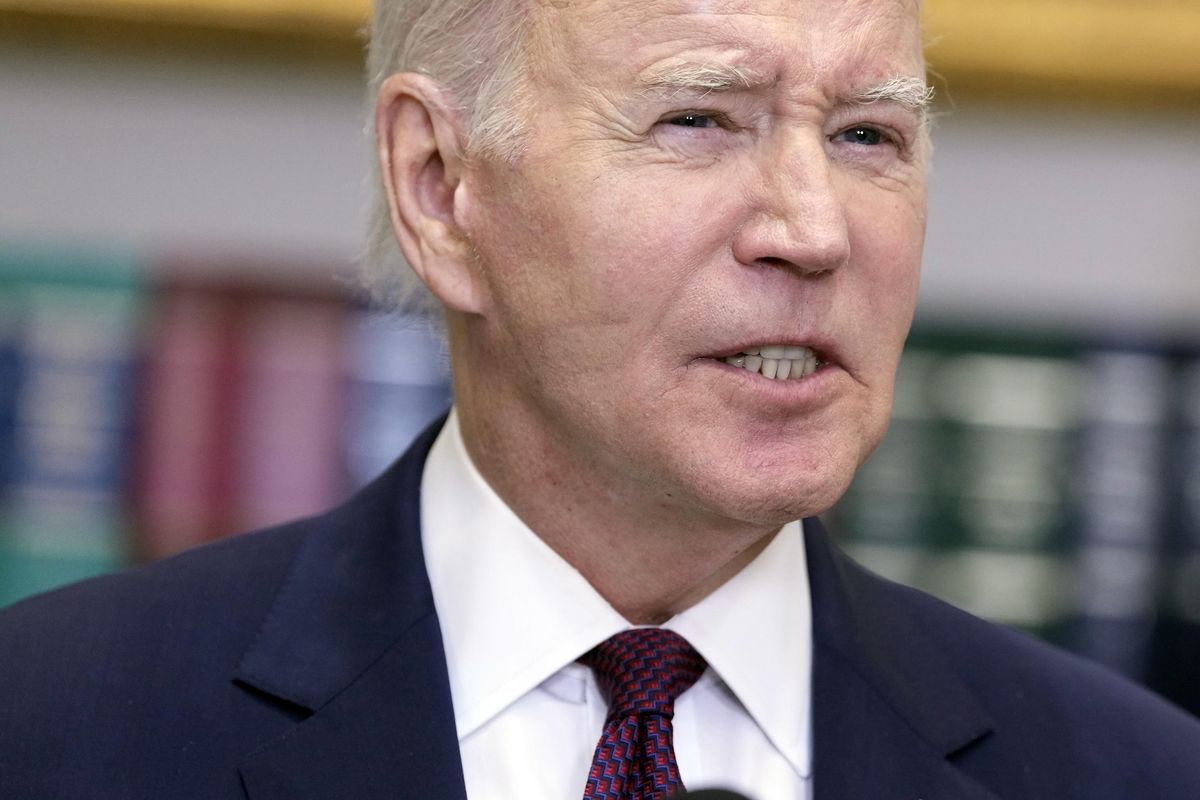
È una sentenza storica, quella emessa ieri dalla Corte suprema degli Stati Uniti. La maggioranza dei togati ha bocciato la cosiddetta «affirmative action»: la pratica, cioè, di considerare l’etnia un fattore di cui tener conto nell’ammissione degli studenti all’università. La decisione riguarda due casi correlati: l’organizzazione Students for fair admissions aveva fatto causa a Harvard e all’Università del North Carolina, contestando a entrambe il ricorso all’«affirmative action».
Ebbene, secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei supremi giudici, questa pratica viola la clausola dell’eguale protezione davanti alla legge, sancita dal Quattordicesimo emendamento: una clausola che, ha sottolineato la Corte, rende inammissibile ogni discriminazione basata sulla razza. Certo: i giudici riconoscono che possano essere in linea teorica ammesse delle eccezioni, ma dovrebbe trattarsi di casi mirati, legati a un «interesse fondamentale» e sottoponibili a un «severo controllo». Una serie di criteri che, afferma la sentenza, né Harvard né l’Università del North Carolina sono state in grado di soddisfare. In altre parole, gli obiettivi che i due atenei hanno detto di voler conseguire tramite l’«affirmative action» risulterebbero, per i togati, troppo generici e non adeguatamente misurabili.
Non solo. I giudici hanno contestato anche il fatto che le università abbiano adottato «categorie razziali» che, definite «imprecise» e «opache», hanno portato a dei cortocircuiti. «Focalizzandosi sulla sottorappresentazione», i due atenei «preferirebbero apparentemente una classe con il 15% di studenti dal Messico rispetto a una classe con il 10% di studenti provenienti da svariati Paesi latinoamericani, semplicemente perché la prima contiene più ispanici rispetto alla seconda», si legge nella sentenza. Un altro punto contestato dai giudici è stato che la scadenza, a cui i programmi di «affirmative action» avrebbero dovuto essere sottoposti, è rimasta fondamentalmente vaga.
Alla luce di questi fattori, la conclusione è chiara: «I programmi di ammissione di Harvard e dell’Università del North Carolina non possono conciliarsi con le garanzie della clausola di eguale protezione davanti alla legge. Entrambi i programmi mancano di obiettivi sufficientemente mirati e misurabili che garantiscano l’uso della razza, utilizzano inevitabilmente la razza in modo negativo, implicano stereotipi razziali e mancano di una scadenza significativa. Non abbiamo mai permesso ai programmi di ammissione di funzionare in questo modo e non lo faremo oggi», recita la sentenza.
«Nulla vieta alle università di prendere in considerazione la discussione di un candidato su come la razza abbia influenzato la vita del candidato stesso, a condizione che tale discussione sia concretamente legata a una qualità del carattere o a un’abilità unica che il particolare candidato può apportare all’università», prosegue la sentenza, per poi precisare: «Lo studente deve essere trattato in base alle sue esperienze come individuo, non in base alla razza».
«Mentre sono dolorosamente consapevole delle devastazioni sociali ed economiche che hanno colpito la mia razza e tutti coloro che subiscono discriminazioni, nutro una speranza duratura che questo Paese sarà all’altezza dei suoi principi così chiaramente enunciati nella Dichiarazione d’Indipendenza e nella Costituzione degli Usa: che tutti gli uomini sono creati uguali, sono cittadini uguali, e devono essere trattati allo stesso modo davanti alla legge», ha scritto il giudice afroamericano, Clarence Thomas, schieratosi con la maggioranza dei togati.
Ad esprimersi contro l’«affirmative action» sono stati i sei giudici di nomina repubblicana, mentre quelli di designazione dem l’hanno sostenuta, dichiarando - con la togata Sonia Sotomayor - che la sua abolizione «respinge decenni di precedenti e di epocali progressi». Il dibattito su questa pratica andava avanti da tempo. I fautori hanno sempre affermato che essa si limitasse a usare l’etnia soltanto come uno dei fattori da considerare nell’ammissione universitaria. I contrari l’hanno, invece, sovente tacciata di essere una discriminazione al contrario: un metodo, cioè, per introdurre surrettiziamente un meccanismo di quote, dichiarato incostituzionale dalla stessa Corte suprema nel 1978. Bisogna inoltre ricordare che questa pratica non era adottata da tutti gli atenei statunitensi e che in nove Stati il suo uso era già stato vietato. Secondo Harvard, l’abolizione dell’«affirmative action» comporterà probabilmente un aumento delle ammissioni di bianchi e di asiatici americani.
La sentenza di ieri è innanzitutto un altro schiaffo all’amministrazione Biden dopo la sentenza dello scorso anno sull’aborto, che in sede di dibattimento si era schierata con i due atenei. Più in generale, è un duro colpo inferto all’«identity politcs»: un controverso orientamento ideologico progressista, da sempre molto sponsorizzato dall’attuale Casa Bianca. Non a caso, Joe Biden ha criticato la sentenza. «Non possiamo lasciare che questa decisione sia l’ultima parola», ha detto. «La discriminazione esiste ancora in America. Per 45 anni, la Corte suprema ha riconosciuto e rispettato la libertà degli atenei di scegliere come costruire e garantire la diversità del proprio corpo studentesco. Con la decisione odierna, ha fatto un passo indietro rispetto a decenni di progresso», ha aggiunto, per poi concludere: «Questa non è una Corte normale». Di tutt’altro avviso si è invece mostrato Donald Trump, che ha accolto con favore la decisione dei togati, dichiarando: «Tutto tornerà basato sul merito, è così che dovrebbe essere».






