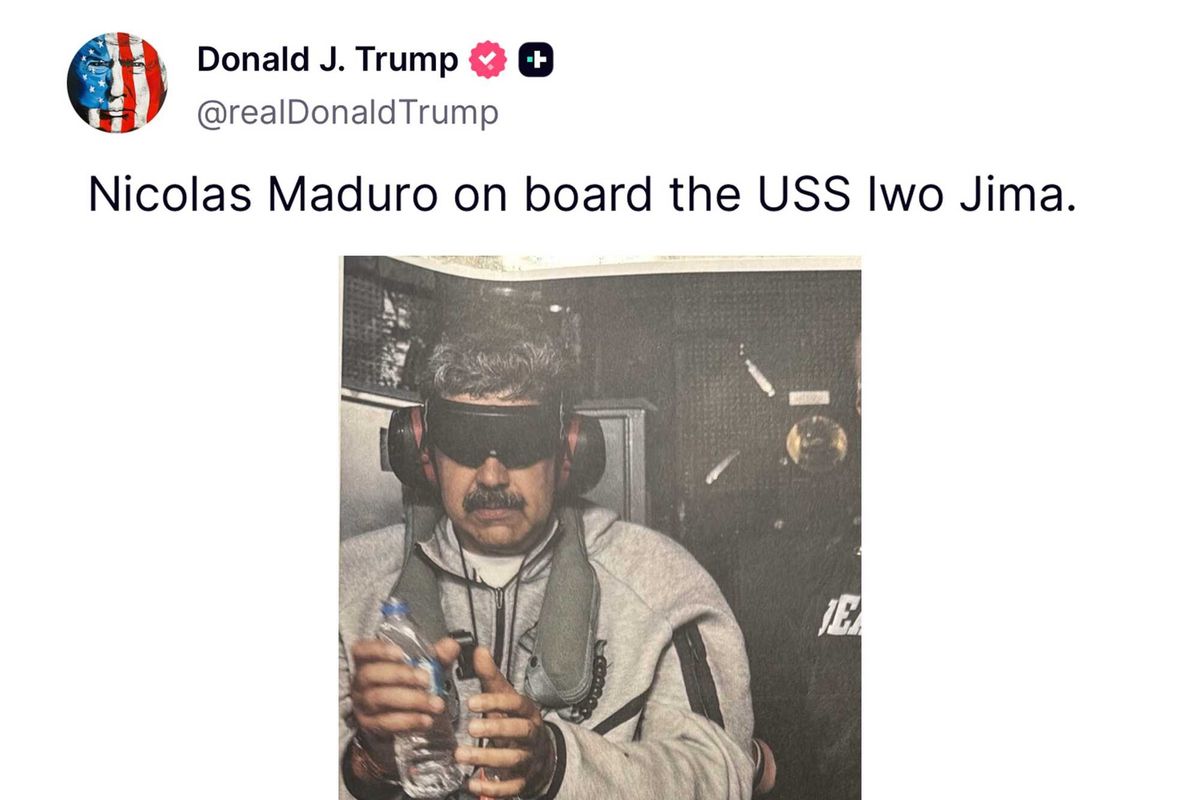Ci sono due guerre civili ma la retorica del 25 aprile dimentica quella rossa

Il mio primo 25 aprile l'ho festeggiato quando avevo quasi dieci anni. Stavo seduto sul gradino della modisteria di mia madre Gioanna e vidi passare tra due ali di folla una jeep americana. Era un piccolo veicolo agile, tutto verde, e trasportava una sola persona: un tizio che si faceva notare per due cose. Portava un basco nero e aveva un paio di baffi orgogliosi che anche negli anni Quaranta non tutti possedevano.
La jeep procedeva a passo d'uomo per non deludere la gente che la assediava. Il tizio baffuto non rispondeva ai saluti della folla, si limitava a osservarla con un mezzo sorriso bonario. Mio padre Ernesto stava in piedi accanto a me e domandò: «Giampa, sai chi sta passando?». Non ebbi incertezze nel rispondere: «Porthos, uno dei quattro moschettieri!». Il papà rise e replicò con un tantino di enfasi: «No, passa la libertà. La guerra è finita, per questo stiamo festeggiando».
Quella sera Ernesto mi spiegò chi era il passeggero della jeep: un famoso comandante partigiano che nella valle del Po aveva fondato e guidato una divisione delle Garibaldi. Si chiamava Pompeo Colajanni, era siciliano, nato nel 1906. Chiamato alle armi dal regio esercito, aveva combattuto nel Nizza Cavalleria, lo diceva il basco nero. Da partigiano aveva scelto come nome di battaglia quello di Barbato. In onore del medico Nicola Barbato, un protagonista del movimento dei fasci siciliani.
Con il trascorrere degli anni, Barbato e io diventammo amici. Quando andavo a Palermo, per decisione di uno dei tanti direttori che mi avevano voluto come inviato speciale, passavo sempre a trovarlo, di solito nella reggia dell'Assemblea regionale siciliana dove aveva il suo ufficio di vicepresidente. Mi ordinava: «Pansa, lascia perdere questo palazzo e tutte le porcherie che contiene. Ma parlami di quando mi hai visto da ragazzino e credevi che fossi Porthos, uno dei moschettieri…».
La prima volta che lo incontrai a Palermo gli chiesi come mai era venuto nella nostra città. Lui mi spiegò: «Nella mia banda avevo anche qualche ragazzo di Casale. Sono loro che mi hanno imposto quella parata. Si erano procurati una jeep e decisero che avrei attraversato il centro a passo d'uomo. Potevo dirgli di no? Nella guerra partigiana avevo messo a rischio la loro vita. Quanto mi domandavano era il minimo che potessi fare per loro!».
Alla fine della guerra partigiana, Barbato aveva 39 anni e campò sino a farne 81. Aveva uno studio da avvocato e per una legislatura fu anche eletto deputato del Pci nel collegio di Torino. Ma per me rimase sempre il Porthos del mio primo 25 aprile. A proposito di quelli successivi ho scritto molto, anche quando non mi piacevano per l'asprezza e spesso la violenza che sprigionavano. Ne citerò un solo episodio: quello che nel 2006 vide gli antenati dei centri sociali di oggi comportarsi in modo brutale con l'allora candidata sindaca di Milano, Letizia Moratti, ministro dell'Istruzione.
Quale peccato aveva commesso la signora Moratti? Voleva soltanto avvicinare al palco della cerimonia antifascista il proprio padre seduto su una carrozzella. E quale colpa aveva commesso quel signore? Aveva combattuto nella Resistenza in una organizzazione non comunista, quella guidata da Edgardo Sogno, un altro meraviglioso irregolare nel mare tempestoso delle bande rosse. Catturato dai tedeschi, era stato deportato in un campo di sterminio in Germania e ne era uscito per miracolo.
Il mio disinteresse per il 25 aprile è cresciuto anno dopo anno, mentre riflettevo da revisionista sulla nostra guerra civile. Arrivando a una conclusione che a qualche lettore del Bestiario non piacerà. Quella che l'Italia non ha visto un solo conflitto interno, bensì due. La prima guerra è stata quella che viene celebrata ogni anno. I vincitori sono i partigiani. I vinti sono i fascisti della Repubblica sociale e i militari tedeschi che combattevano per Hitler.
Ma una volta chiusi questi conti, è emersa un'altra guerra civile anch'essa cattiva. Tutta interna al campo antifascista. Bande di partigiani comunisti hanno cominciato a uccidere chi si opponeva alla nascita di una dittatura non più nera, ma rossa. Un regime che aveva un obiettivo: fare dell'Italia una nazione soggetta a un partito unico e autoritario, da mettere agli ordini dell'Unione sovietica.
Non è un'invenzione del Bestiario. È una verità storica, piena di sangue, di crudeltà, di morti ammazzati, di falsità spacciate per verità. Nei miei tanti lavori revisionisti ho raccontato molte di queste storie. Meritandomi una sfilza di ingiurie, di attacchi personali, di minacce. Le ricordo con allegria e con fierezza. Se tu hai il coraggio di dare del cornuto al bue, devi andarne fiero. Perché anche nel racconto storico i punti di vista possono essere diversi, ma alla fine della fiera la verità che si impone è una sola.
Con la saggezza un po' scriteriata dell'ottantenne che ha avuto già tanto dalla vita, oggi sento il dovere di ringraziare un leader politico per il quale non ho mai votato: Alcide De Gasperi. Il 18 aprile 1948, trionfando in una battaglia elettorale decisiva per la democrazia italiana, ha tagliato le gambe alla seconda guerra civile. Se avesse vinto il Fronte popolare dei comunisti e dei socialisti, oggi non starei di certo a scrivere questo Bestiario per un giornale che si chiama La Verità.
Anche la narrazione della nostra guerra civile ha bisogno di un po' di verità. Non è certo quella che verrà sbandierata in questi giorni. A cominciare dall'Anpi, l'associazione nazionale dei partigiani, un sodalizio di estrema sinistra che ritiene il revisionismo un demonio impossibile da esorcizzare. State bene attenti alle tante parole che in questi giorni verranno ripetute dai giornaloni, dai telegiornali ipocriti, da politici di ogni risma che tenteranno di nascondere la loro pericolosa debolezza dietro una nebbia che sa di stantio, di viltà, di bugie ripetute sino alla nausea.
Ma esiste un modo per difendersi da tutto questo pattume. È di ricordare un vecchio signore scomparso, il grande De Gasperi. Ho la fortuna di averlo visto davvero poco prima del 18 aprile 1948. Arrivò nella mia città dopo aver incontrato il ministro degli Esteri francese: George Bidault. Veniva dal santuario di Crea, quello della Madonna nera, che il fumo delle tante candele votive aveva trasformato in una migrante scagliata in casa nostra da un paese sub sahariano e condotta sino a quella collina benedetta.
Bidault aveva garantito a De Gasperi che se il Fronte popolare avesse vinto il 18 aprile, la Francia avrebbe dato asilo politico a tutti i democristiani che non potevano più vivere in una Italia diventata rossa. Il vecchio Alcide si era messo tranquillo. E il suo discorso in piazza del Cavallo fu telegrafico: «Non andare a votare è un delitto. Votare male è una viltà».
Eccovi serviti, lettori del Bestiario. Qualcuno di voi mi replicherà: caro Pansa, lei il 4 marzo 2018 non è andato a votare, come la mettiamo con l'appello di De Gasperi? Nel modo più semplice: non sono andato alla mia sezione elettorale perché sapevo che avrei comunque votato male. Contenti?