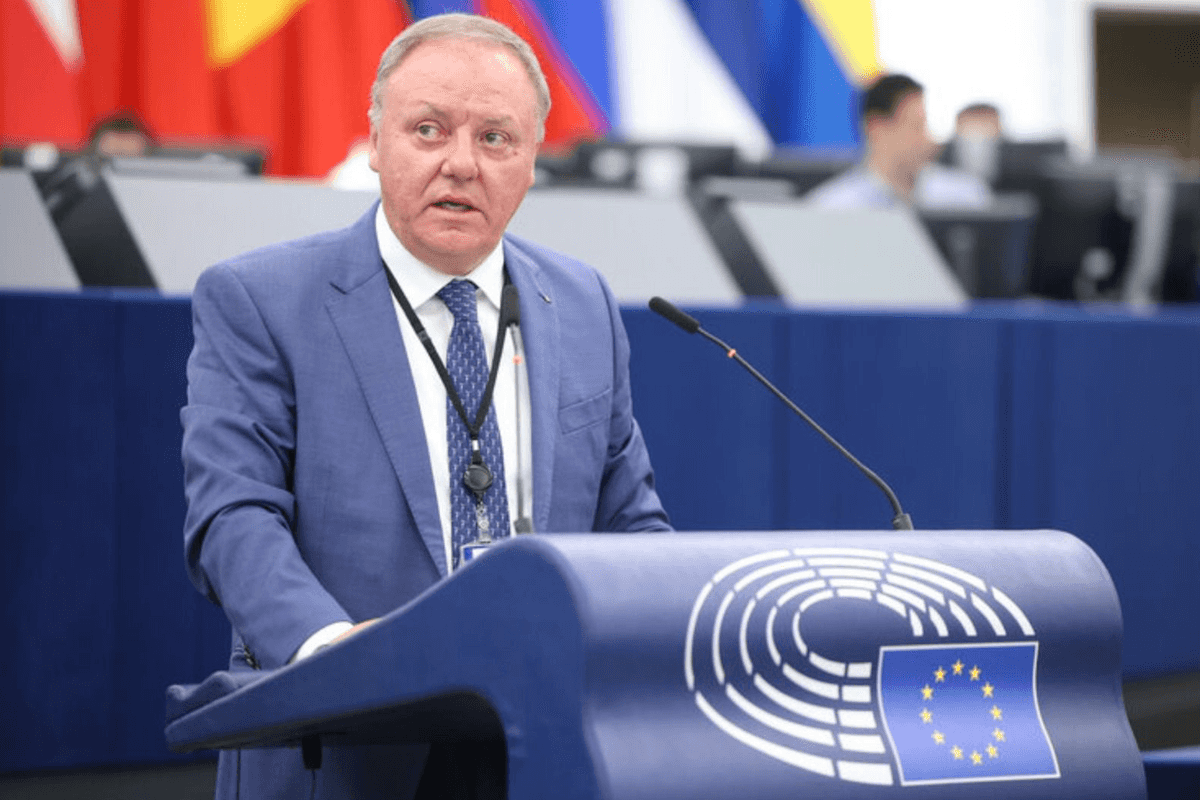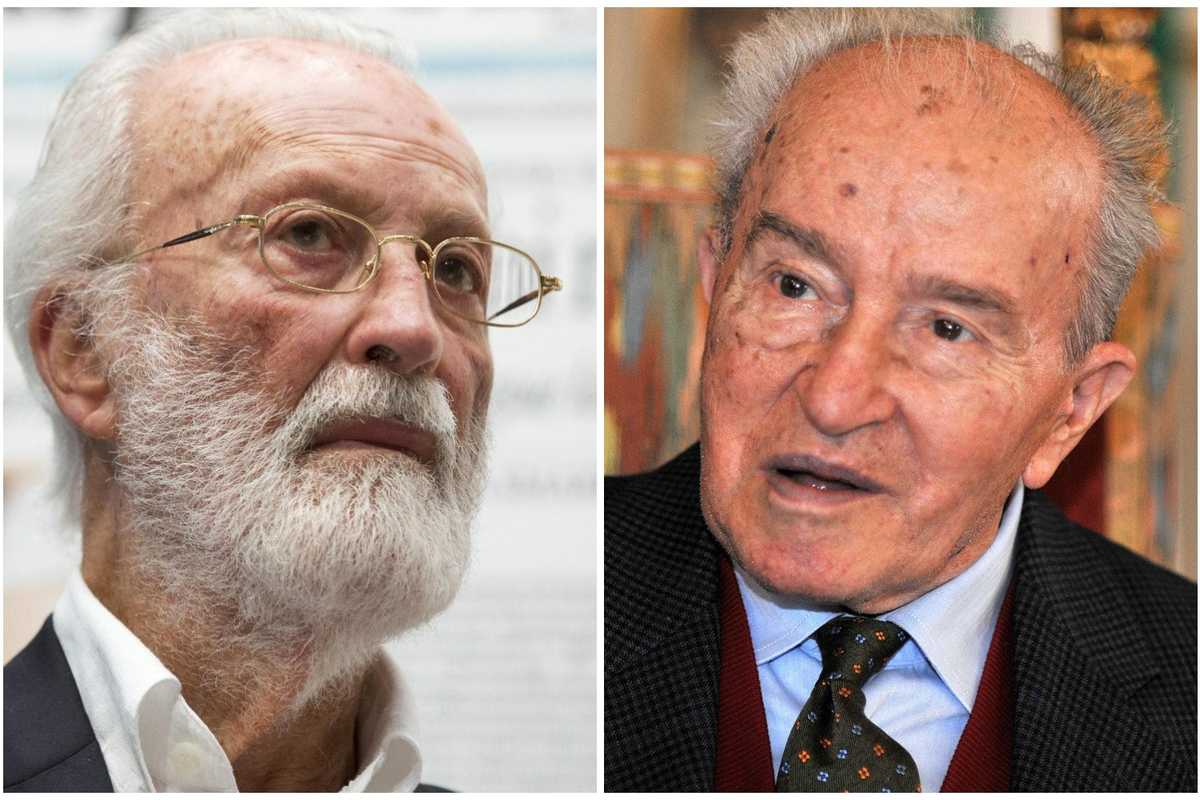
Il 25 aprile di 80 anni fa finiva il fascismo e cominciava l’antifascismo. Per lo meno quello di massa, che è arrivato fino a noi e che oggi celebrerà la lotta partigiana. In piazza probabilmente ci saranno i nipotini dei tanti che si dichiarano antifascisti senza mai aver imbracciato un fucile e senza mai aver combattuto il regime, di cui prima cercarono i benefici e che poi, ovviamente a guerra finita o già persa, criticarono. Gli italiani, infatti, per 20 anni furono nella quasi totalità ferventi sostenitori di Benito Mussolini e quando il Duce cadde si riscoprirono altrettanto ferventi avversari di Mussolini. Il trasformismo, del resto, è una specialità nazionale, ma negli anni che precedettero di poco la caduta del regime e, soprattutto, in quelli a seguire, fu la cifra di una stagione politica, in cui si distinsero in particolare i cosiddetti intellettuali. Prima fascistissimi, dopo partigianissimi e comunistissimi. Per quieto vivere, sia prima che dopo. Ma anche per ansia di carriera e per sbarcare il lunario.
In vista delle ipocrite manifestazioni che oggi verranno celebrate in ogni angolo d’Italia, sono dunque andato a ripescare nella libreria di casa un vecchio volume ormai dimenticato. S’intitola Camerata dove sei?, sottotitolo: Rapporti con Mussolini e il fascismo degli antifascisti della prima Repubblica. L’autore si firmò Anonimo nero, forse per paura di rappresaglie, perché nel 1976 la caccia alle camicie nere era uno «sport» assai praticato (l’omicidio di Sergio Ramelli, ucciso a sprangate a 18 anni per il solo torto di essere stato iscritto al Fronte della gioventù, è del 1975). Il libro, che si autodefinisce di controinformazione, è uno spasso, perché fa cadere il muro di ambiguità che ha accompagnato per anni la lotta partigiana di tanti intellettuali, ai quali, rileggendone la storia e la militanza, si può riconoscere solo la partigianeria con cui si sono giudicati e assolti per gli errori di gioventù.
Camerata dove sei? è un librino tascabile, di poco più di 200 pagine, che in ordine alfabetico mette in riga gli esordi fascistissimi di registi come Michelangelo Antonioni e Carlo Lizzani, del pittore Renato Guttuso, di giornalisti e scrittori come Eugenio Scalfari, Davide Lajolo e Cesare Zavattini, di politici come Amintore Fanfani, Benigno Zaccagnini, Pietro Ingrao, Giovanni Spadolini, tanto per citarne alcuni di diverse sponde. In totale sono una cinquantina di nomi, alcuni famosissimi e ancora celebrati, altri dimenticati. Tutti però uniti da parole di entusiasmo nei confronti del regime e dei gerarchi, molte delle quali pronunciate dopo le leggi razziali, dopo gli arresti e il confino di chi si opponeva per davvero e anche dopo l’entrata in guerra. Non ancora celebrato come il regista dell’incomunicabilità, Antonioni, di cui nel libro c’è anche una fotografia in camicia nera, andava in estasi per la cinematografia fascista. Da camerata nel 1935 parlava del cinema di regime definendolo «un’arma potentissima di propaganda, che agirà in profondità sull’anima del popolo e sarà per il Fascismo (la F maiuscola è dell’autore di Deserto rosso, come annota l’autore del volume, ndr) un mezzo efficacissimo per affermarsi in tutto il mondo, in ciò che di esso ha di più essenziale e di più insostituibile». Carlo Lizzani, che non aveva ancora girato film come Mussolini ultimo atto per denunciare il degrado del fascismo, nel 1940 spiegava che bisognava sostituire il vecchio mondo democratico con il nuovo mondo fascista, fondato sulla «nostra razza e la nostra civiltà». «Questa posizione di avanguardia sarà da conquistare e rendere sempre più solida, e con le armi e con il nostro modo di vita tutto informato a concetti unitari e di intransigenza fascista». Lizzani non si tirava indietro neppure quando c’era da lodare film di propaganda antisemita, come L’ebreo Suss, che definiva una pellicola ottimamente riuscita. Eugenio Scalfari, non ancora diventato maître à penser della sinistra, ma già caporedattore di Roma fascista e collaboratore di Cronache dall’Impero nel 1942 tesseva le lodi dell’impero e della razza: «L’imperialismo non può sboccare in definitiva che in un più o meno vasto e solido dominio coloniale», scriveva a sostegno della volontà di potenza di Mussolini, «non può affermarsi cioè che sopra genti nettamente inferiori e prive di civiltà». E concludeva dicendo che «noi giovani... ci troviamo uniti e solidali quando si tratti di raggiungere questo obbiettivo che è supremo per la futura vita politica della Nazione e dell’Impero». Anche in questo caso le maiuscole sono dell’autore.
Quanto a Guttuso, nel 1965 il Pci, nelle cui file fu eletto, usò un suo disegno per un manifesto per la pace in Vietnam dal titolo «Alt agli sbarchi degli imperialisti Usa». Peccato che quel disegno fosse già stato usato nel 1941, ma dalla rivista fascista Documento, forse a favore degli sbarchi nazifascisti in Africa. Di certo nel 1942 una giuria fascistissima premiò il Maestro e non per un quadro antifascista. Nel libro c’è anche una fotografia del pittore in divisa, ai Littoriali di Palermo.
Di Fanfani viene citato un saggio del 1936, dal titolo Cinquant’anni di preparazione dell’Impero, in cui il futuro presidente del Consiglio del centrosinistra proclamava spettare a Mussolini «la preveggente preparazione di forze nuove per superare la politica del piede di casa». Ma nel 1941 il futuro segretario della Dc pubblica un libro per le scuole medie italiane dal titolo Il significato del corporativismo, dove, oltre a elogi del sistema corporativo fascista e del regime, è compresa una parte scritta dal professor Carlo Marzorati in cui si sosteneva che «la difesa della Razza è una necessità biologica e come fatto spirituale di fronte all’urgente necessità di distruggere quel fenomeno di ebreizzazione che dall’unità d’Italia in poi dilagò in tutti i campi della cultura, della economia, della politica».
Benigno Zaccagnini, poi segretario dc in odore di santità, nel 1939 sul periodico del gruppo universitario di Ravenna pubblicò un articolo dal titolo Problemi razziali: il meticciato, con il quale denunciava pericoli e danni di ordine genetico di un incrocio fra razze. Per il partigiano Zaccagnini il popolo italiano era chiamato a elevarsi sempre di più, non confondendosi o mescolandosi con altre genti, rendendo più netto il carattere della propria civiltà. L’incrocio fra razze, fra l’altro, rappresentava un gravissimo rallentamento di ogni vincolo familiare e «un’assoluta mancanza di educazione morale e intellettuale di questi infelici». Non solo: «Una continua eccitazione dei loro più bassi istinti (odio, vendetta, furto)».
Pietro Ingrao, futuro leader comunista e membro della direzione del Pci, fu più sobrio. Oltre a partecipare, come Guttuso, ai Littoriali ed essere ammesso nel novero dei Poeti, al tempo di Mussolini, si limitava a esortare «i poeti del teatro nuovo a rinunciare a pigri rifacimenti di motivi in camicia nera; partano bensì dal presente per esplicare piuttosto un’azione formatrice sul popolo, per svegliare nuove idee e prospettive, per creare i nuovi miti della Rivoluzione». A quei tempi Ingrao non pensava a una rivolta comunista per conquistare il Palazzo d’inverno, ma a una rivoluzione fascista. «Il Duce ha detto che non bisogna aver paura di avere coraggio. Coraggio, slancio, entusiasmo: ecco dei termini che sono ricorsi spesso e che ci premevano». Poi, come Veltroni farà in seguito col comunismo, Ingrao si assolse raccontando che era già un antifascista e combatteva il fascismo «dall’interno».
Spadolini, in seguito segretario repubblicano e presidente del Consiglio, non fu da meno e nel 1944, dopo l’armistizio, scrisse un articolo pieno di elogi per il Duce. «Mussolini ha fatto una politica ardita, ardente, perentoria talvolta, prudente talaltra, spregiatrice di convenzioni e consuetudini anacronistiche, nemica dei sentimentalismi e delle retoriche, ma sempre e solo italiana, orgogliosamente italiana. Cioè, in una parola, ha inteso restituire al popolo italiano, nei fatti con lo straniero, quella dignità, quella coscienza di sé, del proprio passato, delle proprie possibilità, quel prestigio e la fierezza e quasi alterezza, quello stile, quel senso, diciamolo pure, di superiorità, quel lievito, quello stimolo di grandezza, quello slancio verso l’espansione, che gli erano sempre mancati nei primi anni della sua unità».
Mi fermo qui. Credo che possa bastare a capire che gli italiani, fino quasi alla fine del regime, non sono stati - se non con poche eccezioni - antifascisti, ma fascisti e gran parte degli intellettuali quasi fino all’ultimo sono stati fascistissimi, anche se dopo si riscoprirono partigiani. Mirella Serri, in un libro di qualche anno fa, li definì i redenti. Giornalisti, scrittori, studiosi che vissero due volte, prima applaudendo il fascismo, poi applaudendo - molti, non tutti - l’antifascismo. Trasformisti, opportunisti, conformisti o semplici «poveri diavoli» costretti a vendere il loro lavoro e le proprie idee? La Serri non li giudica, si limita a parlare di una grande rimozione.
Oggi tuttavia si celebrerà la Resistenza, attribuendo a essa la vittoria contro il nazifascismo. Secondo Giorgio Bocca, che lo ha scritto in un libro dedicato alla lotta partigiana, nel settembre del 1943 ad avere imbracciato il fucile per combattere contro le milizie della Rsi e i soldati di Adolf Hitler erano poche e isolate bande, con 1.500 uomini, che nel novembre sarebbero diventati 3.800. L’anno dopo, 12 mesi prima della liberazione, i partigiani risultavano 12.600 e Ferruccio Parri, nell’estate di quel 1944 li stimò in 50.000. Ma all’inizio di marzo del 1945 secondo Bocca erano già diventati 80.000 e il 15 aprile, dieci giorni prima della fine della guerra, 130.000, per poi diventare 200.000 e anche 300.000. Maurizio Stefanini tempo fa stimò che solo un partigiano su 23 avesse combattuto per almeno un anno, mentre alcuni lo fecero solo gli ultimi dieci giorni del conflitto.
Tanto per chiarire le forze in campo, nel 1943 i soldati tedeschi in Italia erano 450.000, cui si sommavano i 150.000 dell’esercito della Rsi più altri 150.000 appartenenti alle milizie in camicia nera. Nell’aprile del 1944 il comando germanico rafforzò il contingente di stanza nel nostro Paese, arrivando a 800-900.000 uomini. In pratica, i nazifascisti disponevano di più di un milione di militari. Gli alleati nell’estate del 1944 invece ne schierarono tra i 600.000 e i 700.000, ma la differenza la fecero gli aerei, le navi da guerra, l’artiglieria, i carri armati e i mezzi da trasporto, che americani e inglesi sbarcarono in gran quantità. Dal punto di vista militare, dunque, la Resistenza fu poca cosa, ma 80 anni di retorica partigiana e di rimorsi di una classe politica e intellettuale che voleva autoassolversi l’hanno trasformata in qualche cosa di decisivo.