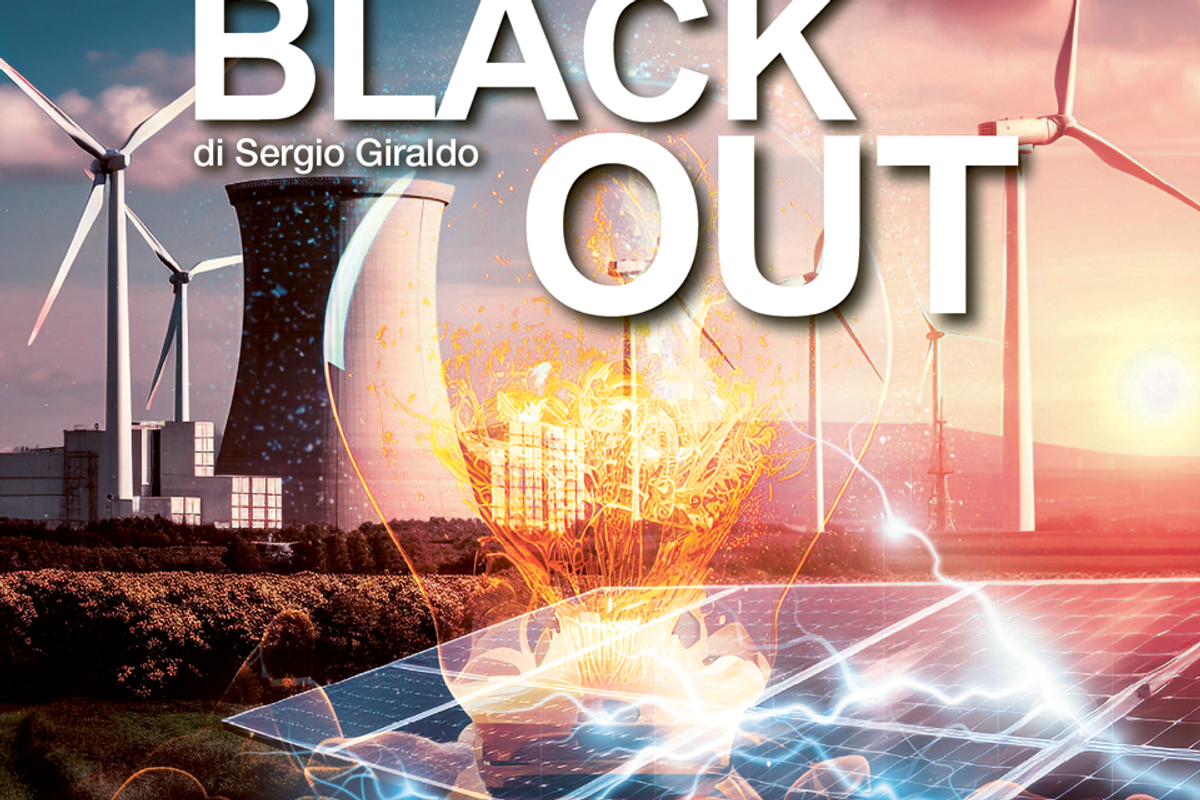C'è chi interroga i fondi di caffè per sapere come andrà domani. A noi serve guardare il cucchiaino di zucchero per sapere che se l'Europa non cambia il futuro sarà pessimo. Lo zucchero è il più grande disastro che l'Europa abbia commesso per accontentare gli appetiti di Germania e Francia, che rischiano di restare vittime del loro egoismo. Dal 2017, finito il regime di quote produttive e caduti i dazi, il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale è crollato del 70%. Questo ha significato la morte dello zucchero in Italia, dove 4 pacchetti di zucchero su 5 sono d'importazione, ma ha sconvolto il mercato. Segno evidente che le politiche liberistiche e di potenza che piacciono a una certa Europa sono fallimentari. Perché questa Europa ha ucciso una parte consistente dell'agricoltura e dell'industria italiana.
I mandanti sono la Francia e la Germania con il supporto dell'Olanda, gli esecutori sono stati i nostrani governanti; quelli del «ce lo chiede l'Europa» quelli, per dirla come cantava Fabrizio De André - con lo zucchero aveva una certa parentela - in Bocca di rosa, che oggi vorrebbero dare buoni consigli perché non possono (si spera) dare più cattivo esempio. Un nome su tutti: Romano Prodi che si è ingegnato prima da presidente dell'Iri, poi da presidente della Commissione europea, infine da presidente del Consiglio a distruggere l'agroalimentare italiano. E pensare che la sua Nomisma i primi incarichi li ebbe proprio dal mangia e bevi e che tra le sue fila è cresciuto anche Paolo De Castro, ministro dell'agricoltura che firmò la disfatta dello zucchero italiano.
Gardini e mani pulite
Doloroso prenderne atto oggi che fanno 120 anni dalla fondazione dell'Eridania, ormai non più italiana, e mentre tutti hanno celebrato nella scomparsa del fu procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli Mani pulite come l'inchiesta che ha cambiato l'Italia. Nel senso che l'ha distrutta. Può capitare occupandosi di barbabietole di domandarsi se la morte di Raul Gardini a seguito di un pezzo d'inchiesta di Mani pulite che fece secchi Psi e Dc, ma lasciò intonso il Pci che pure riceveva tangenti dall'Italia e rubli dall'Urss, non sia stato un favore per qualcuno. L'Italia c'era già passata con Enrico Mattei. Allora si parlava di petrolio, con Gardini anche di zucchero che sarà probabilmente il petrolio del futuro. Per questo nel mondo c'è una guerra senza quartiere su questa materia prima e l'Italia è stata condannata alla marginalità proprio dall'Europa, dove è stata scatenata una guerra industriale da Germania e Francia contro i Paesi cosiddetti periferici con una concorrenza sleale.
Chiusi 33 impianti
In Italia avevamo fino al Duemila 36 impianti e producevamo circa 1,5 milioni di tonnellate di zucchero, con aziende praticamente in ogni regione che ci rendevano quasi autosufficienti. Poi Prodi ha firmato nel 2006 la fine delle quote, ha aperto il mercato, nel 2017 finito il regime di prezzi assistiti e da noi lo zucchero è diventato amarissimo. Quest'anno il terzo zuccherificio italiano superstite di 60 che ne avevamo negli anni Ottanta non lavorerà. Di impianti aperti ne restano solo due: produrranno, se va bene, 250.000 tonnellate di zucchero, in un Paese come il nostro che ne «mangia» quasi 2 milioni.
Ma perché importiamo 1,5 milioni di tonnellate di zucchero e le fabbriche che lo producono in Italia sono così poche e chiudono pure? Perché ce lo chiede l'Europa. È il 1986 quando l'Europa decide che lo zucchero è strategico: non vuole farsi invadere da quello d'importazione, impone le quote nazionali produttive e remunera barbabietole e zucchero con incentivi al prezzo, mentre mette forti dazi. Funziona tutto per un po' di anni, ma poi i tedeschi, che sono i primi trasformatori e, soprattutto, i francesi, si accorgono che in Italia c'è un tipo che rompe le scatole. Quel tipo è Raul Gardini che, dopo essersi comprato l'Eridania - l' acquista dal petroliere editore Attilio Monti che aveva affidato la gestione del suo impero a Giuseppe De André, il padre di Fabrizio - ha dato l'assalto alla Beghin Say , il più grande zuccherificio francese dall'epoca di Napoleone. Valery Giscard d'Estaing, presidente de la Republique, fece argine a Gardini, ma alla fine «il pirata» vinse. Gardini voleva costruire un enorme polo chimico industriale da materia prima agricola. Poi arriverà Antonio Di Pietro, l'Eridania finirà ai Maccaferri, la Montedison come sappiamo e l'Europa potrà banchettare sulla chimica italiana. Ma l'incursione di Gardini suonò come un campanello d'allarme e tedeschi e francesi se ne ricordarono appena arrivò l'euro.
Come scrive autorevolmente in uno studio Ludovico Fiano, utilizzano la nuova moneta per svalutare le loro produzioni e sono convinti che aprendo il mercato - nel Wto hanno già fatto entrare la Cina - alla globalizzazione venderanno zucchero a tutti. Così impongono la fine delle quote nazionali di produzione e nel 2006 Romano Prodi e il suo ministro dell'agricoltura Paolo De Castro firmano. Risultato: il prezzo passa da 600 euro a tonnellata a 350 euro, chi ha costi di produzione più alti - e l'Italia e tra questi - viene spazzato via dal mercato. Dice Stefano Dozio, direttore di Coprob di fatto l'ultimo produttore di zucchero in Italia: «Oggi due francesi e due tedeschi controllano il mercato e portano lo zucchero in Italia a 360 euro a tonnellata compreso il trasporto. Noi a questi prezzi non ci stiamo dentro: i nostri soci tirano la cinghia, abbiamo ridotto la remunerazione del 10 per cento, ma non basta». La situazione italiana è disastrosa. L'Eridania ceduta dal gruppo Maccaferri ora è di proprietà dei francesi della Cristal Union e l'Italia dello zucchero è limitata a soli tre stabilimenti; due sono del gruppo cooperativo Coprob-Italia Zuccheri, uno è della Sadam della famiglia Maccaferri ed è quello che quest'anno non produrrà zucchero. Hanno deciso di avviare la produzione di bioplastiche. Il risultato è che l'Italia è ormai quasi totalmente dipendente dalle forniture estere.
Marchio d'origine
Il gruppo Coprob è l'ultima frontiera della bieticoltura italiana: impiega in filiera circa 25.000 persone, coinvolge 7.000 aziende per 32.000 ettari coltivati a barbabietola tra Emilia, Veneto e parte della Lombardia e ha due stabilimenti. Si rischia di vedere crollare del tutto la nostra bieticoltura con un doppio paradosso: siamo il primo Paese d'Europa per produzione dolciaria, ma dobbiamo comprare tutto lo zucchero all'estero; siccome la bieticoltura è necessaria alla rotazione, soprattutto del grano, finirà che non avremo la materia prima che ci serve per fare la pasta, un altro nostro primato. L'allarme è stato dato dalla Coldiretti, che evidenzia come sarebbe necessario intervenire con un'etichettatura d'origine dello zucchero da rintracciare anche nei prodotti che lo usano come ingrediente. Insomma, se un dolce è made in Italy anche lo zucchero dovrebbe essere italiano. Questo è il ragionamento alla vigilia della campagna di trasformazione di quest'anno, che sarà fatta solo a Minerbio (nel Ferrarese) e a Pontelongo in Veneto dove ci sono gli stabilimenti Coprob, perché lo zuccherificio Sadam di San Quirico nel parmense e quello di Termoli in Molise non produrranno.
L'idea di Coldiretti è di attivare contratti di filiera con i grandi confezionatori di dolci e cercare un rilancio in sede internazionale. Il nostro ministro dell'agricoltura e turismo Gian Marco Centinaio ha provato a porre la questione in Europa, ma è stato respinto con perdite. La proposta italiana, per paradosso appoggiata anche da Paolo De Castro - l'ex ministro Pd che firmò nel 2006 la resa dello zucchero italiano - in commissione agricoltura a Strasburgo, avanzata da Centinaio era di remunerare lo stoccaggio della produzione in attesa della ripresa dei prezzi. Ma la Commissione ha detto no sbattendo la porta in faccia non solo all'Italia, ma a tutti i Paesi minori: dalla Moldavia alla Polonia, dalla Slovenia all'Ungheria che con i suoi 5,9 milioni di tonnellate è un produttore significativo. Perché lo ha fatto? Perché i colossi tedeschi - la prima produttrice in zucchero è la Sud Zucker che ha 31 stabilimenti - e francesi - Teros e Cristal Union - sono convinti di vincere la guerra mondiale dello zucchero. Ma hanno fatto molto male i conti. Perché lo zucchero bianco rappresenta solo il 20% della produzione mondiale, il resto viene dalla canna. E se è vero che il Brasile ha problemi produttivi, ora sul mercato globale si sono affacciate la Thailandia e soprattutto l'India, che in pochi anni è diventata il primo produttore mondiale. I grandi speculatori hanno già fiutato il business della guerra dello zucchero. Wilmar International, il più importante commerciante di olio di palma, ha comprato futures di zucchero per 2,3 miliardi di dollari e sta giocando a far alzare e abbassare i prezzi.
Il crollo dei prezzi
In questo contesto l'Europa rischia di essere marginalizzata anche perché non pone dazi, come dimostra l'accordo Mercosur che dà via libera allo zucchero brasiliano. Insomma, tedeschi e francesi rischiano di restare vittime della loro stessa aggressività. Un quadro che fa dire a Roberto Iovino e Raffaele Ferrone della Flai Cgil: «Dopo la fine delle quote, il mercato europeo dello zucchero ha visto un progressivo crollo dei prezzi, calati in pochi mesi di circa il 40%, passando da circa 550 euro a tonnellate a scarse 300. Una guerra commerciale a colpi di concorrenza sleale, finalizzata a rafforzare la posizione di mercato dei grandi gruppi francesi e tedeschi, che si è consumata nell'indifferenza (o complicità…) dei governi nazionali e della Commissione Ue. Ma in questa vicenda a perdere è l'intera Europa». Eh sì, perché se la fine delle quote ha desertificato l'Italia (abbiamo perso in 13 anni l'80% di produzione), la concorrenza mondiale sta creando problemi anche a tedeschi e francesi. La Sud Zucker ha già chiuso 4 impianti, i francesi di Saint Luois Succre hanno annunciato una pesantissima ristrutturazione. L'Europa dei furbi mastica amaro .
(4. Continua)