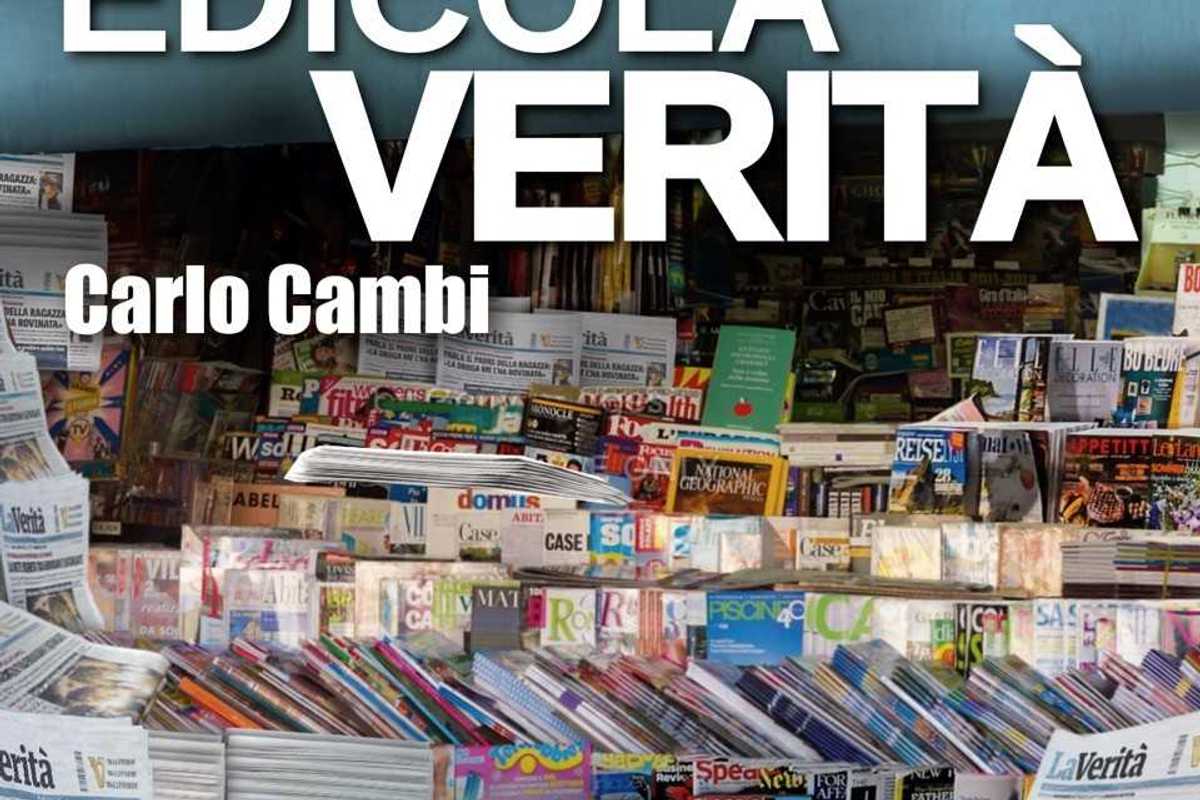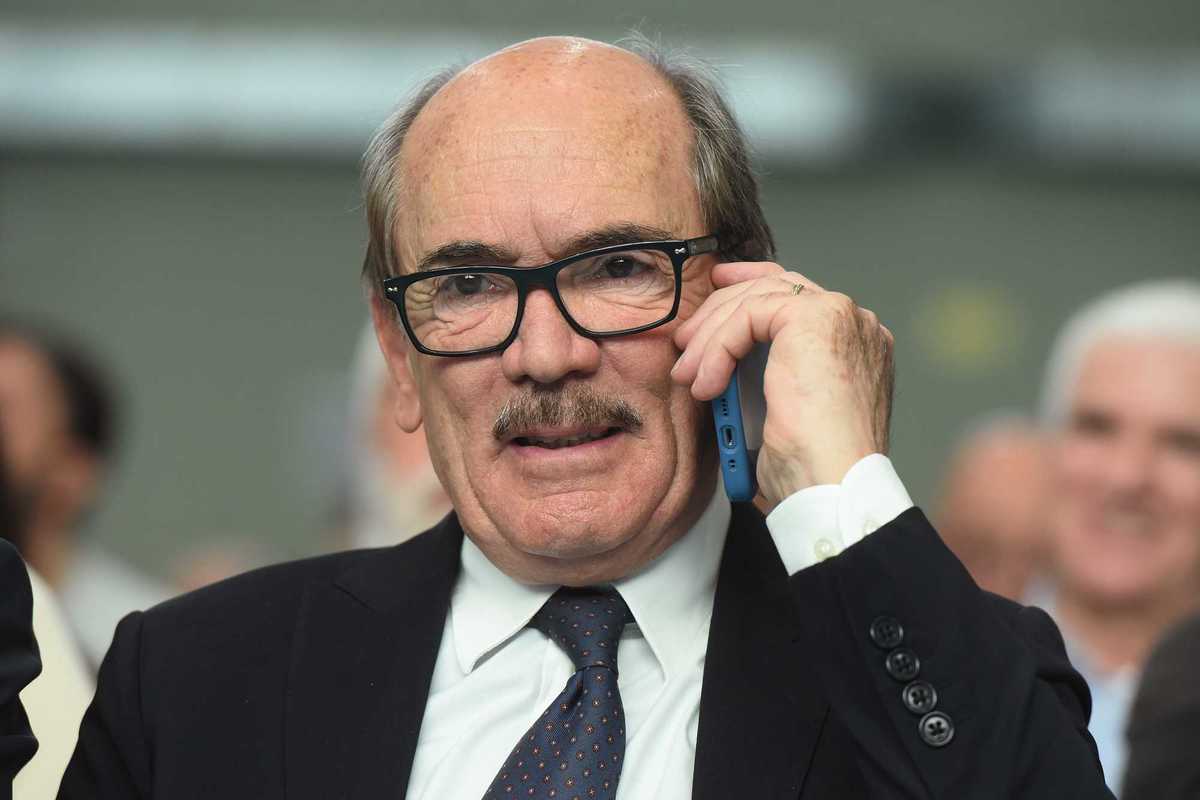«Vi racconto chi era mio zio Bisagno, partigiano che obbediva solo a Dio»

L'8 settembre 1943 il sottotenente Aldo Gastaldi non indietreggia davanti alle sue responsabilità, in accordo con un parroco nasconde le armi nell'orto di una canonica di Chiavari e sale in montagna. Da questo momento in poi diventa Bisagno, il comandante della divisione partigiana Cichero. Il comandante bianco, colui che sarà il Primo partigiano d'Italia.
«Sono riuscito a comprendere», aveva scritto ai genitori il 7 ottobre 1941, «che la vita non la devo vivere solo per me ma è come quella di un albero che, per diversi anni, ha strappato fatiche al giardiniere. Ora che è il momento del frutto, non è sua facoltà, ma suo dovere fruttare». Il 31 maggio scorso, 76 anni dopo, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha firmato l'editto per l'apertura del processo di beatificazione di Aldo Gastaldi, i cui frutti evidentemente non sono stati soltanto quelli di una medaglia d'oro della Resistenza. Proprio oggi a Rovegno in provincia di Genova si tiene una cerimonia commemorativa per ricordare lui e tutti i caduti della gloriosa divisione Cichero; celebra la messa il vescovo ausiliare del capoluogo ligure, monsignor Nicolò Anselmi e l'orazione commemorativa sarà tenuta dal sindaco Marco Bucci.
Con il via al processo di beatificazione la retorica partigiana passa un po' di lato, per chi sa guardare oltre le pieghe della storia. Infatti, c'è un uomo che ha vissuto piantando le proprie radici in Cielo. E, in effetti, le testimonianze su Bisagno sono concordi: il giovane di appena 23 anni, morto in un controverso incidente dopo aver riaccompagnato a casa i suoi uomini subito dopo la Liberazione, era un cattolico autentico di fede sobria e virile. Chi volesse farsene un'idea può guardare il docufilm che gli ha dedicato il regista Marco Gandolfo, con le testimonianze dei suoi uomini della Cichero e di altri documenti.
«Mio zio», racconta alla Verità il nipote omonimo Aldo Gastaldi, «si impose per autorevolezza grazie a determinate regole che poneva per entrare nella sua divisione e le regole più ferree le doveva rispettare lui: il comandante mangiava sempre per ultimo e faceva i turni più gravosi. Inoltre, nessuno doveva bestemmiare, né toccare le donne, né toccare nulla della roba dei contadini a meno che non venisse offerto e comunque veniva pagata al prezzo del mercato nero».
La sua fede robusta era nata in famiglia, soprattutto dalla madre, Maria Lunetti, che gliela trasmise con l'esempio. «Questa fede», dice il nipote, «emerge in particolare dalle lettere che Bisagno scrisse proprio alla famiglia. Basti pensare che si riferisce a Dio - testualmente - come “unica guida". In un'altra lettera, quando aveva 20 anni, scrisse: “Non trovai nessuno, sulla terra, che potesse darmi giustizia e pace. Ma trovai l'una e l'altra in Dio. Con Lui ho compreso che la gloria terrena è molto effimera e passeggera, mentre la gloria di Dio è eterna"».
La figura del partigiano scomodo in Bisagno è data dal fatto che non era inquadrabile politicamente e si oppose fortemente a una lettura politicizzata della Resistenza. Dopo, una volta ottenuta la liberazione, si sarebbe potuto fare politica, ma nel momento della battaglia il suo obiettivo era solo quello di restare uniti per la libertà della patria. «Non volle mai avvicinarsi ad alcun partito perché si era accorto che la politica divide e lui voleva l'unità», spiega il nipote. «Un'aspirazione che riuscì a coltivare grazie al suo essere cattolico e al suo considerare, al di là delle ideologie politiche, quello che è il solo, vero orizzonte di libertà, ossia Cristo». Purtroppo, quella unità per cui Bisagno si è sempre battuto non è mai riuscito ad ottenerla davvero, a causa delle note azioni di continua politicizzazione delle formazioni partigiane.
Per la famiglia, riprende il nipote, «questa causa è una gioia perché risponde all'esigenza di dare testimonianza di quello sguardo di Aldo sempre rivolto al Cielo, in fondo questo è il suo vero tesoro che non potevamo tenere per noi. In un mondo che propone l'effimero e il passeggero, quali alimenti quotidiani e gratuiti a tutti, Aldo sono convinto si rivolga ai giovani e non solo testimoniando per chi e per cosa valga la pena vivere. E anche per chi vale la pena morire. Ha vissuto in un periodo tremendo, dove il mondo era diviso, come ha scritto san Giovanni Paolo II nel suo ultimo libro Memoria e Identità, tra due grandi ideologie del male: nazismo e comunismo. E ci indica un criterio di discernimento assoluto tra bene e male che oggi poco viene considerato per ciò che è, e che ha garantito a lui di rimanere libero sempre. La Parola di Dio».
La poetessa Elena Bono, staffetta partigiana nella 6^ zona operativa comandata da Bisagno, lo incontrò una sola volta, ma rimase folgorata da «quello sguardo dritto», che «andava a segno». Intervistata dal regista Marco Gandolfo nel libro Bisagno. La resistenza di Aldo Gastaldi (Itaca, 2018), ha detto che il comandante bianco «sapeva che per esser liberi bisogna cominciare col rinunciare a certi facili piaceri. Non è facile. Doveva leggere il Vangelo, c'è poco da dire. Speriamo che qualcuno a un certo punto scelga Bisagno come guida interiore. Speriamo. Noi abbiamo testimoniato di lui…».
L'avvio del processo di canonizzazione potrebbe un domani attestare che Bisagno non è soltanto un esempio di coraggio e dedizione, ma che lui, Aldo Gastaldi, fedele laico, la libertà che non passa l'ha raggiunta davvero. Senza questa liberazione, doveva pensare Bisagno, tutte le altre sono assai limitate, per quanto importanti.