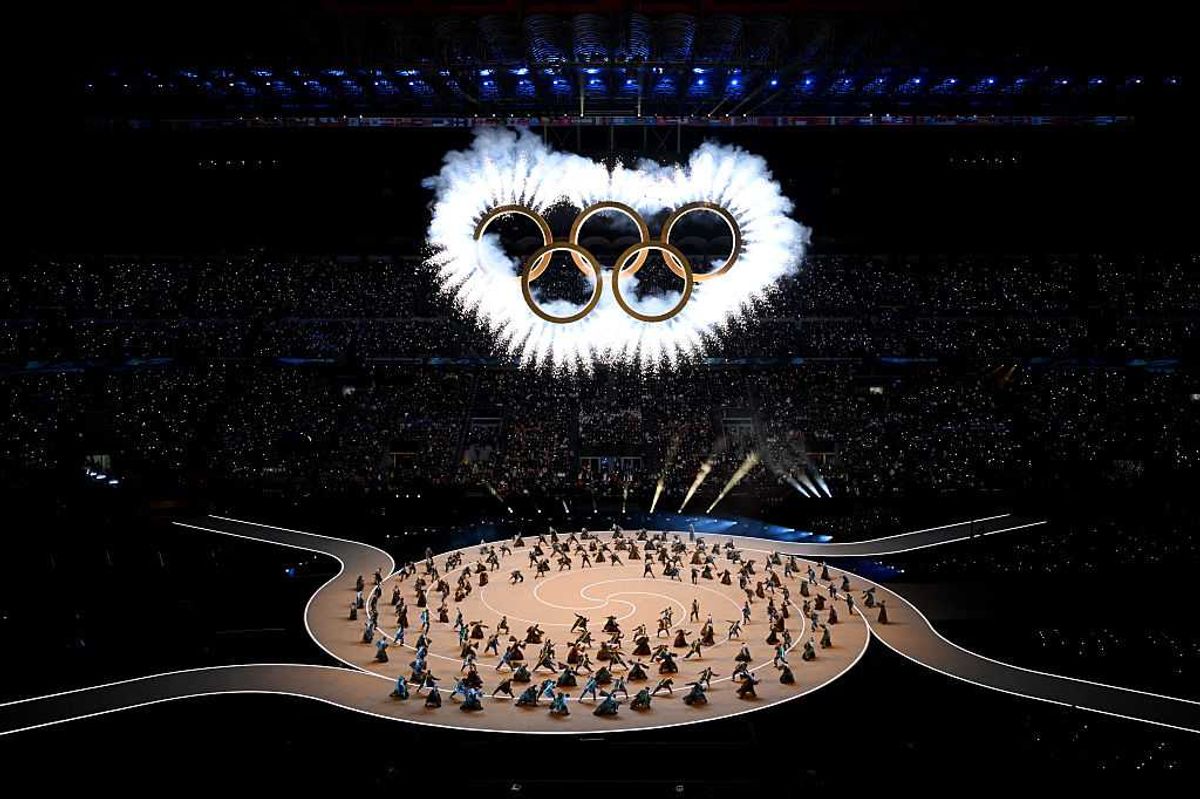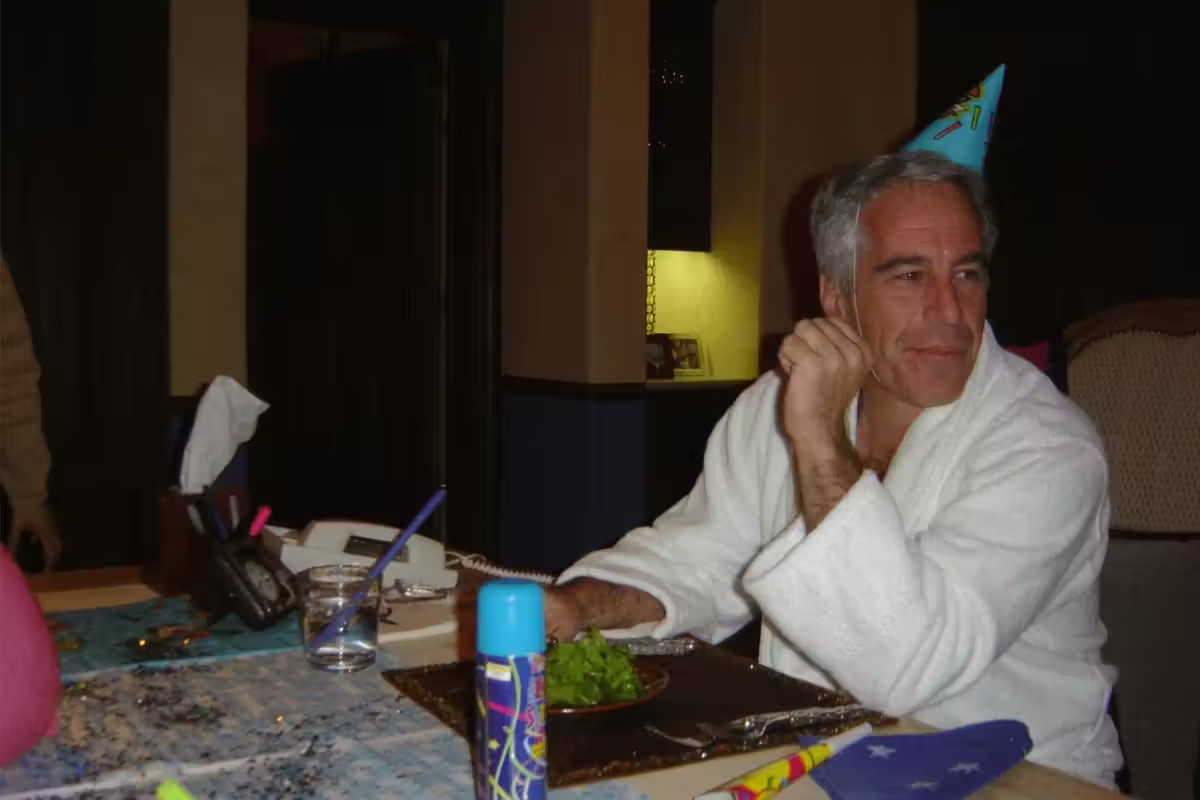«Una volta la famiglia ti osteggiava ora ti spinge a recitare, ma sbaglia»

Antonello Fassari è un attore, e un signore, di una volta. Non ama parlarsi addosso, ripercorrere, passo dopo passo, la sua fortunata carriera, preferendo analizzare, con l'ironia che lo contraddistingue sullo schermo, com'è cambiato il mestiere di attore, parallelamente alle mutazioni avvenute nel mondo dello spettacolo, negli ultimi 50 anni. Un tema strettamente legato al senso di indossare una maschera e di esibirla davanti a un pubblico, sempre più disincantato.
Lei è figlio di un avvocato e uno dei ruoli più importanti della sua carriera è quello dell'avvocato Rocco Mangia in Pasolini un delitto italiano. Come mai non ha intrapreso la carriera di suo padre?
«Eh, me lo chiedo anch'io! Per fare Rocco Mangia mi sono ispirato proprio a papà perché lui era un penalista di una volta, con il suo modo di fare molto accentratore. I penalisti erano i principi del foro e non si vergognavano di esternare al massimo anche una certa retorica. Ultimamente per come è andato a finire 'sto lavoro ho pensato: “Ma quasi quasi potevo fa' l'avvocato" perché mio padre mi ha praticamente diseredato per colpa di questa cosa».
Non era contento della sua scelta?
«Neanche un po'!"».
Poi ha cambiato idea?
«Come idea non l'ha cambiata mai, ma quando mi ha chiamato a lavorare Eduardo De Filippo, ha detto: “Chissà, forse sarà un mestiere vero". Avevo fatto al liceo uno spettacolo per le scuole, mi era piaciuto molto, ma non è che pensassi più di tanto a fare l'attore, così il primo anno di Legge sono andato a studio da papà, ma avevo capito che non era la mia strada. Ho fatto l'esame all'Accademia nazionale d'arte drammatica, con l'idea: “Se mi prendono bene, sennò fa niente". Invece mi hanno preso e da lì è partita questa strada».
Una strada non facile…
«Prima, per chi non era un figlio d'arte, c'era una selezione naturale che cominciava già in famiglia. Se dicevi: “Vado a fare l'attore, il regista, lo scenografo, il costumista...", ti guardavano come un pazzo! È una riflessione che faccio perché oggi mi stupisce il fatto che si presentino in mille a Roma, in mille a Milano, una cosa impressionante».
Invogliati molte volte dalla famiglia, al contrario di quanto accadeva un tempo...
«Esatto, con la famiglia che favorisce l'ingresso nel mondo dello spettacolo. Preferivo il mestiere che c'era ai tempi miei perché era completamente un altro mondo, sconosciuto ai più. Oggi è sconosciuto uguale, ma c'è come l'idea, non so se dovuta ai social o ad altro, che sia invece un mondo accessibile. Questo è un problema perché poi, siccome questo è il mestiere delle illusioni e delle disillusioni, c'è gente che ce rimane sotto. Non è più concepito come una carriera, con l'idea che facendolo poi si possa invecchiare, sembra che uno giochi al Superenalotto: però anche se uscisse il numero, il problema non è lavorare qualche anno, ma lavorare tutta la vita».
Paga l'aver fatto l'Accademia, per chi ha avuto la fortuna e il merito di entrarvi.
«Paga forse quell'Accademia di quegli anni, in cui ancora avevo Orazio Costa come insegnante, per dire. Noi studiavamo e poi entravamo nel mondo del lavoro preparati. C'era una genia di registi teatrali all'epoca, non solo Ronconi che è stato il mio maestro quando è venuto in Accademia, ma anche Trionfo, Cobelli, Squarzina, Enriquez, per citarne alcuni, perciò uno usciva dall'Accademia e andava a fare il teatro, che era ritenuto una cosa importante. Adesso mi sembra che cerchino tutti il cinema o la televisione, fanno il teatro perché si deve fare, come per entrare nell'ambiente, ma non con l'idea che possa essere una carriera, come una volta».
La sua prima occasione come attore cinematografico è stata in Atsalut pader di Paolo Cavara, nel 1979.
«Sì, lo ricordo come un incubo perché ero rigidissimo, avevo una paura terribile».
Da allora ha alternato commedie e film drammatici.
«Mi sono sempre contraddetto: facevo un cattivo, poi un personaggio comico, quindi un altro tragico, un altro comico. A noi all'epoca dicevano che un attore doveva fare tutto, e io continuo ancora a pensarlo. Siccome da un mondo più aristocratico è diventato un mondo piccolo borghese, ognuno adesso ha le sue etichette: quello fa il tragico, quello fa il comico... Poi c'è stato un periodo in cui ti dicevano: “No, non fare troppo". Io mi sono sempre chiesto se avessero detto questa cosa al Gassman de I mostri o a Totò!».
È cambiato tutto...
«C'è stata, secondo me, una grossa involuzione da un punto di vista della libertà di fare le cose, di pensarle, di crearle, di idearle, e sono andati verso la ricerca assoluta del consenso, dell'audience, che dal mondo della televisione, dove si vende la pubblicità, si sono trasferiti sia al teatro che al cinema. Questo mi ha addolorato molto. Vedo attori molto bravi che non possono fare a meno di essere piacioni. Mi ricordo che un giornalista chiese a Michele Placido, quando fece un personaggio tremendo ne La sconosciuta di Tornatore, “perché lei ha accettato un personaggio così?", lui è un po' trasalito, poi ha risposto: “Ma qualcuno li dovrà fare questi personaggi?". O è diventato tutto edulcorato? Poi c'è un genere che esiste solo in Italia: il genere impegnato. Ma che vor dì impegnato?».
Prima lo chiamavano cinema d'autore, ma mancando ora gli autori è più facile chiamarlo cinema impegnato.
«Se la suonano e se la cantano! Nel cinema italiano sono anni e anni che manca una descrizione reale della società, per esempio non ci sono film in cui si vedono i ragazzi che vanno a studiare all'estero. Ci sono dei copioni, più o meno impegnati, che vanno a cerca' de capì alcune cose della situazione, ma non è la società reale. Lo dico perché vivo in mezzo alla gente, ho sempre vissuto così. È tutto meta-teatrale, meta-cinematografico, tutto meta!».
Un'aurea mediocrità…
«Sì, viviamo in un'aurea mediocrità».
Lei ha fatto in tempo a lavorare con i grandi autori, Steno, Lattuada, Scola. È figlio di due epoche.
«Ho conosciuto la coda di quel vecchio, grande, nostro cinema, giusto la coda, per carità, però ho avuto a che fare con gente completamente diversa, molto aristocratica, anche nelle sue figure più popolari. Era più bello il nostro mondo quando era lontano, inaccessibile, era più interessante, c'era un confronto continuo».
Oggi invece?
«I giovani attori mi chiedono: “Cosa facevate senza i telefonini?" e io: “Guardate che faccio i provini da 10-12 anni, prima non si facevano" e mi guardano tutti sconvolti. Non si facevano perché c'erano gli aiuto registi che andavano in giro a vedere gli attori e poi incontravi il regista. Adesso 'sti provini non si sa dove vanno, chi li vede. Quando un regista ti chiamava per lavorare con lui, voleva da te collaborazione, adesso te stanno a fa' un favore. Io mi rifiuto di fare i provini, non perché non voglio farli, ma voglio avere un incontro con il regista. Ci sono dei ragazzi all'opera prima che ti chiedono il self tape: “Lo faccio io a te un provino: ma chi sei, che hai fatto?!". Perché siamo arrivati a questo?».
È un po' avvilente.
«Un pochino sì, poi io, per carità, continuo a lavorare, però trovare dei lavori dove puoi mettere qualcosa di tuo è sempre più complicato. Dipende anche dal poco spessore dei copioni, in generale, perché poi abbiamo i nostri autori, anche molto bravi, ma il mestiere non si fa perché lavori con Fellini, si fa nella quotidianità di quello che offre il panorama generale. Magari ci fossero solo incontri eccezionali con grandi maestri».
Tra i suoi film più recenti, quale copione l'ha più convinta?
«Mi è dispiaciuto molto non aver dato continuità ad alcuni personaggi, come quello di Romanzo criminale o di Suburra perché mi sembra di aver offerto delle prove valide da un punto di vista drammatico. Ho fatto questi film perché mi hanno voluto i registi, Placido e Sollima, ma non è successo niente. Perché? Perché ho fatto I Cesaroni? Sarà per quello? Forse è perché non ho un approccio “piacionico"!».
O perché ha lavorato troppo con i fratelli Vanzina, che in Italia sembra una colpa…
«Sì, quasi una macchia indelebile. Io mi sono sempre trovato molto bene con loro».
Nel 1987 ha fatto il primo film con Carlo e Enrico, Montecarlo gran casinò, e l'ultimo film del padre, Steno, Animali metropolitani.
«Nel periodo del teatro, che ho fatto per tantissimi anni, a un certo punto decisi di prendere un anno sabbatico perché avevo ricevuto delle proposte che non mi avevano convinto. Mi misi a casa e mi inventai una canzone rap. Sono stato il primo in Italia a fare il rap. Incisi un disco con Lele Marchitelli e Danilo Rea, che avevano composto la musica. Con questo rap feci un provino da Antonello Falqui, il quale mi prese per Al Paradise. Steno mi vide in questo programma che andava in onda il sabato sera, mi chiamò per fare il suo film e mi segnalò anche ai figli».
Com'è stato scelto per I Cesaroni?
«Da quello che so, ci sono arrivato perché una serie di attori hanno detto di no. Mi hanno chiesto di fare un provino, l'ho fatto ed è andato bene. I Cesaroni sono quel tipo di successo che travalica un po' il prodotto in sé: è quando la televisione fa diventare i personaggi come un fratello, uno zio, un padre, un cugino, diventi uno di casa, e questa è una cosa che un po' mi mancava».
Le ha dato la grande popolarità, da strada…
«Quella affettiva, vedi che le persone per strada ti vogliono bene, al di là del tuo valore. Sono tutte occasioni nelle quali cerco di mettere dentro quel po' di umanità che ho. Io ho sempre cercato questo, privilegiandolo sugli aspetti tecnici. Ho ancora una visione del mondo dello spettacolo in senso universale, credo ancora che si debba parlare a tutti, con grande rispetto del pubblico inteso proprio nella sua totalità. Io non lavoro per un critico o per quel regista impegnato, lavoro per tutti. Poi è bello quando una persona ti dice: “Mi hai fatto fare un sacco di risate… ero triste invece mi hai tirato su quel giorno". Così ha quasi un senso quello che si fa, sennò perché lo facciamo? Il mio mestiere non è esibire, parlare di sé, ma comunicare, raccontando le storie degli altri».