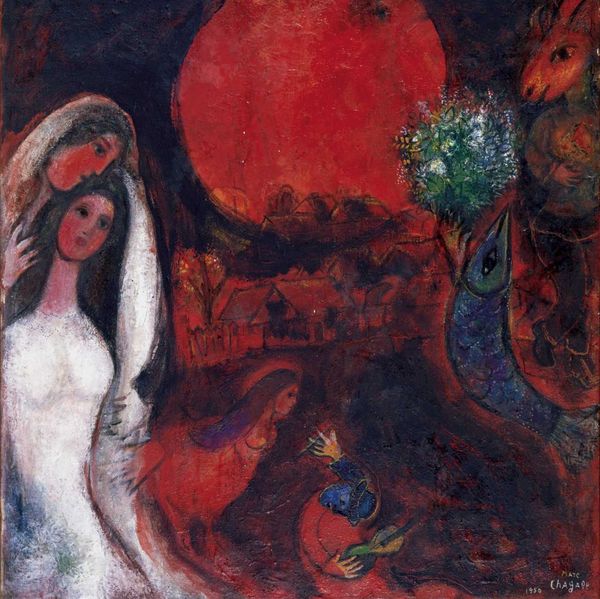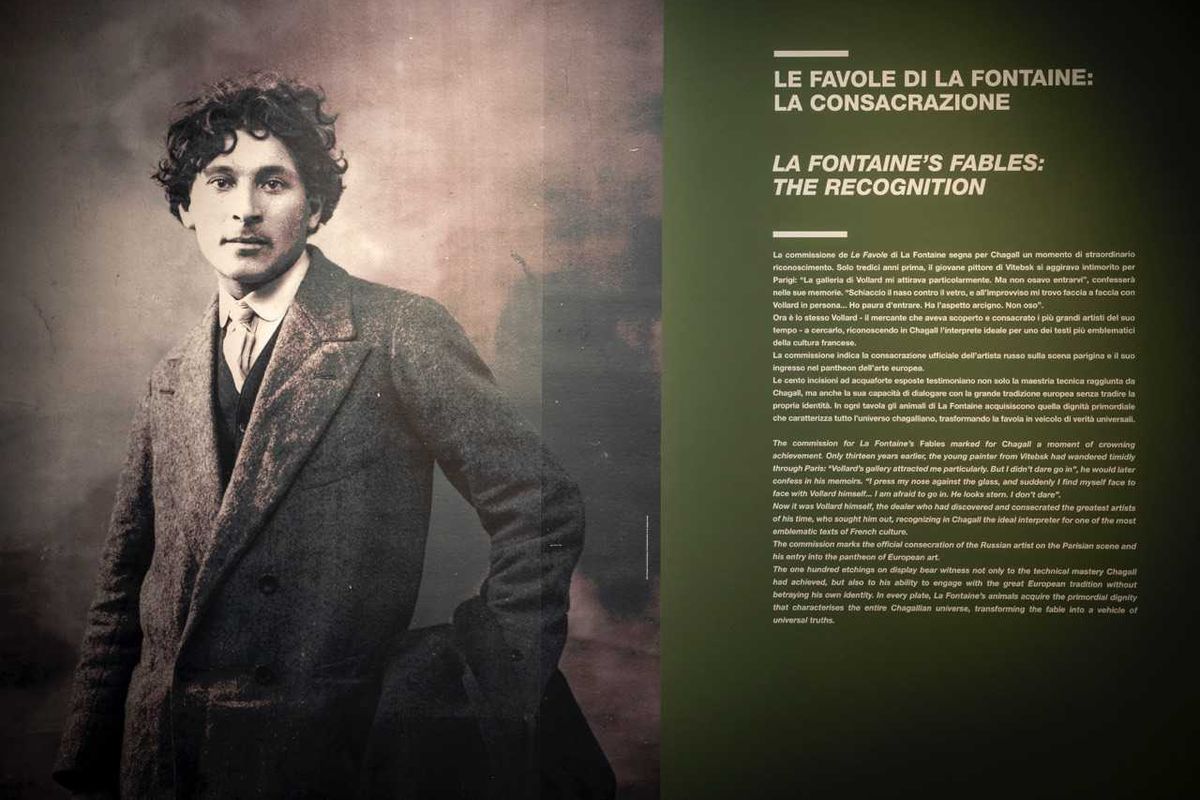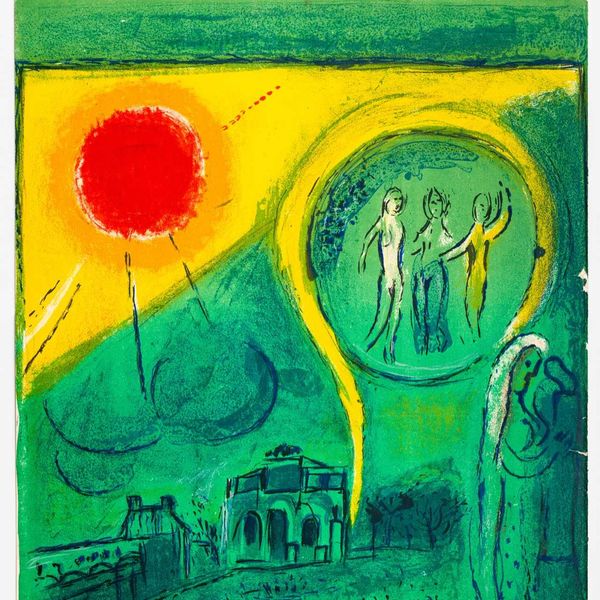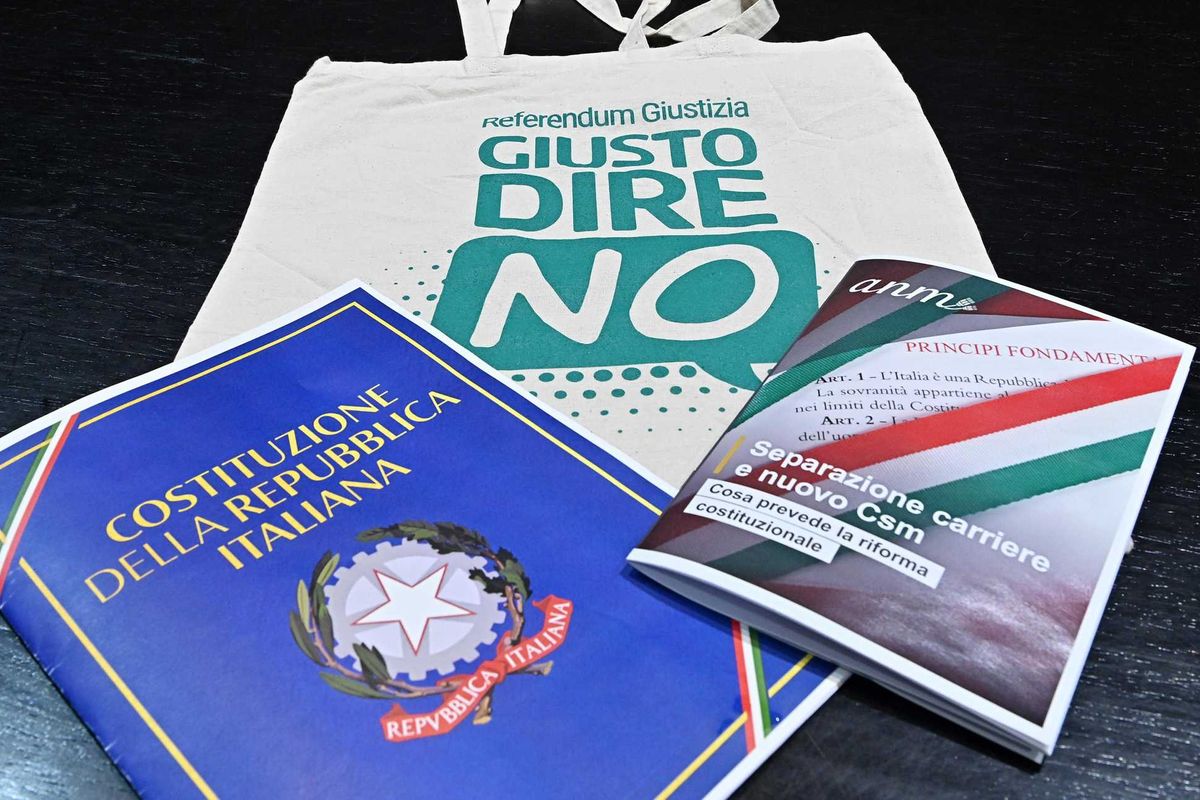Linguaggio presidenziale ma con venature antipolitiche. Il discorso sullo stato dell'Unione, tenutosi questa notte a Washington, ha mostrato un Donald Trump particolare, che sembra di fatto già guardare alle presidenziali del 2020. Un presidente che è più volte ricorso al principio dell'unità nazionale (ricordando anniversari storici che vanno dalla «grande crociata» di Eisenhower allo sbarco sulla luna), non rinunciando però alla sua classica linea di figura antisistema e avversa ai crismi del professionismo politico.
Nei suoi 82 minuti di discorso, il magnate newyorchese ha innanzitutto rivendicato quelli che considera i principali successi della propria amministrazione: dalla ripresa economica alla creazione di nuovi posti di lavoro, dalla riforma del sistema giudiziario al taglio delle tasse, passando per lo scontro commerciale con la Cina. Il tutto condito da un accorato appello all'unità, in un momento molto delicato in cui un mancato accordo sull'immigrazione potrebbe far scattare nuovamente lo shutdown tra pochi giorni. Elemento che ha portato il magnate a tendere una mano ai democratici. «Insieme», ha detto Trump, «possiamo rompere decenni di stallo politico. Possiamo superare tutte le divisioni, possiamo superare vecchie divisioni, guarire vecchie ferite, costruire nuove coalizioni, forgiare nuove soluzioni e sbloccare la straordinaria promessa del futuro dell'America. La decisione sta a noi». Non a caso, il presidente ha toccato alcuni tasti particolarmente cari a buona parte della sinistra dem. Non solo ha citato la necessità di una riforma infrastrutturale, ma sulla sanità ha sostenuto di volersi battere per abbassare i costi dei medicinali e tutelare i pazienti con condizioni preesistenti. Insomma, una mano tesa che ha il chiaro obiettivo di riportare compattezza all'interno di un Congresso spaccato: un Congresso che, in queste condizioni, rischia evidentemente di paralizzare la sua attività di governo.
Ciononostante il presidente non ha rinunciato ad alcuni suoi vecchi cavalli di battaglia. Innanzitutto - pur celandola sotto la velatura di uno spirito bipartisan - il magnate ha ribadito la propria linea antipolitica. «L'agenda che presenterò questa sera», ha dichiarato, «non è un'agenda repubblicana o un'agenda democratica, è l'agenda del popolo americano. Molti di noi hanno condotto una campagna con le stesse promesse di base, per difendere i posti di lavoro americani e chiedere un commercio equo per i lavoratori americani».
In secondo luogo, il presidente ha tenuto il punto sulla questione dell'immigrazione, ribadendo la necessità di rafforzare e difendere il confine meridionale. «È una questione morale. La situazione senza legge del nostro confine meridionale è una minaccia per l'integrità, la sicurezza e il benessere economico di tutta l'America. Abbiamo il dovere morale di creare un sistema di immigrazione che protegga la vita e l'occupazione dei nostri cittadini. Ciò include il nostro obbligo nei confronti dei milioni di immigrati che vivono qui oggi, che hanno seguito le regole e rispettato le nostre leggi». Perché «la tolleranza verso l'immigrazione illegale non è compassionevole: è in realtà molto crudele», ha affermato, citando i benefici che i trafficanti di esseri umani traggono dal caos che si verifica al confine con il Messico. Da qui, l'esigenza di un muro.
Infine, sulla politica estera il presidente ha mescolato due linee contrapposte: se da una parte è venuto incontro alle correnti interventiste dell'establishment di Washington (sottolineando il ritiro dal trattato Inf con la Russia), dall'altra ha ricordato con orgoglio il processo di distensione avviato con la Corea del Nord, annunciando un nuovo incontro con Kim Jong Un il 27 e il 28 febbraio in Vietnam. Ha inoltre evidenziato la sua prospettiva tendenzialmente isolazionista, dichiarando: «Le grandi nazioni non combattono guerre senza fine». Elementi che mettono in luce come il presidente stia faticando non poco a superare quelle logiche da Guerra fredda che aveva promesso di abbandonare. Logiche che i falchi di Washington cercano di mantenere vive e vegete ma che il magnate, pur tra alterni successi, sta pian piano riuscendo a picconare.
Con questo discorso, Trump ha tracciato il perimetro delle relazioni con il Congresso dei prossimi due anni. Il presidente sa di trovarsi infatti davanti a un bivio, dovendo scegliere se aprire all'Asinello o prediligere al contrario la strada dello scontro totale. Bisognerà adesso vedere se i punti di convergenza tra i due fronti (a partire della riforma infrastrutturale) serviranno realmente a gettare un ponte, inaugurando una collaborazione in grado di portare avanti un'agenda bipartisan. Certo è che la questione dell'immigrazione continua a rivelarsi una spada di Damocle sospesa sulla Casa Bianca: un elemento su cui nessuno sembra veramente disposto a fare un passo indietro. Né Trump (che sulla proposta del muro ha costruito la propria campagna elettorale nel 2016), né i democratici (che vogliono colpire la credibilità del presidente nell'aspetto saliente del suo storico programma politico).
In tutto questo, le presidenziali del 2020 si fanno sempre più vicine. E, anche in tal senso, il discorso di stanotte segna uno spartiacque. Perché, nonostante i toni presidenziali e concilianti, le parole di Trump possono paradossalmente suonare anche come una dichiarazione di guerra. La dichiarazione di un presidente pronto nuovamente a scendere in campo contro tutto e tutti. Perché il magnate sa bene che, in fin dei conti, l'ostruzionismo dei democratici potrebbe riportarlo alla Casa bianca. E tutto si potrà dire di Trump. Tranne che non sappia fare campagna elettorale.