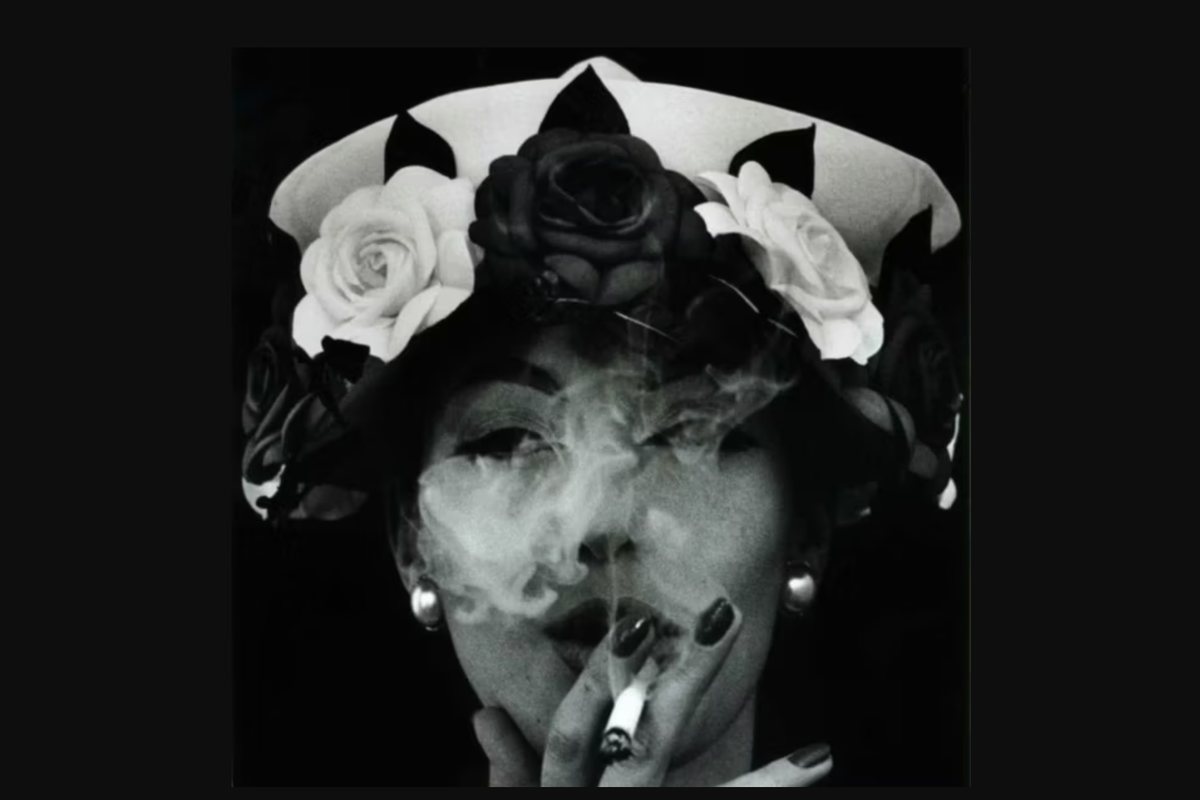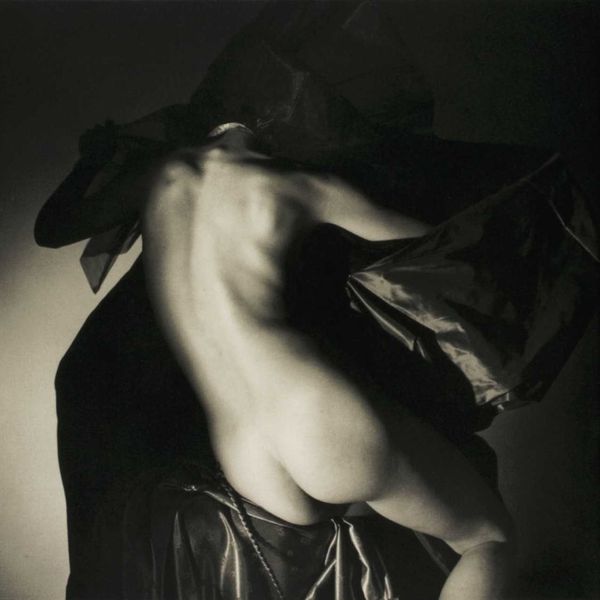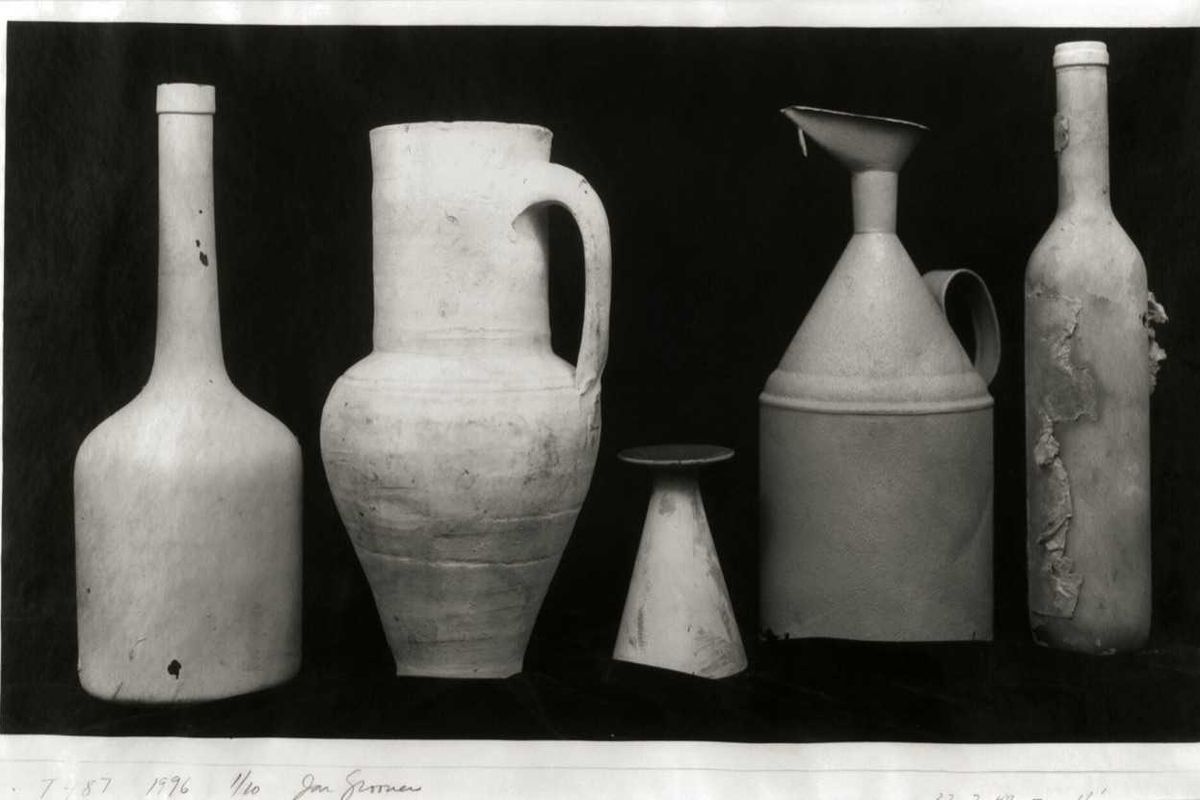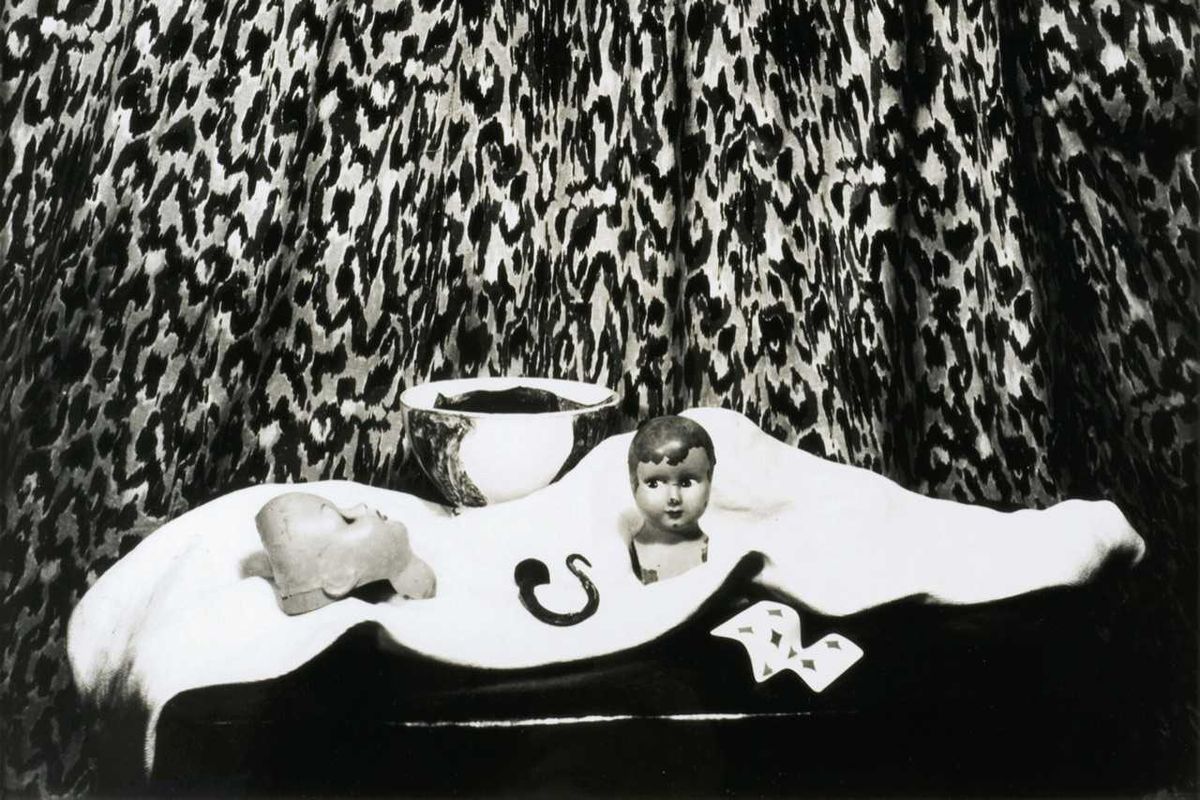Tra i simboli, la spada e il gioiello parte la sfida del nuovo Giappone

In Giappone, un dio ha rassegnato le dimissioni. Il 30 aprile, Akihito, l'ottantacinquenne Tennō heika, «sua maestà l'Imperatore», ha lasciato il trono dopo 30 anni di regno, dichiarando di non sentirsi più in grado di adempiere ai propri doveri a causa dell'età avanzata. È il primo sovrano ad abdicare da oltre 200 anni. Oggi gli è succeduto il figlio Naruhito, 59 anni. Ma il passaggio di potere ufficiale avrà luogo durante la cerimonia d'incoronazione, il 22 ottobre, quando verranno consegnati al nuovo Tennō la Spada e il Gioiello, due delle insegne regie che la tradizione shintoista vuole affidate al clan di Yamato dalla dea del sole Amaterasu Ōmikami, progenitrice della dinastia imperiale. Nei numerosissimi riti di successione (per l'ascesa al trono di Akihito nel 1990 furono ben 89), tutto ha il sapore del sacro e dell'antico. Ma cosa rappresenta l'Imperatore per i giapponesi di oggi?
Per i fedeli shintoisti, i militanti di destra e gli esotisti occidentali, è un akitsukami, un «dio che si manifesta in terra», l'anima stessa del Giappone. E in parte è vero. Secondo il culto shintoista, Amaterasu ha conferito l'autorità sull'Arcipelago al clan di Yamato, sua progenie in terra, nel 660 a.C., data che la renderebbe la dinastia più antica al mondo. Il potere del sovrano è legittimo perché deriva da legami di sangue ininterrotti con la divinità, che lo rendono l'unico a poter comunicare direttamente con essa. Non a caso, il 18 aprile Akihito si è presentato al santuario di Ise, il sacrario principale dello shintoismo, per comunicare le proprie dimissioni direttamente alla dea.
Una centralità che si riflette anche sul tempo. In Giappone, infatti, la scansione degli anni non viene misurata a partire dalla nascita di Cristo, ma in base all'inizio del regno del sovrano. Se fino al 30 aprile eravamo nel 31° anno Heisei («pace realizzata», nome ufficiale di Akihito in veste d'Imperatore), dal giorno successivo siamo entrati nel primo anno Reiwa («meravigliosa armonia», nome assunto da Naruhito). Per i giapponesi non si tratta di un semplice avvicendamento sul trono, ma della fine di un'era: la prima della storia moderna in cui il Paese non sia mai entrato in guerra, ma anche un periodo flagellato dalla crisi economica, dal rapido invecchiamento demografico e da terribili disastri naturali (tra cui lo tsunami che l'11 marzo 2011 provocò 16.000 morti e l'esplosione alla centrale nucleare di Fukushima).
Per i sacerdoti dell'accademismo pastorizzato e gli alfieri dell'intellighenzia conformista, invece, il Tennō non sarebbe altro che una figura anacronistica, il residuo di un passato feudale e retrivo che ha condotto il Paese agli orrori della Seconda guerra mondiale. E anche questo in parte è vero. Nella storia giapponese, l'Imperatore ebbe un potere politico effettivo solo fino all'XI secolo. Successivamente, fu ridotto a una sorta di taumaturgo di Stato mantenuto dai vari shōgun, i signori della guerra, per legittimarne il governo. Lo scenario cambiò radicalmente nel 1868: per far fronte alla decadenza del potere shogunale e alla pressione navale degli Stati Uniti, che minacciavano di ridurre il Paese a una colonia, il Tennō Meiji venne riportato sul trono. Fu una rivoluzione militare e culturale: lo shintoismo divenne religione di Stato; Amaterasu, sullo stampo dei monoteismi occidentali, assurse al rango di divinità suprema; il Tennō fu ossessivamente esaltato come figlio degli dei e padre del popolo. Il mito delle origini divine dei giapponesi servì a costruire la retorica dell'identità nazionale, ma fu una manipolazione necessaria per permettere alla popolazione di reggere gli enormi sacrifici richiesti da una modernizzazione forzata e accelerata. Fu un'arma a doppio taglio: ciò che permise alla società nipponica di non disintegrarsi, fu ciò che la spinse al delirante sogno della conquista dell'Asia e ai ripugnanti massacri della guerra del Pacifico. Non a caso, dopo la disfatta del 1945, la Costituzione imposta dagli americani negò formalmente la natura divina del Tennō e i suoi poteri temporali, relegandolo al ruolo quasi unicamente onorifico di «simbolo dello Stato».
Entrambe queste immagini del Tennō sono vere, ma parziali. Un paradosso? Non se si considera che in giapponese il termine makoto significa a un tempo «verità» e «fedeltà»: la sola cosa che può dimostrare la veridicità di un'idea è la costanza con cui la si persegue, fino ai limiti estremi, là dove i mezzi giustificano il fine. La figura del Tennō come padre del popolo fu senza dubbio una forzatura, ma per sostenerla rischiarono la vita alcune delle personalità più straordinarie della storia dell'Arcipelago. Questa retorica fu l'ancora di un popolo allo sbando tra i marosi dei grandi mutamenti della Storia.
Negli anni della modernizzazione forzata, un intellettuale scrisse nel suo diario: “So che cosa eravamo, lo so bene, ma non so più che cosa siamo e quale futuro ci possiamo aspettare". Oggi, nel Giappone dei robot avveniristici, dei treni ultraveloci e degli alberghi a capsule, nel Giappone ultramaterialista, relativista, ipertecnologico, sonnolento e cinico della contemporaneità, si avverte lo stesso rischio di una perdita irrimediabile d'identità e di senso. E proprio per questo, dopo le dimissioni del figlio del Cielo, un nuovo e identico dio ha ripreso il suo posto sul trono. Perché tra gli astri che turbinano in una notte senza fine, c'è sempre bisogno di una stella polare.