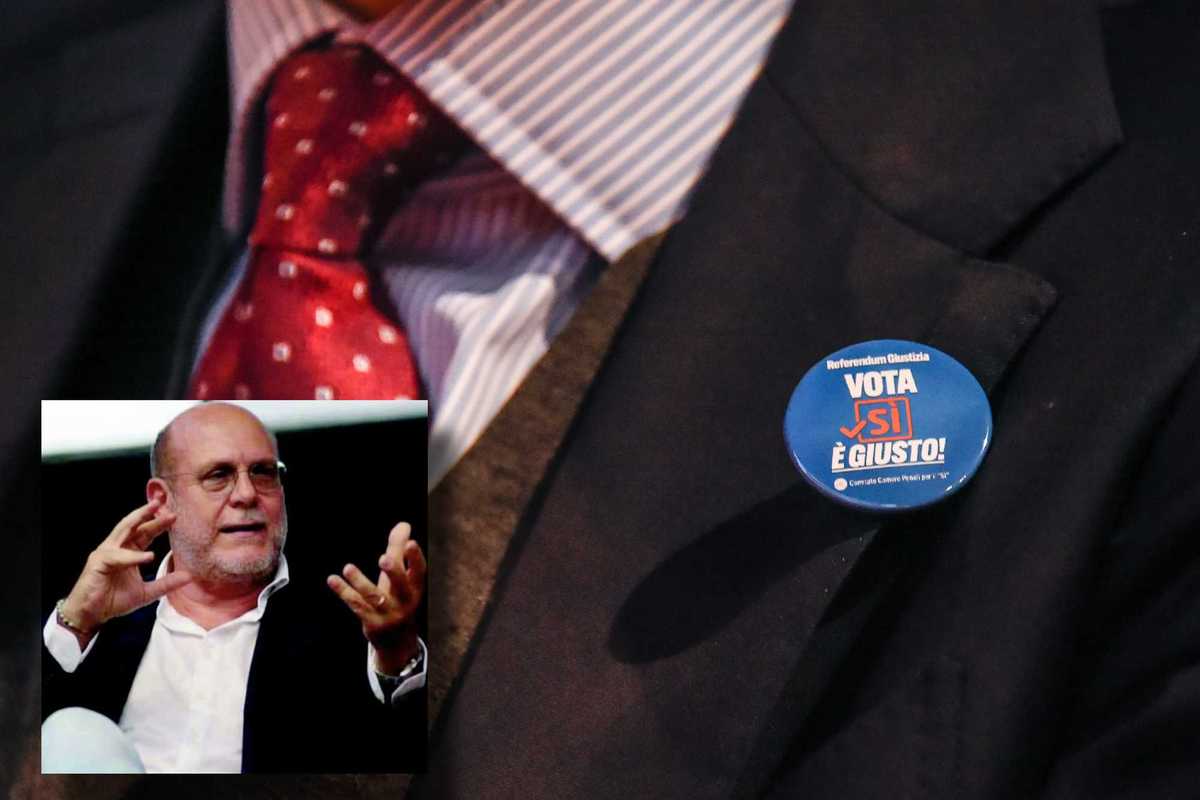Altro che tempi certi per i processi. Così nasce la lotteria delle sentenze

La riformetta della giustizia, che si è guardata bene dal toccare le criticità emerse dal Sistema scoperto grazie all'intercettazione delle chat dell'ex stratega delle nomine Luca Palamara, propaganda una riduzione del 25 per cento dei tempi del processo penale. E per farlo vuole introdurre il concetto di improcedibilità. Una sorta di ghigliottina temporale che interverrebbe in questo modo: due anni per concludere il giudizio d'appello e uno per quello di Cassazione.
I termini sono prorogabili rispettivamente di un anno e di sei mesi per reati gravi o processi complessi.
Sono esclusi i reati imprescrittibili, ovvero quelli puniti con l'ergastolo. Ma ora il rischio è che si crei una sorta di regionalismo giudiziario, con annessa lotteria delle sentenze. Perché ogni distretto di Corte d'appello ha i suoi tempi. Dettati dalle carenze di personale, dai metodi di organizzazione, dai carichi di lavoro, dal numero di procedimenti pendenti. Tutti fattori che concorrono a diluire o rendere più stretti i tempi della giustizia. Che, stando agli ultimi dati (del 2019) diffusi dal ministero della Giustizia, renderebbero differenti le sorti degli imputati d'appello e in Cassazione a seconda della corte che andrà a trattare il procedimento. A Napoli, per esempio, ci vogliono in media 1.495 giorni per un processo d'appello. Quasi il doppio di quelli previsti dalla riforma di Marta Cartabia. E anche a Roma i numeri sono da record negativo: 1.128 giorni. Pure Venezia non scherza, con i suoi 1.017 giorni. Seguite da Reggio Calabria (1.013) e Bari (1.002). Per avvicinarsi ai numeri previsti dalla riforma bisogna arrivare alla Corte d'appello di Potenza: 767 giorni in media. Poco al disopra dei due anni previsti dalla ghigliottina che vorrebbe azionare Cartabia.
La Corte d'appello più volece è Salerno, con 242 giorni, che abbatte il record negativo dei tempi del primo grado: 635 giorni. Seguita da Messina: 247 e Campobasso 283. Milano è al quarto posto con 315 giorni. Tempi medi che al momento restano più o meno, tranne poche eccezioni, entro i limiti di «ragionevole durata», ovvero la soglia che, se superata, dà diritto a un indennizzo, come previsto dalla legge Pinto, che ha stabilito la durata massima di un processo, Cassazione compresa, in sei anni. In totale, comunque, da quando partono le indagini a quando il procedimento viene definito in Cassazione, le stime più recenti oscillano tra 1.500 e 2.500, una media molto più alta di Francia, Spagna, Germania. E anche il dato dei procedimenti finiti in prescrizione non deve essere stato preso adeguatamente in considerazione: in alcune Corti di Appello come Roma, Reggio Calabria e Venezia, quasi un procedimento penale su due, tra quelli definiti nel corso del 2020, si è prescritto. Napoli è al 39,1 per cento di procedimenti prescritti in appello. La forbice è larga. Se si pensa che a Trento solo l'1,6 per cento dei procedimenti si prescrive. E anche Messina e Caltanissetta detengono un buon 3,3. Seguite da Trieste con il 3,7. Insomma, la differenza nella trattazione di un procedimento penale tra le varie Corti d'appello è notevole. E l'improcedibilità rischia di far pesare ancor più il piatto della bilancia tra chi, per lo stesso reato, dovrà affrontare un processo a Roma, dove facilmente finirà nel calderone degli improcedibili, e chi, invece, verrà giudicato col turbo, come a Salerno o a Messina. Le prime reazioni sono state durissime. Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, ha dichiarato: «Con l'improcedibilità prevista dalla riforma Cartabia il 50 per cento dei processi, considerata la gran mole dei reati di mafia e maxi processo che celebriamo, saranno dichiarati improcedibili in appello». Una valutazione simile a quella che ha fatto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho: «Immaginare che tanti processi vengano dichiarati improcedibili mina la sicurezza del paese». Il Csm ha espresso un parere fortemente negativo, parlando addirittura di «possibile contrasto con l'attuale assetto dei rapporti tra i poteri dello Stato». Per Gian Carlo Caselli, «se l'appello non si conclude entro due anni, tutto il processo va in fumo, un po' come avveniva con la prescrizione, che però adesso si chiama improcedibilità». Anche l'Associazione nazionale magistrati l'ha liquidata come una «normativa» che «non ha alcuna funzione acceleratoria», che, anzi, «azzererebbe non pochi processi», non tendo «in considerazione approfondita la realtà di tutti gli uffici».
Questo, secondo l'Anm, produrrebbe «un costo sociale molto alto» e con un «forte sacrificio dei diritti delle vittime».
Ma il cortocircuito federalista non è l'unico aspetto che appare strambo. La riformetta prevede che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una «ragionevole previsione di condanna». Ma, di fatto, sono già centinaia di migliaia i procedimenti penali che si chiudono dopo le indagini preliminari, senza arrivare a giudizio. Le archiviazioni rappresentano infatti oltre il 60 per cento. E nel periodo Covid i numeri sono anche cresciuti. Nel 2020, su 600.000 procedimenti definiti, 390.000 sono finiti in archivio, superando quota 65 per cento.
E se per l'improcedibilità Cartabia stima un abbattimento dei tempi del 25 per cento, nessuna previsione viene fatta sull'assenza di una «ragionevole previsione di condanna» per mandare a giudizio un indagato.