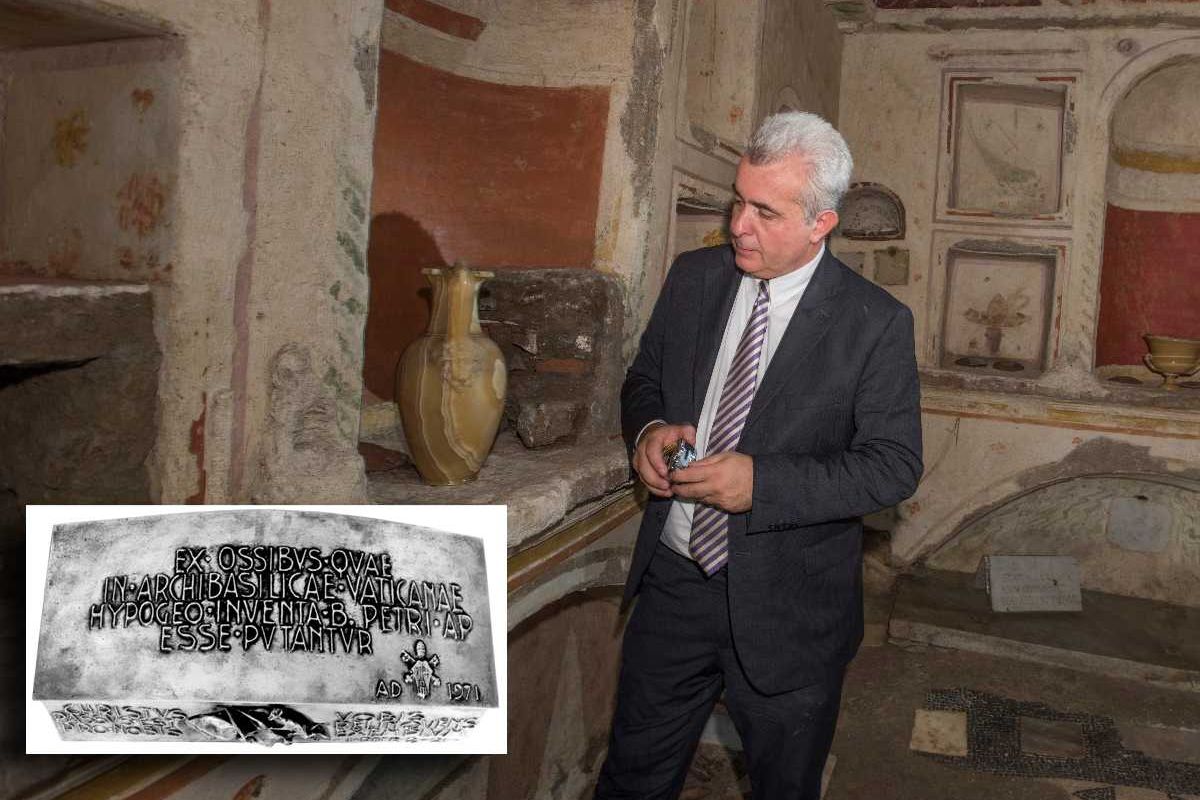Bruxelles fa il gioco delle tre carte: ci dà 130 miliardi e se ne prende di più

- È la quota del bilancio che spetterebbe all’Italia per coesione, immigrazione, difesa e competitività. Ma se consideriamo le tasse su imprese, tabacco e green anche nei prossimi anni saremo in passivo.
- Dopo l’indagine dell’Antitrust, Msc, il colosso mondiale del trasporto marittimo, ha abbandonato il salvataggio della compagnia in crisi. Che ora non vede vie d’uscita.
Lo speciale contiene due articoli
È la domanda che un po’ tutti si stanno ponendo da quando la Commissione Ue ha annunciato il nuovo bilancio europeo, quello che andrà a valere per il prossimo settennato (2028-2034) e che si porta dietro poche certezze: la cifra monstre, circa 2.000 miliardi di risorse da allocare, e il fatto che questo «Quadro finanziario pluriennale» non piaccia a nessuno. O forse piace solo a chi l’ha ideato.
Il quesito è scontato: come sarà ripartita la ricca torta tra i singoli Stati e sopratutto, nel conto del «dare avere» saranno i soliti noti a rimetterci? Premessa: fare i conti è complicato perché mancano ancora i dettagli e viste le proteste di questi giorni (nettissima l’opposizione tedesca) è praticamente impossibile che il bilancio esca indenne dalle acerrime discussioni dei prossimi mesi. Insomma, se dovessimo scommettere oggi, vinceremmo facile puntando qualche euro sulla possibilità che ci siano cambiamenti sostanziali alla manovra di bilancio dell’Ue. Eppure ieri sono usciti i primi numeri.
Che in prospettiva ci dicono molto. Secondo quanto rilanciato dalla testata Public Policy Europe, nel periodo 2028-2034 l’Italia riceverà 86,6 miliardi di euro. Di questi, 78,3 miliardi saranno destinati a una allocazione generale, 2,9 miliardi andranno alla gestione della migrazione, alla sicurezza e agli affari interni e 5,4 miliardi di euro rimpingueranno il fondo sociale per il clima.
«Non si tratta», spiega alla Verità il membro della Commissione bilancio del Parlamento Ue per il gruppo Ecr, Ruggero Razza, «della ripartizione di tutte le risorse del bilancio, ma solo di quelle che fanno riferimento al maxi-fondo da 865 miliardi per i Piani di partenariato nazionale e regionale. A questa liquidità va aggiunta quella prevista per la competitività, che ammonta a 451 miliardi di euro. Insomma se dovessimo fare una proporzione, complessivamente ci spetterebbero non meno di 130 miliardi di euro».
Il punto è quanti miliardi l’Italia verserà nello stesso arco temporale. «La premessa è che stiamo parlando di stime», continua Razza, «ma se restiamo agli ultimi anni vediamo che il nostro contributo alla causa europea è in media di circa 17 miliardi all’anno. Quindi saremmo intorno ai 120 miliardi nel periodo. Il problema è che a questi fondi bisogna aggiungere quelli derivanti dal sistema di tassazione che, se resta questo l’impianto, colpirà soprattutto imprese, tabacco e chi proverà a discostarsi dall’ideologia green. Venendo al punto, sui 58 miliardi di nuovi introiti da imposte, il 5-10% sarà a carico dell’Italia. Questo vuol dire che in 7 anni dobbiamo considerare al massimo 35-40 miliardi di risorse che usciranno dal nostro sistema Paese per “ingrassare” il grande calderone comunitario». Insomma, l’Italia sarebbe ancora una volta in passivo. I numeri sono importanti, ci mancherebbe, ma qui emerge un sistema che non sta in piedi. «È di tutta evidenzia», continua Razza, «che colpendo le imprese sopra i 100 milioni di fatturato si va a mettere un balzello su tutto il sistema economico anche quello delle piccole e medie realtà che contraddistinguono la nostra economia».
Ma gli altri come sono messi? Secondo i numeri emersi, alla Francia dovrebbero andare 90,1 miliardi (81,8 miliardi di allocazione generale, 2,7 miliardi per la gestione della migrazione e 5,6 miliardi per il clima), alla Spagna 88,1 miliardi e alla Germania 68,4 miliardi.
Primeggia la Polonia (123,3 miliardi, di cui 112,6 miliardi di allocazione generale, 1,9 miliardi per migrazioni e sicurezza e ben 8,8 miliardi destinati al Fondo sociale per il clima). Tant’è che diversi commentatori hanno notato una coincidenza con la nazionalità del commissario competente, il polacco Piotr Serafin , responsabile del bilancio comunitario.
Numeri che potrebbero però subire dei bruschi cambiamenti. E bastava leggere le dichiarazioni rilasciate anche ieri da alcuni dei principali leader dell’Unione per capirlo. «Nessun Paese membro dell’Ue», ha spiegato la ministra degli Affari europei della Danimarca, Marie Bjerre, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Affari generali a Bruxelles, «è pronto ad accettare il piano di oggi. Avremo una lunga discussione e ovviamente ci sono opinioni diverse su come strutturare il bilancio. Sarà difficile, ma l’Europa ha bisogno di un bilancio».
Mentre la Germania punta il dito contro il contributo richiesto alle aziende. «Così facendo», ha evidenziato Gunther Krichbaum, il ministro incaricato per gli Affari europei, «non promuoveremo la competitività internazionale, ma piuttosto la mineremo. Ci sono aziende come Volkswagen, che potrebbero dover riconsiderare la possibilità di mantenere le loro attività in Europa. Potrebbero delocalizzare. Quindi dobbiamo essere chiari sul fatto che sarebbe come darci la zappa sui piedi». Per una volta non si può non essere d’accordo con Berlino.
L’Ue affonda Moby: 7.000 a rischio
La speranza di un rilancio per Moby si spegne bruscamente. Il gruppo Msc, colosso mondiale del trasporto marittimo guidato dalla famiglia Aponte, ha annunciato la rinuncia formale all’acquisizione della compagnia di navigazione italiana. Un colpo durissimo per l’armatore Vincenzo Onorato e per i circa 5.000 dipendenti diretti della compagnia, che ora vedono sfumare l’unico vero piano di salvataggio in campo. Una crisi che rischia di travolgere non solo l’azienda, ma anche l’intero ecosistema che le gravita intorno: fornitori, porti, logistica e turismo.
Msc, che deteneva già il 49% di Moby, ha deciso di retrocedere la propria partecipazione all’azionista di maggioranza, ovvero Onorato Armatori, rinunciando anche al diritto di pegno sul restante 51% del capitale. Non solo: entro fine anno, la compagnia svizzera venderà le proprie quote e uscirà definitivamente dal capitale della storica compagnia, segnando così il naufragio dell’operazione di salvataggio avviata nel 2023.
Contestualmente, Moby sarà chiamata a restituire quanto rimasto del finanziamento da 243 milioni di euro che Msc aveva concesso lo scorso dicembre per chiudere positivamente il concordato preventivo con i creditori. Un’operazione che aveva rappresentato, fino a pochi mesi fa, l’unico spiraglio per il rilancio di una compagnia strangolata dai debiti. La decisione di Msc è strettamente legata all’istruttoria aperta lo scorso novembre dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha sollevato il sospetto di possibili violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Al centro dell’indagine, il rischio di posizioni dominanti sulle rotte di traghetti nel Mediterraneo, in particolare verso la Sardegna, a seguito dell’integrazione operativa tra Moby e Gnv, altra compagnia controllata da Msc.
Secondo l’Antitrust, la concentrazione avrebbe potuto limitare la concorrenza su tratte strategiche, con ripercussioni sui prezzi e sulla qualità del servizio. Di conseguenza, Msc ha preferito defilarsi per evitare un possibile esito sanzionatorio, pur dichiarando di non aver mai violato le regole del mercato. Il ritiro di Msc lascia Moby senza un partner industriale e senza le risorse necessarie per affrontare il futuro. I sindacati parlano già di un’emergenza occupazionale, con almeno 5.000 lavoratori diretti a rischio - tra personale di bordo, tecnici, amministrativi e addetti alle prenotazioni - oltre a circa 2.000 lavoratori indiretti che operano negli scali, nella logistica e nei servizi collegati. Senza un nuovo piano industriale e senza l’intervento di investitori pubblici o privati, la compagnia rischia il collasso. E con essa, viene messa a rischio la continuità territoriale tra l’Italia continentale e le isole, in particolare Sardegna, Elba e Corsica. La vicenda Moby riaccende anche un dibattito più ampio: quello sulle rigide regole europee in materia di concorrenza e sui loro effetti pratici nei settori strategici. In altri contesti internazionali, come Stati Uniti e Cina, le fusioni tra grandi operatori vengono talvolta incentivate per consolidare la competitività del settore, soprattutto in momenti di crisi.
Nel caso italiano, invece, la rigorosa applicazione delle normative Ue rischia di impedire operazioni che potrebbero rappresentare un’occasione di salvataggio. Msc, leader mondiale del cargo con oltre 900 navi, avrebbe potuto portare in dote non solo liquidità, ma anche tecnologia, competenze, una rete commerciale globale e - soprattutto - l’ammodernamento di una flotta ormai vetusta.
Il tentativo di Onorato di rilanciare la compagnia si è scontrato con una realtà economica durissima. L’accordo con Msc era stato presentato come l’unica via percorribile per evitare il fallimento. La buona notizia è che l’Autorità Garante ha sottolineato che l’istruttoria non è ancora conclusa e che sono previste ulteriori consultazioni con gli operatori del settore. Tuttavia, le possibilità che l’operazione venga riaperta sembrano ridotte al minimo, anche perché Msc ha già annunciato pubblicamente la propria uscita.