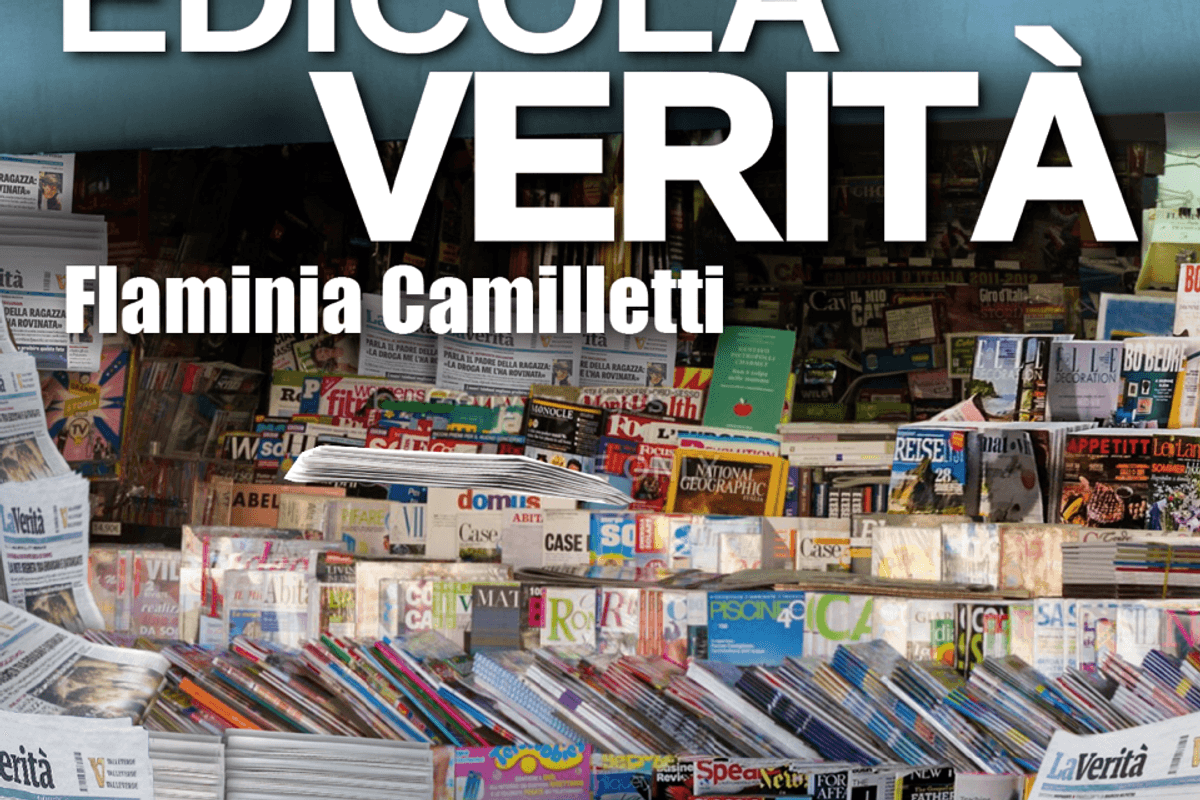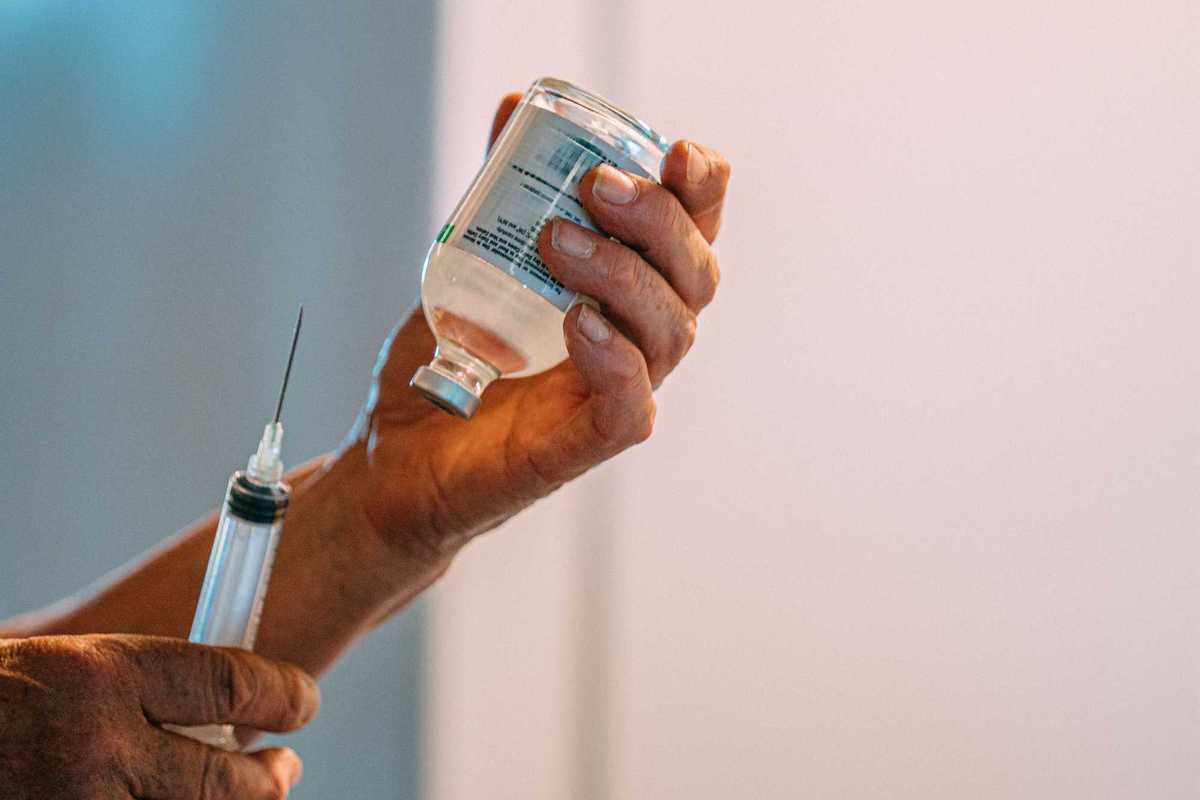Eminenza, cos'è la libertà? Oggi, la parola è spesso associata all'idea della completa autonomia da tutto e tutti. È questa la libertà?
«Quella così concepita è la falsa libertà. Prima però vorrei mettere in chiaro un dato fondamentale: il cristianesimo non è nemico della libertà. Anzi, non è eccessivo dire che il cristianesimo è la religione della libertà, come è la religione dell'amore. Per il cristianesimo non solo Dio ma anche l'uomo è libero. Poi certo, per lunghi secoli, la Chiesa - pur continuando ad affermare che la fede è un atto libero - non ha rispettato abbastanza la libertà di chi non credeva, o credeva diversamente. Noi siamo creature, esseri limitati e radicalmente non autosufficienti. Così è anche la nostra libertà: imperfetta, sottoposta a molteplici condizionamenti, che proprio la psicologia e la sociologia moderne e contemporanee non si stancano di mettere in luce, a volte esagerando. È normale e doveroso, dunque, che a nostra volta, nell'esercitare la nostra libertà teniamo conto degli altri, della loro libertà ma non solo di essa: della loro vita, del loro bene, dei loro bisogni e interessi. Non posso soffermarmi sui diversi casi concreti di presunti diritti. Mi limito al primo, l'aborto, che è il più grave e il più frequente e a cui si può anzitutto rispondere che si tratta dell'uccisione di un altro essere umano, per di più innocente. Alla base di questi pretesi diritti sta il relativismo, per il quale il bene e il male, il vero e il falso dipendono solo dalle nostre scelte e quindi ogni desiderio diventa un diritto. Così la nostra libertà viene distaccata dalla verità e dall'etica, in ultima analisi dalla realtà, e finisce per autodistruggersi. L'illusione di questa falsa libertà conduce facilmente al conformismo».
Cattolici e potere. Oggi è innegabile un impegno di molte associazioni di chiaro orientamento cattolico nel volontariato e nel Terzo settore. Non è così in politica: esistono cattolici, ma spesso questa loro appartenenza non è dirimente. Dove sta il problema?
«Direi anzitutto che oggi in Italia il peso dei cattolici in politica è ridotto al minimo. Il problema sta nella debolezza del rapporto tra fede e cultura. Per questo rapporto rimangono fondamentali le parole pronunciate da Giovanni Paolo II nel 1982: “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta". Oggi invece, non solo in Italia, assistiamo proprio a una diaspora culturale e politica, per la quale molti politici cattolici si sentono liberi di prendere posizioni opposte, condivise da tanti altri cattolici loro elettori o comunque convinti che la propria fede personale non abbia determinate implicazioni culturali e politiche. Come uscirne? C'è senz'altro bisogno di quel lavoro educativo a cui accennavo. È inoltre di grande aiuto la testimonianza di quei politici, cattolici ma anche non espressamente tali, che non temono di andare contro corrente sulle questioni eticamente più rilevanti. Oggi in politica, piaccia o non piaccia, contano soprattutto i leader: sarebbe quindi assai auspicabile che emergesse qualche leader di questo genere».
Dei “capi" però possono manifestarsi solo se esiste un ambito, un humus, una comunità nella quale tali leader possano crescere.
«In parte è come dice lei, in parte è qualcosa di personale... il leader non si sceglie, ha una sua forza naturale. Tuttavia è certamente importante, perché il leader sia di un certo tipo, il contesto educativo in cui si è formato. Ad esempio, i leader della Democrazia cristiana si erano tutti formati in ambiente cristiano. Pensiamo ad Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti, Guido Gonella, Attilio Piccioni, tutta gente che aveva una formazione di un certo tipo».
Oggi, però, le condizioni sono assai diverse rispetto a quella situazione. Quando nel 2007 ci fu il primo Family day ci furono un'indicazione chiara da parte dell'autorità ecclesiastica e una mossa decisa da parte del laicato cattolico. Rispetto alla Chiesa, che consiglio darebbe per mettere insieme un mondo cattolico che è molto frastagliato?
«Ho lavorato molti anni a quello che si chiamava il “Progetto culturale". Poi si è spento perché la Cei non se ne è più interessata, sebbene ci fossero vescovi e laici in esso molto impegnati, ma senza il supporto vero della Conferenza episcopale il Progetto si è afflosciato. E questo, secondo me, è stato un danno molto grave. Si tratta sempre di mettere in rapporto fede e cultura, attraverso un lavoro educativo e formativo e coinvolgendo tutte le forze vive che ci sono. Io credo che l'idea di separare la Chiesa ufficiale, da una parte, e il laicato, dall'altra, sia un errore fondamentale che priva il laicato del suo retroterra di cui ha assoluto bisogno, ma priva anche l'autorità ecclesiastica di quell'incidenza concreta che deve proporsi».
Oggi è arduo sostenere pubblicamente posizioni considerate «vecchie» o «intolleranti». Quindi, c'è anche un problema di coraggio e di tenacia? Come si riacquistano? In cosa possiamo riporre la nostra speranza?
«Speriamo innanzitutto in nostro Signore. Se si ha coraggio si fanno cose che sembrerebbero impossibili, questo è sicuro. Quando si accettò la sfida sul referendum sulla legge 40, quella sulla procreazione assistita dissi: “Guardate che noi non abbiamo paura". Molti pensarono che fossi un po' matto, ma io, in realtà, sapevo che ci sarebbe stata una fetta di popolazione che si sarebbe astenuta, così come era avvenuto nella precedente consultazione sull'articolo 18. In quell'occasione a me fu richiesto molto coraggio, anche se ero certo che sarebbe finita bene. Dissi agli scettici: proviamo una volta tanto a giocarci la sfida puntando su un'astensione consapevole e questo, poi, piacque moltissimo tanto che raccogliemmo adesioni immediate e poi, pian piano, anche fra coloro che volevano votare No. Quindi c'è un elemento di rischio che bisogna affrontare perché nelle vicende umane non si sa mai come andrà a finire. È come nell'educazione: quando ci si espone con libertà c'è sempre un rischio, un “rischio educativo", un pericolo di insuccesso - don Luigi Giussani ha spiegato molto bene queste cose. Ma bisogna rischiare, non si può non dare mai libertà per paura di rischiare».
A proposito del referendum sulla legge 40, in quel periodo ci fu la risposta di un certo mondo laico alle preoccupazioni sollevate dai cattolici. Rispetto a questo mondo che atteggiamento dobbiamo avere noi cattolici? Su quali punti possiamo convergere?
«Un atteggiamento molto positivo, perché non è vero che certi princìpi possono essere solo dei cattolici. Non è vero, hanno una loro razionalità e positività intrinseca che convince molte persone credenti o non, praticanti o non. Questo lo ha sottolineato più volte papa Benedetto negli scritti che ha pubblicato poco prima di salire al soglio pontificio in cui diceva che era fondamentale questa apertura, questo non costruire barriere tra laici e cattolici. Naturalmente, questo si può fare a partire da fatti concreti ed è su questi che va portata l'attenzione, non sulla discriminante “io sono cattolico e tu no". Questo è un po' un limite che hanno a volte certi gruppi cattolici, ma che va superato cercando di concentrarci sulla sostanza delle cose. È per questo che io dico: l'unità politica dei cattolici oggi è impossibile, però il mettere in luce dei contenuti su cui ci sia una larga convergenza, questo è possibile e questa era l'anima del Progetto culturale e del discorso che fece Giovanni Paolo II a Palermo».
Ricomincia la scuola. In particolare gli istituti paritari, in questi ultimi anni, sono in difficoltà. Ad aggravare una situazione già complicata è arrivato il coronavirus. Perché, secondo lei, le paritarie meritano di esistere ancora? Cosa dovrebbe fare lo Stato nei loro confronti?
«Purtroppo questa è una questione italiana: altri Paesi, certamente meno legati alla Chiesa rispetto all'Italia, hanno una piena libertà scolastica e, addirittura, si meravigliano che noi non l'abbiamo. Questo è un residuo della cultura risorgimentale che si trascina ancora oggi, ma che non ha nessuna ragione intrinseca. Perché un insegnante dovrebbe essere libero ma solo dentro la scuola dello Stato? Se viviamo in un Paese liberale e democratico che assicura non solo il voto a tutti ma anche la libertà, allora bisogna riconoscere che una delle libertà fondamentali è quella di insegnare. E questa si può concretizzare in istituti dediti all'insegnamento come sono le scuole e le università. Per quanto riguarda il resto, occorre che la scuola cattolica sia davvero tale non solo nello stile, ma anche nei contenuti che propone. Quando si spiega la filosofia, la letteratura, le scienze è importantissimo che nella scuola cattolica si esprima una posizione che ha certe radici e giunge a certe conclusioni. Altrimenti è una scuola cattolica di nome, ma non di fatto».