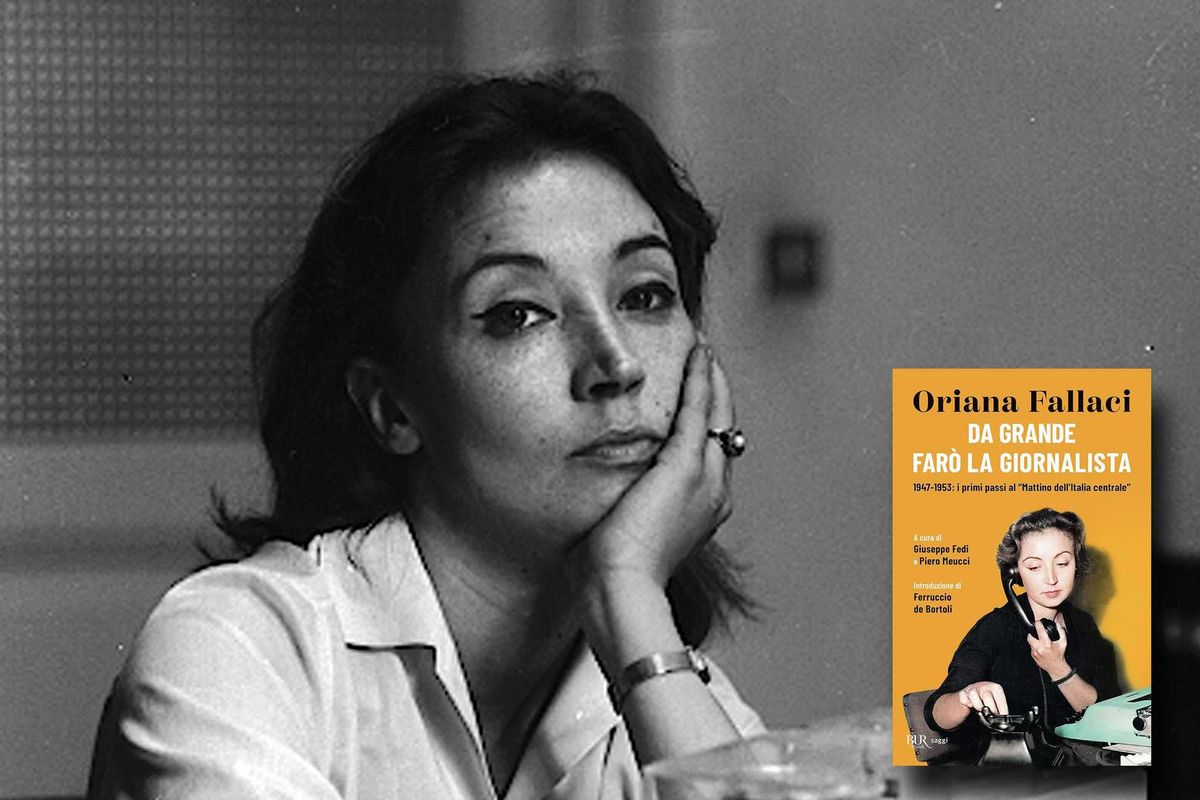Il rischio della società tecnocratica: ci lascia soltanto «liberi di obbedire»

Nell’ultimo secolo il governo e il management, nelle tragedie e nei progressi, sono stati due tra i principali motori della storia umana. Il governo si è mostrato in tutta la sua forza e violenza in verticale, soprattutto tra le due guerre mondiali, ma si e anche saputo sviluppare in orizzontale, con una moltiplicazione di istituzioni pubbliche necessarie per evolvere in parallelo alla società e al capitalismo, e orientarsi su plurimi livelli di governo, dal locale all’internazionale. […]
Il rapporto tra governo e management è stato ciclico: tra le due guerre mondiali la dottrina manageriale è stata uno strumento della politica, attraverso la quale quest’ultima cercava di neutralizzare il conflitto politico e sociale; nei primi trent’anni del dopoguerra invece il management e i manager hanno assunto una connotazione più politica, cercando di influenzare un processo decisionale pubblico dominato dai partiti e dai parlamenti per allinearlo con i propri interessi e obiettivi, provando a trasformare tutte le organizzazioni economiche, pubbliche e private, in attori politici; infine, nell’ultima parte del Ventesimo secolo, è stata ancora la politica, in una ottica di liberalizzazione e internazionalizzazione dell’economia, che derivava anche dalla pressione delle élite economiche e finanziarie, a utilizzare le tecniche manageriali per modernizzare e aziendalizzare la pubblica amministrazione; mentre oggi emergono nuove esigenze quale il ritorno dello Stato sotto molteplici forme dentro un paradigma di sicurezza nazionale che condiziona tanto il pubblico quanto il privato e si richiede ai manager una interdisciplinarietà e una preparazione strategica in grado di fronteggiare volatilità, incertezza, complessità e ambiguità degli eventi che caratterizzano un ordine globale interconnesso, interdipendente e in transizione dove «pensare per sistemi», attraverso elaborazione di scenari e analisi dei rischi, non è soltanto opportuno per assumere le migliori decisioni ma è spesso essenziale per la sopravvivenza delle organizzazioni aziendali e amministrative. […]
Non si deve dimenticare che tanto il management quanto il governo soddisfano due appetiti insaziabili della modernità, il profitto e il potere, ma questi due principi alla base della razionalità strumentale possono assumere l’aspetto di un’arma a doppio taglio: da un lato spingono lo sviluppo umano e il miglioramento delle condizioni di vita, dall’altro però moltiplicano all’infinito le possibilità di dominio dell’uomo sull’uomo. Per questo l’esercizio di queste due arti diviene pericoloso quando viene esercitato senza alcun ancoraggio a qualche canone di virtù o di moralità. Dunque, proprio a causa della ambivalenza che si è messa in evidenza il rapporto tra governo e management merita di essere indagato a fondo, di essere compreso nelle sue sfaccettature al fine di cercare un equilibrio tra rischi e opportunità, danni e benefici. Così come certe forme di management possono trasformarsi più che in ideologie in mere tendenze del momento, in mode globali la cui giustapposizione su forme, valori, culture e tradizioni di una peculiare comunità può generare più fallimenti che sviluppo. Anche qui, alla base, c’è forse la distorta visione di un uomo indifferenziato, di gruppi umani omogenei ed equivalenti, di un’uguaglianza che può essere standardizzata e proceduralizzata, di soluzioni tecniche che possono trascendere tutte le increspature modellate dal passato, dai luoghi e dalle culture. Se c’è qualcosa di minacciato dalle pieghe distorte del rapporto tra governo e management quello e l’individuo o, meglio, la persona in tutta le sue articolazioni singole e sociali.
Tuttavia, la storia mostra che l’individuo non può essere estirpato né dalla storia del capitalismo né da quella politica. Un capitalismo vivace e funzionante necessita di intuizioni, invenzioni, ricerche che soltanto un individuo, o un piccolo gruppo di individui, può imprimere. E questa vivacità mal si attaglia a una società di management totale, dove si è soltanto «liberi di obbedire» e poco di creare. Al tempo stesso, una società politica libera e forte si fonda sulla qualità degli individui, sulla capacità della classe governante e dei leader politici, ma soprattutto su istituzioni civili e politiche in grado di promuovere al meglio lo sviluppo dell’individuo, in definitiva di valorizzare la capacità e le responsabilità della persona. Poiché senza questi elementi fondamentali diventa impossibile la realizzazione di una società giusta, prospera e pacifica, la nascita, la crescita e il ricambio di élite capaci, la mobilità sociale e l’innovazione, la fiducia diffusa, la cooperazione da cui scaturisce l’ordine sociale, la legittimazione dell’autorità che è tanto necessaria nell’economia quanto nella politica, diventano le pietre angolari di un rapporto virtuoso tra pubblico e privato. Se il mondo di oggi è complesso, interdipendente, connesso, sempre alla ricerca di cambiamenti ma si ridefinisce intorno a nuove domande di sicurezza e protezione allora le organizzazioni, pubbliche e private, si troveranno sempre sull’orlo del caos ma non dovranno cadere nel disordine.
Non c’è dubbio che il Minotauro nell’ultimo secolo abbia generato una nuova aristocrazia, fondata sulla competenza e sul merito scolastico invece che sul diritto di sangue. Esso ha rappresentato la scossa ingovernabile della società primo novecentesca e la formula politica di successo delle classi governanti del dopoguerra. Tuttavia, in questo nuovo secolo quell’equilibrio raggiunto tra governo e management nel tardo Ventesimo secolo sembra essersi incrinato. Ciò forse anche perché negli ultimi trent’anni le scuole e le università si sono concentrate soltanto sulla competenza tecnica emarginando il sapere umanistico che aveva formato gli statisti, gli imprenditori e i manager di successo della generazione precedente. Di conseguenza oggi si produce una élite di tecnocrati e attivisti, spesso disancorata dalla nazione e dalla ragion di Stato, informata dal cosmopolitismo globale e incapace di autodisciplinarsi, di attribuirsi dei doveri, di imporsi delle responsabilità come era avvenuto per i leader di ogni settore del secondo dopoguerra. Sembra persa, in definitiva, quella mescolanza vincente tra virtù aristocratiche e ambizioni meritocratiche, poiché sono rimaste in vita soltanto le seconde a discapito delle prime. Se si vuole costruire una élite capace e misurata alla guida del Minotauro, nelle alte sfere del pubblico e del privato, c’è da rinvigorire questa meritocrazia virtuosa e ciò significa che l’educazione umanistica deve riacquistare il suo significato, abbracciando materie come la filosofia, la politica, la geografia, le lingue moderne, la storia, il pensiero economico, la letteratura e forse anche l’antichità classica, il cui studio e stato a lungo il vivaio degli statisti e dei grandi uomini d’affari. Soltanto attraverso questo recupero sarà possibile fornire al nostro sistema quella che Thomas Jefferson chiamava la «aristocrazia naturale», una classe dirigente dove c’è confluenza di talento e di virtù. Di conseguenza, in un contesto in cui l’evoluzione del mercato va raccordata con la ragion di Stato la cooperazione tra pubblico e privato deve generare i migliori valori dell’uno e dell’altro.