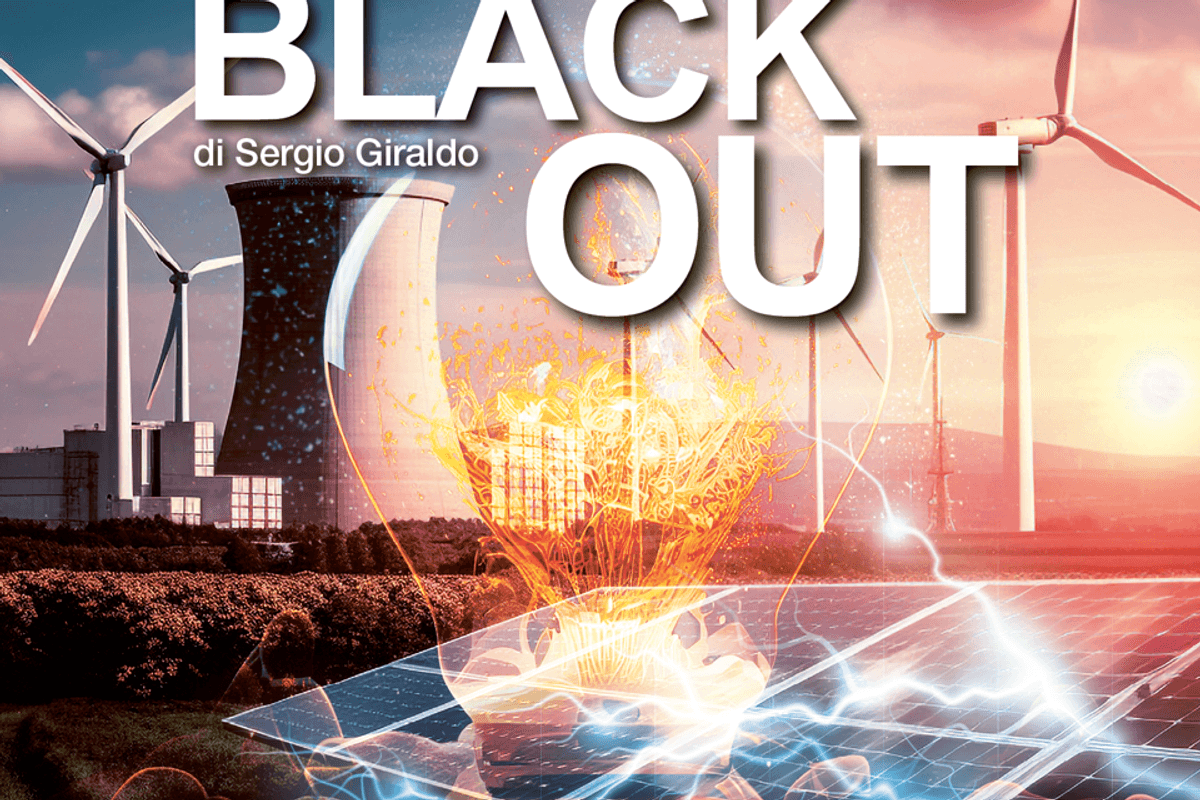True
2021-12-27
E se provassimo a non sparire?
L’Italia è sull’orlo di una catastrofe demografica. Tra cinquant’anni, infatti, il nostro Paese rischia di ritrovarsi con un quinto degli abitanti in meno. Giusto per dare un’idea degli ordini di grandezza in gioco, è come se la Lombardia e la Calabria fossero cancellate dalle carte geografiche. A lanciare l’allarme è stato, di recente, l’Istituto nazionale di statistica. Nel report sulle previsioni della popolazione residente e delle famiglie pubblicato lo scorso novembre, gli studiosi hanno dipinto un quadro a tinte che definire fosche è un eufemismo. Popolazione in calo dai 59,2 milioni di abitanti nel 2020 a 54,5 milioni nel 2050 e appena 47,6 milioni nel 2070. A conti fatti, 12 milioni di abitanti in meno nell’arco di una decina di lustri, per quello che l’Istat definisce senza mezzi termini un «potenziale quadro di crisi».
Sia chiaro, si tratta di previsioni e gli autori del report ci tengono a precisare che, come tali, sono «tanto più incerte quanto più ci si allontana dall’anno base». Quelli forniti nella sintesi sono valori mediani: nella migliore delle ipotesi la popolazione potrebbe subire una perdita di «soli» 4,7 milioni entro il 2070, ma esiste anche un drammatico scenario peggiore, che prevede un calo di ben 18,6 milioni di abitanti, con una popolazione risultante pari a 41,1 milioni di persone. In altre parole, la tendenza è chiara e «nel lungo termine le conseguenze della dinamica demografica» si fanno «importanti».
Sul piano geografico, tutte le macroaree prese in considerazione dall’Istat sono destinate a subire un calo, ma ad avere la peggio sarà il Sud. Nello scenario medio, infatti, il Mezzogiorno potrebbe passare dagli attuali 20,2 milioni di abitanti ai 16,7 milioni del 2050 e ai 13,6 milioni del 2070, facendo registrare un calo complessivo del 33%. Migliore - si fa per dire - la situazione al Centro, con 2,1 milioni di abitanti persi e un calo del 18% da qui a cinquant’anni, e al Nord, con 3,3 milioni di abitanti in meno e un decremento del 12%. Entro il 2030, poi, 8 comuni su 10 si troveranno in una condizione di calo demografico. Nel decennio 2020-2029, le zone rurali (-49.000 unità) e quelle a densità intermedia (-59.000) si spopoleranno a favore delle città e delle zone densamente popolate (+108.000), ma in generale la migrazione interna promuoverà il Centro-nord a danno delle aree del Mezzogiorno.
Come evidenzia il report, le cause di questo declino sono molteplici. Prima fra tutte la denatalità, un fenomeno già in corso da un quindicennio, e accentuato nell’ultimo biennio dal Covid. Nello scenario mediano il bilancio negativo tra nascite e decessi, dopo lo shock di breve termine imposto dalla pandemia, dovrebbe subire un’inversione di tendenza almeno fino al 2038, per poi subire un brusco calo da qui al 2070. In termini assoluti, si dovrebbe passare dalle attuali 400.000 nascite, alle 422.000 del 2038, per poi scendere fino a poco più di 350.000 del 2070.
Parallelamente, i decessi sono previsti in calo con meno di 700.000 unità da qui al 2035, per poi impennarsi fino al picco tra il 2055 e il 2060, quinquennio nel quale sono previsti più di 820.000 morti l’anno. Per effetto del calo delle nascite la popolazione subirà un progressivo invecchiamento. Già oggi gli over 65 rappresentano quasi un quarto (23,2%) del totale, mentre gli under 14 sono appena il 13%. In previsione, le persone con più di 65 anni potrebbero superare un terzo degli abitanti (35%), mentre bambini e ragazzi sotto i 14 anni poco più di un italiano su dieci (11,7%).
Nemmeno gli immigrati, tanto cari a una certa sinistra anche per la loro capacità di mascherare questa emorragia, rappresenteranno più una garanzia. L’Istat definisce infatti lo scenario migratorio «positivo ma incerto», con un saldo tra immigrati ed emigrati all’estero sbilanciato sui primi con valori tra le 118.000 e le 140.000 unità. Un equilibrio giudicato precario anche dagli autori, costretti ad ammettere che lo studio restituisce «due possibili fotografie del futuro tra loro molto diverse». Una che ritrae un «Paese molto attrattivo», e l’altra quella di un’Italia che «potrebbe radicalmente mutare la sua natura di accoglienza per tornare a essere un luogo da cui emigrare».
Ma l’aspetto forse più sorprendente, e al tempo stesso preoccupante, messo in luce dal rapporto dell’Istat risulta quello relativo alla trasformazione della famiglia. Con un paradosso: pur crescendo di numero, dagli attuali 25,7 milioni di unità ai 26,6 milioni nel 2040, diventeranno sempre più evanescenti. In aumento le coppie senza figli (dal 19,8% odierno al 21,6% del 2040) e, viceversa, in drastico calo quelle con figli (dal 32,1% al 23,9%). Sempre di più le persone sole sia di sesso maschile (+17%) che femminile (+23%), una categoria che complessivamente toccherà tra vent’anni quota 10 milioni.
Già nel censimento 2020, i cui risultati sono stati diffusi dall’Istat lo scorso 9 dicembre, si possono riscontrare le prime avvisaglie di questa preoccupante tendenza. Ormai la popolazione italiana si attesta stabilmente sotto quota 60 milioni (59,23 per la precisione), con un saldo negativo pari a 405.275 unità rispetto al 2019. Tranne l’Emilia-Romagna (+310 abitanti), tutte le Regioni fanno registrare una diminuzione degli abitanti. Marcato l’invecchiamento, con il costante e progressivo aumento delle classi di età più anziane e lo snellimento di quelle più giovani. Segnali che confermano come, senza un intervento rapido e netto, una fetta d’Italia è destinata nel prossimo futuro a sparire nel nulla.
Da Regioni e Comuni pioggia di incentivi ma lo Stato è assente
«Voglia di ritmi più lenti e in armonia con la natura? Di luoghi incontaminati in cui respirare a pieni polmoni e far crescere i propri figli in libertà? Di un posto diverso dove continuare il proprio lavoro, sempre più connesso e smart, o in cui iniziare magari una nuova attività? Cambiare vita si può», si legge nel comunicato diffuso lo scorso agosto dagli uffici di Piazza Castello a Torino, «e la Regione Piemonte ti aiuta a farlo». Sul piatto, un contributo da 10.000 a 40.000 euro (per complessivi 10 milioni di euro) destinato a chi sceglie di trasferirsi in un centro urbano e acquista o recupera un immobile in un Comune montano con meno di 5.000 abitanti. Obiettivo: invogliare giovani e meno giovani a ripopolare gli oltre 400 piccoli borghi piemontesi.
Famosa l’iniziativa delle case in vendita al prezzo simbolico di 1 euro, sposata da molti piccoli Comuni sparsi per la penisola. Si va da Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, dove l’amministrazione ha aperto un secondo bando dopo avere già esaurito il primo lotto di 16 immobili; a Nulvi, provincia di Sassari, paesino nel quale tutte le case sono già state vendute; a Castropignano, in Molise, borgo storico di quasi 900 abitanti, dove sono stati immesse sul mercato diverse decine di immobili. Il progetto è talmente ampio e diffuso che si è meritato la realizzazione di un sito (Casea1euro.it) nel quale vengono raccolte informazioni sui Comuni aderenti e sui bandi pubblicati.
Visitando la pagina, è possibile anche consultare una mappa geografica interattiva per scoprire le zone di interesse. Un’idea che funziona? A Mussomeli (Caltanissetta), le richieste sono state circa 60.000, e gli immobili venduti circa 100. Ollolai, centro di 1.300 abitanti in provincia di Nuoro, ha fatto notizia, approdando nel 2018 addirittura sulla stampa internazionale. Tanto che, proprio in questi giorni, in municipio si apprestano a varare la «fase 2» del programma.
Strizza l’occhio alle giovani famiglie il piano lanciato la scorsa prima dal Comune di Bianzano, meno di 600 anime in provincia di Bergamo. Doppio bonus, uno da 500 euro per le coppie under 35 e l’altro da 250 euro per i nuovi nati, a condizione però che gli aderenti sottoscrivano un «patto di residenza», impegnandosi cioè a vivere nel paesino per almeno quattro anni. Nel 2019, era stato Luserna (250 abitanti in provincia di Trento) a mettere a disposizione di quattro coppie altrettanti immobili a titolo gratuito. Un progetto dal valore sociale, dal momento che i nuclei assegnatari «prenderanno parte a un processo partecipato, che prevederà una formazione iniziale con il coinvolgimento della comunità locale». Obiettivo? Dare «nuova linfa alla comunità cimbra».
Pochi giorni fa, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato una legge a difesa dei piccoli Comuni del territorio. Fino a 2.500 euro annui dalla nascita di un figlio fino ai 3 anni d’età, più un contributo di 2.500 euro a chi decide di trasferirsi in un piccolo centro montano abruzzese. Complessivamente, uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per il biennio 2022-23. Promossa da Fratelli d’Italia, la norma è stata lodata dalla leader Giorgia Meloni, la quale l’ha definita «un esempio di buongoverno che mi auguro possa essere d’esempio anche per altre amministrazioni locali e regionali».
Un recente bando ancora allo studio da parte di alcuni Comuni calabresi ha destato l’attenzione nientemeno che della Cnn. Fino a 28.000 euro all’anno per iniziare una nuova vita e una nuova attività economica nei borghi con meno di 2.000 abitanti. La formula è ancora da definire, ma si pensa di erogare ai nuovi residenti un contributo mensile tra gli 800 e i 1.000 euro per due o tre anni. In alternativa, un finanziamento per l’apertura di un’attività commerciale o residenziale.
«Invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree interne». Stando alle dichiarazioni programmatiche pronunciate in Parlamento dal premier Mario Draghi lo scorso febbraio, il drammatico calo della popolazione rappresenta per l’esecutivo una priorità da affrontare con la massima determinazione. Nell’attesa che i buoni propositi dell’attuale governo si traducano in atti concreti, va registrato un fatto: in assenza di una regìa nazionale comune, finora i territori si sono trovati ad affrontare da soli ad affrontare una problematica più grande di loro, costretti a fare i conti con i vincoli burocratici e le limitate disponibilità finanziarie ereditate dai pesanti anni di austerità.
Continua a leggereRiduci
L’Istat fotografa una catastrofe: crollano le nascite e aumenta l’età media, tra una cinquantina d’anni gli italiani saranno 12 milioni in meno. Le misure per invertire la tendenza ancora non bastano.Migliaia di richieste dall’estero per case a costo zero nei borghi da ripopolare. Manca però una strategia nazionale di intervento.Lo speciale contiene due articoli.L’Italia è sull’orlo di una catastrofe demografica. Tra cinquant’anni, infatti, il nostro Paese rischia di ritrovarsi con un quinto degli abitanti in meno. Giusto per dare un’idea degli ordini di grandezza in gioco, è come se la Lombardia e la Calabria fossero cancellate dalle carte geografiche. A lanciare l’allarme è stato, di recente, l’Istituto nazionale di statistica. Nel report sulle previsioni della popolazione residente e delle famiglie pubblicato lo scorso novembre, gli studiosi hanno dipinto un quadro a tinte che definire fosche è un eufemismo. Popolazione in calo dai 59,2 milioni di abitanti nel 2020 a 54,5 milioni nel 2050 e appena 47,6 milioni nel 2070. A conti fatti, 12 milioni di abitanti in meno nell’arco di una decina di lustri, per quello che l’Istat definisce senza mezzi termini un «potenziale quadro di crisi». Sia chiaro, si tratta di previsioni e gli autori del report ci tengono a precisare che, come tali, sono «tanto più incerte quanto più ci si allontana dall’anno base». Quelli forniti nella sintesi sono valori mediani: nella migliore delle ipotesi la popolazione potrebbe subire una perdita di «soli» 4,7 milioni entro il 2070, ma esiste anche un drammatico scenario peggiore, che prevede un calo di ben 18,6 milioni di abitanti, con una popolazione risultante pari a 41,1 milioni di persone. In altre parole, la tendenza è chiara e «nel lungo termine le conseguenze della dinamica demografica» si fanno «importanti». Sul piano geografico, tutte le macroaree prese in considerazione dall’Istat sono destinate a subire un calo, ma ad avere la peggio sarà il Sud. Nello scenario medio, infatti, il Mezzogiorno potrebbe passare dagli attuali 20,2 milioni di abitanti ai 16,7 milioni del 2050 e ai 13,6 milioni del 2070, facendo registrare un calo complessivo del 33%. Migliore - si fa per dire - la situazione al Centro, con 2,1 milioni di abitanti persi e un calo del 18% da qui a cinquant’anni, e al Nord, con 3,3 milioni di abitanti in meno e un decremento del 12%. Entro il 2030, poi, 8 comuni su 10 si troveranno in una condizione di calo demografico. Nel decennio 2020-2029, le zone rurali (-49.000 unità) e quelle a densità intermedia (-59.000) si spopoleranno a favore delle città e delle zone densamente popolate (+108.000), ma in generale la migrazione interna promuoverà il Centro-nord a danno delle aree del Mezzogiorno.Come evidenzia il report, le cause di questo declino sono molteplici. Prima fra tutte la denatalità, un fenomeno già in corso da un quindicennio, e accentuato nell’ultimo biennio dal Covid. Nello scenario mediano il bilancio negativo tra nascite e decessi, dopo lo shock di breve termine imposto dalla pandemia, dovrebbe subire un’inversione di tendenza almeno fino al 2038, per poi subire un brusco calo da qui al 2070. In termini assoluti, si dovrebbe passare dalle attuali 400.000 nascite, alle 422.000 del 2038, per poi scendere fino a poco più di 350.000 del 2070. Parallelamente, i decessi sono previsti in calo con meno di 700.000 unità da qui al 2035, per poi impennarsi fino al picco tra il 2055 e il 2060, quinquennio nel quale sono previsti più di 820.000 morti l’anno. Per effetto del calo delle nascite la popolazione subirà un progressivo invecchiamento. Già oggi gli over 65 rappresentano quasi un quarto (23,2%) del totale, mentre gli under 14 sono appena il 13%. In previsione, le persone con più di 65 anni potrebbero superare un terzo degli abitanti (35%), mentre bambini e ragazzi sotto i 14 anni poco più di un italiano su dieci (11,7%).Nemmeno gli immigrati, tanto cari a una certa sinistra anche per la loro capacità di mascherare questa emorragia, rappresenteranno più una garanzia. L’Istat definisce infatti lo scenario migratorio «positivo ma incerto», con un saldo tra immigrati ed emigrati all’estero sbilanciato sui primi con valori tra le 118.000 e le 140.000 unità. Un equilibrio giudicato precario anche dagli autori, costretti ad ammettere che lo studio restituisce «due possibili fotografie del futuro tra loro molto diverse». Una che ritrae un «Paese molto attrattivo», e l’altra quella di un’Italia che «potrebbe radicalmente mutare la sua natura di accoglienza per tornare a essere un luogo da cui emigrare».Ma l’aspetto forse più sorprendente, e al tempo stesso preoccupante, messo in luce dal rapporto dell’Istat risulta quello relativo alla trasformazione della famiglia. Con un paradosso: pur crescendo di numero, dagli attuali 25,7 milioni di unità ai 26,6 milioni nel 2040, diventeranno sempre più evanescenti. In aumento le coppie senza figli (dal 19,8% odierno al 21,6% del 2040) e, viceversa, in drastico calo quelle con figli (dal 32,1% al 23,9%). Sempre di più le persone sole sia di sesso maschile (+17%) che femminile (+23%), una categoria che complessivamente toccherà tra vent’anni quota 10 milioni.Già nel censimento 2020, i cui risultati sono stati diffusi dall’Istat lo scorso 9 dicembre, si possono riscontrare le prime avvisaglie di questa preoccupante tendenza. Ormai la popolazione italiana si attesta stabilmente sotto quota 60 milioni (59,23 per la precisione), con un saldo negativo pari a 405.275 unità rispetto al 2019. Tranne l’Emilia-Romagna (+310 abitanti), tutte le Regioni fanno registrare una diminuzione degli abitanti. Marcato l’invecchiamento, con il costante e progressivo aumento delle classi di età più anziane e lo snellimento di quelle più giovani. Segnali che confermano come, senza un intervento rapido e netto, una fetta d’Italia è destinata nel prossimo futuro a sparire nel nulla.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/se-provassimo-a-non-sparire-2656161978.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="da-regioni-e-comuni-pioggia-di-incentivi-ma-lo-stato-e-assente" data-post-id="2656161978" data-published-at="1640528573" data-use-pagination="False"> Da Regioni e Comuni pioggia di incentivi ma lo Stato è assente «Voglia di ritmi più lenti e in armonia con la natura? Di luoghi incontaminati in cui respirare a pieni polmoni e far crescere i propri figli in libertà? Di un posto diverso dove continuare il proprio lavoro, sempre più connesso e smart, o in cui iniziare magari una nuova attività? Cambiare vita si può», si legge nel comunicato diffuso lo scorso agosto dagli uffici di Piazza Castello a Torino, «e la Regione Piemonte ti aiuta a farlo». Sul piatto, un contributo da 10.000 a 40.000 euro (per complessivi 10 milioni di euro) destinato a chi sceglie di trasferirsi in un centro urbano e acquista o recupera un immobile in un Comune montano con meno di 5.000 abitanti. Obiettivo: invogliare giovani e meno giovani a ripopolare gli oltre 400 piccoli borghi piemontesi. Famosa l’iniziativa delle case in vendita al prezzo simbolico di 1 euro, sposata da molti piccoli Comuni sparsi per la penisola. Si va da Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, dove l’amministrazione ha aperto un secondo bando dopo avere già esaurito il primo lotto di 16 immobili; a Nulvi, provincia di Sassari, paesino nel quale tutte le case sono già state vendute; a Castropignano, in Molise, borgo storico di quasi 900 abitanti, dove sono stati immesse sul mercato diverse decine di immobili. Il progetto è talmente ampio e diffuso che si è meritato la realizzazione di un sito (Casea1euro.it) nel quale vengono raccolte informazioni sui Comuni aderenti e sui bandi pubblicati. Visitando la pagina, è possibile anche consultare una mappa geografica interattiva per scoprire le zone di interesse. Un’idea che funziona? A Mussomeli (Caltanissetta), le richieste sono state circa 60.000, e gli immobili venduti circa 100. Ollolai, centro di 1.300 abitanti in provincia di Nuoro, ha fatto notizia, approdando nel 2018 addirittura sulla stampa internazionale. Tanto che, proprio in questi giorni, in municipio si apprestano a varare la «fase 2» del programma. Strizza l’occhio alle giovani famiglie il piano lanciato la scorsa prima dal Comune di Bianzano, meno di 600 anime in provincia di Bergamo. Doppio bonus, uno da 500 euro per le coppie under 35 e l’altro da 250 euro per i nuovi nati, a condizione però che gli aderenti sottoscrivano un «patto di residenza», impegnandosi cioè a vivere nel paesino per almeno quattro anni. Nel 2019, era stato Luserna (250 abitanti in provincia di Trento) a mettere a disposizione di quattro coppie altrettanti immobili a titolo gratuito. Un progetto dal valore sociale, dal momento che i nuclei assegnatari «prenderanno parte a un processo partecipato, che prevederà una formazione iniziale con il coinvolgimento della comunità locale». Obiettivo? Dare «nuova linfa alla comunità cimbra». Pochi giorni fa, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato una legge a difesa dei piccoli Comuni del territorio. Fino a 2.500 euro annui dalla nascita di un figlio fino ai 3 anni d’età, più un contributo di 2.500 euro a chi decide di trasferirsi in un piccolo centro montano abruzzese. Complessivamente, uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per il biennio 2022-23. Promossa da Fratelli d’Italia, la norma è stata lodata dalla leader Giorgia Meloni, la quale l’ha definita «un esempio di buongoverno che mi auguro possa essere d’esempio anche per altre amministrazioni locali e regionali». Un recente bando ancora allo studio da parte di alcuni Comuni calabresi ha destato l’attenzione nientemeno che della Cnn. Fino a 28.000 euro all’anno per iniziare una nuova vita e una nuova attività economica nei borghi con meno di 2.000 abitanti. La formula è ancora da definire, ma si pensa di erogare ai nuovi residenti un contributo mensile tra gli 800 e i 1.000 euro per due o tre anni. In alternativa, un finanziamento per l’apertura di un’attività commerciale o residenziale. «Invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree interne». Stando alle dichiarazioni programmatiche pronunciate in Parlamento dal premier Mario Draghi lo scorso febbraio, il drammatico calo della popolazione rappresenta per l’esecutivo una priorità da affrontare con la massima determinazione. Nell’attesa che i buoni propositi dell’attuale governo si traducano in atti concreti, va registrato un fatto: in assenza di una regìa nazionale comune, finora i territori si sono trovati ad affrontare da soli ad affrontare una problematica più grande di loro, costretti a fare i conti con i vincoli burocratici e le limitate disponibilità finanziarie ereditate dai pesanti anni di austerità.
Pensata per i bambini, fa felici i grandi. Ecco una preparazione sfiziosa per rallegrare un pranzo, una cena veloce tra amici (basta un’ottima insalata d’accompagno e il gioco è fatto), per dare al pollo il giusto posto a tavola. Sappiate che potete fare questi bocconcini filanti in forno (180 gradi statico pre-riscaldato e dopo una quindicina di minuti saranno pronti) fritti, oppure, come abbiamo fatto noi, in friggitrice ad aria (ci vogliono una ventina di minuti). Per il resto tutto molto semplice, ma alla fine un trionfo di gusto croccante.
Ingredienti – 8 fette sottili di petto di pollo, 8 fette di prosciutto cotto, 8 fette di scamorza o altro formaggio a pasta filata, 3 uova, 60 gr di farina, 100 gr di pangrattato, olio per frittura se del caso oppure olio per friggitrice ad aria spray, olio extravergine, sale e pepe qb.
Procedimento – Battete col batticarne le fette di pollo e una volta ben spianate salatele appena, mettete un pizzico di pepe e farcitele con una fetta di prosciutto cotto e una di scamorza. Arrotolatele a involtino e fissatele con uno stecchino. Ora battete le uova in una ciotola con un po’ di sale e pepe. In due piatti distinti sistemate la farina e il pangrattato. Passate nella farina gli involtini, poi nell’uovo, poi nel pangrattato, di nuovo nell’uovo e in ultimo ancora nel pangrattato. Dovete fare agli involtini il cappotto come si dice in gergo! Ora cuocete secondo il metodo che avete scelto. Se in forno sistemateli su una placca foderata da carta forno e irrorateli con po’ di olio extravergine di oliva, se nella friggitrice ad aria sistemateli nel cestello e spruzzateli con l’olio apposito, se fritti fate scaldare il grasso in una padella e procedete come con qualsiasi frittura.
Come fa divertire i bambini – Fatevi aiutare nei diversi passaggi d’impanatura.
Abbinamento – In omaggio ai 400 anni di Francesco Redi abbiamo scelto un Chianti Superiore del Valdarno. Vanno benissimo un rosso di Montepulciano, un Rosso Piceno, ma anche un ottimo Pere e’ Palummo campano o una Schiava altoatesina. Altrimenti optate per una bollicina.
Continua a leggereRiduci
Donald Trump (Ansa)
«Sulla base di un’analisi approfondita, dettagliata e completa...», scrive Donald Trump e l’economia internazionale trattiene il fiato. Annuncia la nuova tariffa globale che sale dal 10 al 15%, «con effetto immediato». Un aumento deciso - spiega il presidente - per rimediare a decenni in cui molti Paesi hanno «derubato» gli Stati Uniti. Promette ulteriori tariffe «legalmente ammissibili» nei prossimi mesi, lasciando intendere che le nuove aliquote potrebbero non essere il capolinea, ma solo una stazione intermedia. La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle intenzioni avrebbe dovuto riportare ordine. Nella pratica, ha avuto l’effetto di scuotere il tavolo mentre sopra c’erano ancora le carte.
Il risultato è una situazione che gli operatori descrivono con una parola molto efficace: caos. Accordi firmati che rischiano di essere reinterpretati prima ancora di entrare a regime. Le aziende, che per loro natura preferiscono i calendari alle sorprese, si trovano a pianificare esportazioni come si organizza un viaggio in una zona sismica: pronti a cambiare strada da un momento all’altro. In teoria il nuovo prelievo non si applicherà ai prodotti già soggetti a tariffe settoriali, né a quelli provenienti dai partner nordamericani, e prevede eccezioni sensibili, come per il farmaceutico. In pratica, ogni esclusione genera una nuova domanda, ogni chiarimento ne richiede un altro. È l’effetto domino della regolazione commerciale contemporanea: una norma non chiude, ma apre scenari. Così il commercio internazionale entra in una dimensione curiosa, una specie di presente continuo dove tutto è provvisorio. Non c’è più la certezza - costosa ma rassicurante - delle regole stabili. C’è una sequenza di decisioni adattive, ciascuna delle quali obbliga imprese e governi a ricalcolare le proprie mosse. Per l’Unione europea il problema non è tanto il livello del dazio - quel 15% era già stato messo in conto nell’accordo siglato con Washington - quanto la sua natura mutevole. Se il quadro giuridico cambia mentre gli accordi sono ancora caldi di firma, diventa difficile capire quali condizioni resteranno in piedi e per quanto. Bruxelles attende chiarimenti, convoca riunioni straordinarie, aggiorna dossier. Per domani è previsto il voto dell’Europarlamento sull’accordo siglato la scorsa estate da Ursula von der Leyen. A questo punto c’è da chiedersi: che cosa si vota?
Le imprese, molto meno filosoficamente, cercano di capire se spedire o aspettare. Dai produttori di vino italiani ai gruppi chimici tedeschi, il timore è «l’effetto boomerang»: mesi di adattamento a nuove regole che rischiano di essere riscritte mentre sono ancora in fase di applicazione.
Un dazio, infatti, si può incorporare nei prezzi. Un dazio che cambia forma, durata e motivazione nel giro di settimane è un’altra cosa: diventa un fattore di instabilità strutturale.
Le catene globali del valore - costruite in trent’anni di integrazione - funzionano come orologi: precise, interdipendenti, allergiche agli scossoni. Ogni variazione improvvisa obbliga a ripensare forniture, logistica, investimenti. E quando le decisioni politiche viaggiano più veloci delle merci, l’economia rallenta per prudenza. In questo contesto, l’intervento di Fabio Panetta, al congresso Assiom Forex, suona come una nota di metodo in mezzo al frastuono. Il governatore della Banca d’Italia invita a non arrendersi alla frammentazione e a non archiviare con troppa leggerezza quel multilateralismo che ha sostenuto la crescita globale del dopoguerra.
Non entra nello scontro istituzionale americano - troppo presto per valutarne gli effetti - ma richiama il punto essenziale: l’economia mondiale sta cambiando rapidamente, sospinta dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale, e proprio per questo avrebbe bisogno di più cooperazione, non di meno. Da una parte c’è la politica commerciale che accelera, fatta di decisioni rapide, aggiustamenti continui, annunci immediati. Dall’altra c’è l’economia reale, che per funzionare ha bisogno di tempo, fiducia e prevedibilità. È lo scarto tra queste due velocità a generare l’incertezza che oggi preoccupa imprese e governi più dei dazi stessi. Perché l’economia mondiale può sopravvivere a molti aumenti di dazi, ma fatica molto di più a sopravvivere alla perdita delle regole comuni che l’hanno fatta crescere.
Continua a leggereRiduci
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (Ansa)
All’evento «Non c’è sì-curezza senza giustizia» gli ospiti d’onore sono il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Per Fratelli d’Italia presenti i capigruppo alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan e poi Giovanni Donzelli, Augusta Montaruli e Elisabetta Gardini. La mattinata si è aperta con un video del premier Giorgia Meloni. Poi le interviste/dibattito con i due ministri Nordio e Piantedosi.
«Il referendum è un voto di merito sulla riforma. I governi si valutano nelle sedi e nei tempi propri», ha ribadito il ministro dell’Interno escludendo «scossoni istituzionali» a prescindere dall’esito del voto. Sul tema del rapporto tra polizia giudiziaria ha chiarito: «Sfido chiunque a indicare dove, nel testo costituzionale, sia previsto anche indirettamente un simile assetto. Non si incide sul rapporto tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, che resta saldo e rappresenta una ricchezza del nostro ordinamento». Per quanto riguarda i toni della campagna ammonisce velatamente il suo collega Nordio quando dice: «Dobbiamo puntare sulla forza della ragione e non commettere falli di reazione rispetto alle provocazioni che arrivano da alcune parti. È legittimo che nel Paese ci sia chi sostiene il Sì e chi il No, ma il confronto deve restare nel merito».
Piantedosi ha parlato anche di immigrazione lamentando che «alcuni magistrati non fanno mistero di avere una posizione in qualche modo sfavorevole, concettualmente sfavorevole, non alle leggi ma alla filosofia del contrasto all’immigrazione irregolare». Il numero uno del Viminale ha parlato di «filosofia immigrazionista, legittima a livello di politica, di opinione pubblica, ma non si può immaginare che possa essere quella di un giudice». «Alcuni sono ben noti», ha proseguito, «altri hanno nomi ben precisi e hanno avuto anche l’accortezza di dire che in qualche modo ha chiesto la collocazione personale proprio nelle Sezioni specializzate, che curano questa materia proprio per intervenire in maniera che poi abbiamo visto in casi specifici. È così, noi l’abbiamo verificato», la sua grave accusa.
All’evento interviene anche Nordio. «La riforma tende anche a liberare le energie di tutti magistrati bravi, preparati e operosi che non essendo iscritti alla corrente fino adesso non hanno nessuna possibilità di assumere incarichi apicali». Sui toni usati nei giorni precedenti, Nordio spiega di non pentirsi «perché io non li ho mai inaspriti (i toni), a suo tempo mi sono limitato a citare quello che avevano detto altri. Nel complesso delle polemiche che sono state accese da varie parti, abbiamo condiviso e ringraziato il presidente Mattarella perché con il suo intervento speriamo, e siamo certi anzi, che i toni saranno ricondotti nell’ambito fisiologico della dialettica dei contenuti». E poi: «Parleremo del contenuto di questa riforma sperando che non ci diano degli eversori, anticostituzionalisti, piduisti, mafiosi o altro, ma semplicemente che si possano analizzare gli elementi di un codice di una riforma costituzionale che si inserisce nel percorso iniziato 40 anni fa da un eroe della Resistenza che era Giuliano Vassalli». Su Gratteri «non sono mai stato in lite, anzi» assicura. «Ogni volta che lo vedo, ci scambiamo la mano e qualche volta anche baci e abbracci. Lui ha un carattere un po’ fumino e un modo di esprimersi pittoresco che non è il mio. Però, quando si esagera con gli aggettivi bisogna anche cercare di abbassare i toni». Il padrone di casa è Galeazzo Bignami, Bologna la sua città. «Non c’è sicurezza senza giustizia e non c’è giustizia senza il coraggio di mantenere gli impegni presi con i cittadini», ha esordito aprendo l’incontro. «Il nostro interesse non è alimentare scontri o contrapposizioni, né costringere le nostre bravissime forze dell’ordine a dover difendere il diritto di tutti a parlare e manifestare. Abbiamo quindi ritenuto, pur sapendo che sarebbe stato più penalizzante in termini di partecipazione, di svolgere l’incontro in questa struttura, garantendo maggiore controllo e tranquillità. A noi interessa confrontarci nel merito». Quanto al referendum «se Bologna risponde così, e se l’Emilia-Romagna risponde così, credo che potremo avere soddisfazioni». Inevitabile affrontare l’argomento del Cpr a Bologna e a margine risponde: «È chiaro che dobbiamo farlo nel dialogo con le istituzioni e abbiamo apprezzato l’apertura del presidente Michele de Pascale. Per il governo la cosa migliore è trovare un accordo con i territori però è altrettanto importante introdurre questi strumenti dove c’è bisogno» e «noi riteniamo che Bologna sia un luogo utile».
Continua a leggereRiduci
Eni inizia l’export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l’abbandono. Scende il prezzo del rame. La Libia taglia le forniture di benzina dalla Russia.