San Tommaso gigante della psicoterapia, il lato meno esplorato del filosofo di Dio
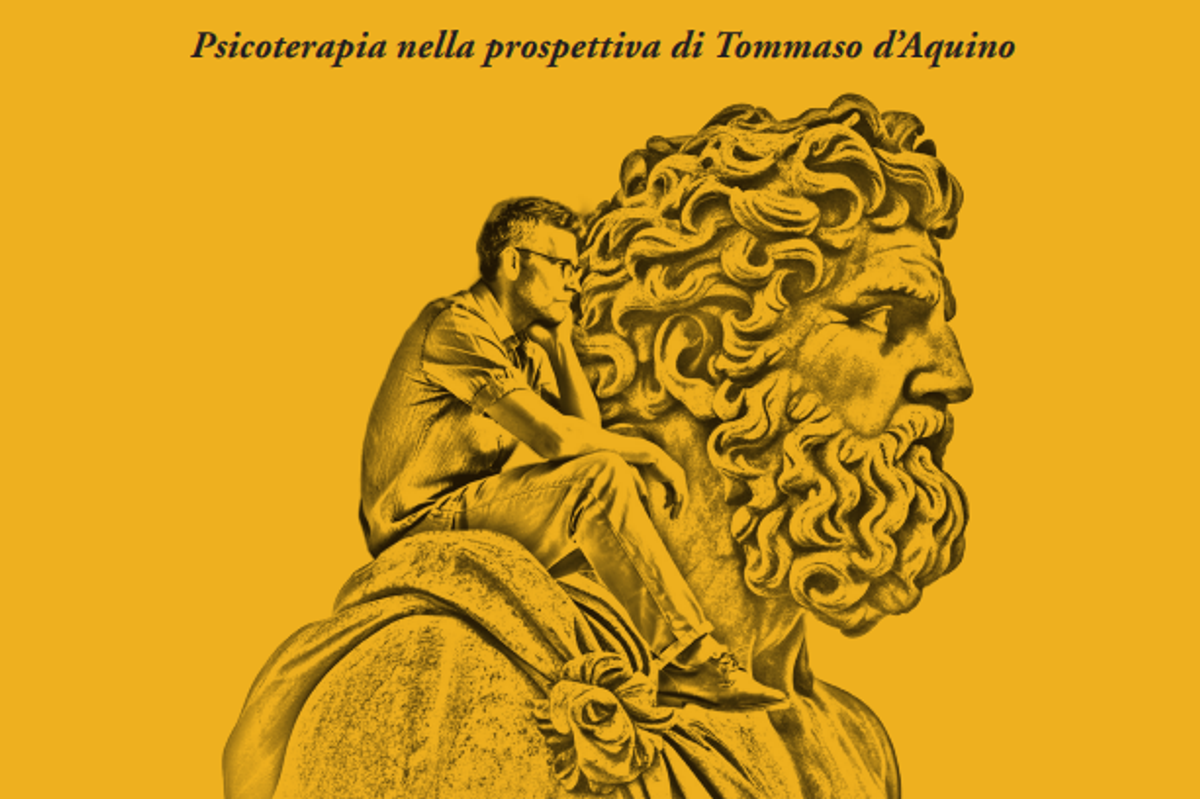
Perché proprio San Tommaso? Con papa Benedetto XV, nel 1921 la Chiesa ha stabilito che la dottrina di Tommaso fosse «anche la sua propria». Anche il Concilio Vaticano II che, con la Gaudium et spes mirava a dialogare con il mondo secolarizzato (utilizzando anche la psicologia), non ha mancato di raccomandare San Tommaso come maestro degli studi. Più recentemente, papa Giovanni Paolo II ha sottolineato un aspetto particolarmente significativo definendo l’Aquinate dottore di umanità e invitando ad approfondire i trattati dedicati all’antropologia presenti nella sua opera. [...] Un secondo gruppo di segnalazioni proviene da alcuni psicologi cattolici del XX secolo profondamente segnati dall’incontro con la prospettiva tomista. Il primo è Rudolf Allers il quale, già esperto psichiatra e allievo di Alfred Adler, così racconta: «Nel corso della guerra del 1914-18, nei lunghi periodi di relativa inerzia all’ospedaletto da campo, crebbe in me la persuasione che la filosofia tomista offrisse in realtà la base più adatta per lo sviluppo di un sistema di “antropologia filosofica” quale fondamento di una teoria della psiche sia normale che anormale». Fu questa intuizione che lo portò a Milano da padre Agostino Gemelli - rettore dell’Università Cattolica, filosofo e psicologo - ove completò un dottorato in filosofia tomista che lo indusse ad abbandonare le psicologie secolari per dedicarsi alla costruzione di una teoria della psiche sulla base dell’antropologia cristiana. [...] È questa la lezione che papa Francesco ha più volte impartito: «Così, il tomismo va avanti seguendo un doppio movimento vitale di “sistole e diastole”. Sistole, perché bisogna prima concentrarsi sullo studio dell’opera di San Tommaso nel suo contesto storico-culturale, per individuarne i principi strutturanti e coglierne l’originalità. Dopo, viene la diastole: rivolgersi nel dialogo al mondo odierno, per assimilare criticamente ciò che di vero e giusto c’è nella cultura del tempo».
Un percorso analogo a quello di Allers lo ha sperimentato Magda Arnold quando ha impattato inaspettatamente con gli scritti di San Tommaso: «[…] alla fine dell’estate, possedetti almeno un fondamento su cui dopo avrei costruito di mia iniziativa, leggendo il De anima di Tommaso d’Aquino e parti della Summa. Li trovavo sorprendentemente semplici e stupefacentemente moderni. Il De anima era il primo trattato sistematico delle capacità psicologiche umane che avessi visto. Da quel giorno, non ho mai trovato nulla che lo superasse. Si adatta alle scoperte della ricerca moderna e le rende intelligibili in un modo che non avevo trovato da nessun’altra parte». È impressionante pensare che una docente universitaria, ricercatrice e sperimentatrice nel campo delle emozioni, rimanga stupefatta per gli scritti di un autore deceduto 700 anni prima. «Presto realizzai che la sintesi tomista offrisse un sicuro fondamento per la visione psicologica che avevo lentamente elaborato nel corso degli anni precedenti».
[...] Purtroppo al giorno d’oggi San Tommaso è stato dimenticato ed è sconosciuto nei seminari e nelle università cattoliche (di psicologia, e in parte anche di filosofia). Tommaso d’Aquino viene invece apprezzato da diversi autori non cattolici, specialmente nell’ambito della filosofia. [...] Nel campo della psicoterapia sono davvero sorprendenti gli elogi che Erich Fromm - ebreo, marxista e umanista - tributa all’Angelico: «In Tommaso d’Aquino si incontra un sistema psicologico da cui si può probabilmente apprendere di più che dalla gran parte degli attuali manuali di tale disciplina: si incontrano in esso trattati interessantissimi e molto profondi di temi come il narcisismo, la superbia, l’umiltà, la modestia, i sentimenti d’inferiorità, e molti altri».
Anche Karl Jaspers, nella sua celebre Psicopatologia generale, si unisce al coro degli encomi: «Ancora oggi vale la pena di studiare la psicologia di San Tommaso. Essa è veramente originale e la sua realizzazione è grandiosa. Le sue classificazioni meritano di essere meditate».
Cosa può aver generato tali riconoscimenti? Tra le tante risposte che si possono ipotizzare, ritengo che un ruolo centrale sia svolto dal carattere «laico» dell’argomentare di San Tommaso che, a sua volta, si basa sullo schema delle disputationes medievali. «Argomentare» ha la stessa radice etimologica della parola argento: indica una materia che «luccica», come la verità messa in luce dal ragionamento. San Tommaso riproduce nei suoi testi questa dinamica, che risulta particolarmente ordinata e fondata sulla ragione, e che anticipa e rispecchia il metodo «scientifico» - se così possiamo dire - delle ipotesi e verifiche in voga oggigiorno. Aggiungiamo anche che San Tommaso sviluppa in modo originale il rapporto tra le prove ricavate dalla ragione (secondo lo schema della logica aristotelica) e quelle dedotte dalla fede (i contenuti espressi specialmente nel Vangelo, nell’antico testamento e nei Padri della Chiesa), limitando le seconde solo quando le prime si rivelano insufficienti.
A queste considerazioni è bene aggiungerne una ulteriore che riguarda il contenuto dell’opera tomista. La produzione dell’Aquinate è sostanzialmente di tre tipologie: i commenti, le questioni disputate e le opere originali (tra cui le due grandi Summae, la Contra gentiles e la Somma di teologia). Non è un caso che i due testi principali siano chiamati «summe», ovvero compendi o sintesi di ampia portata.
Nel compiere questo percorso Tommaso attinge alle fonti principali del pensiero umano: la filosofia greca e romana, i commenti arabi ed ebrei, la teologia dei Padri e la Sacra scrittura. Si potrebbe dire che svolge una doppia sintesi: tra le varie correnti del pensiero umano, in particolare l’aristotelismo e il platonismo, e tra queste e la Rivelazione. Viene a delinearsi così una piattaforma, concettuale e di linguaggio, che permette innanzitutto il confronto e poi l’integrazione delle varie prospettive: la valorizzazione degli elementi innovativi, posteriori a Tommaso, e il rifiuto di quelli erronei. [...] Questa libertà di giudizio lo rende un modello di scienziato, il cui spirito buono e vero, valorizzante e allo stesso tempo rigoroso, va custodito e alimentato.



 Lipsia, il mercato e il vecchio municipio (iStock)
Lipsia, il mercato e il vecchio municipio (iStock) La città di Brno in Repubblica Ceca (iStock)
La città di Brno in Repubblica Ceca (iStock) Trnava, Slovacchia (iStock)
Trnava, Slovacchia (iStock) Il centro storico di Brașov in Transilvania (iStock)
Il centro storico di Brașov in Transilvania (iStock)

