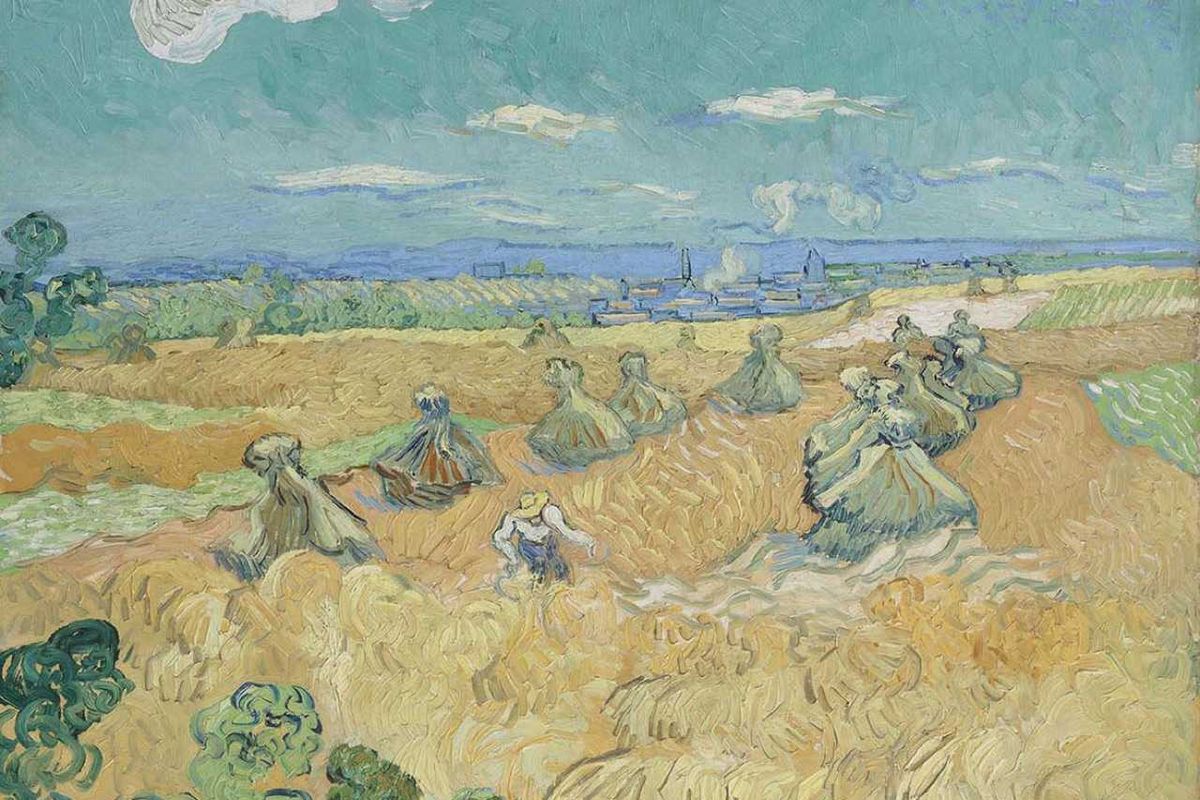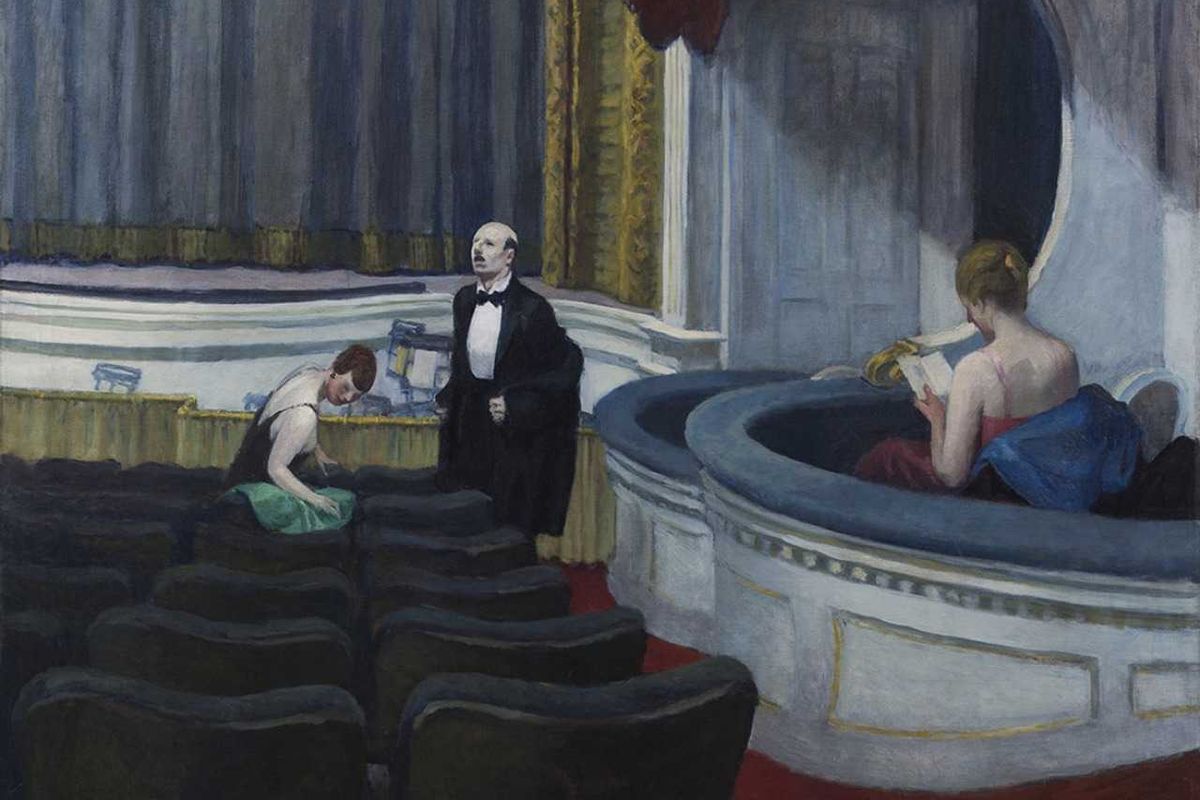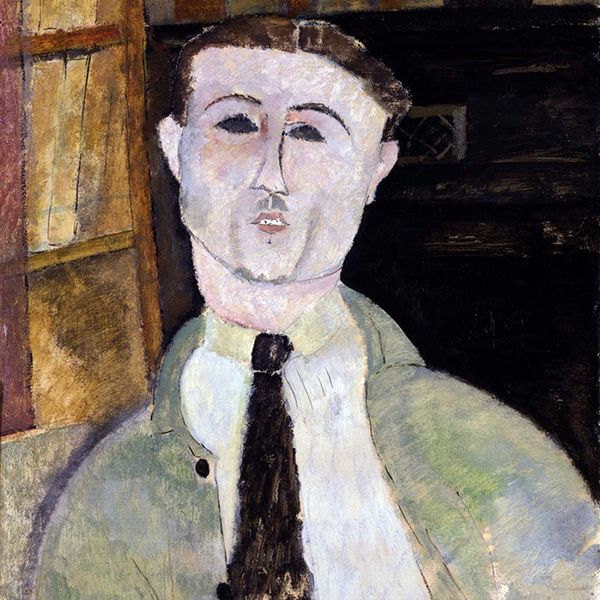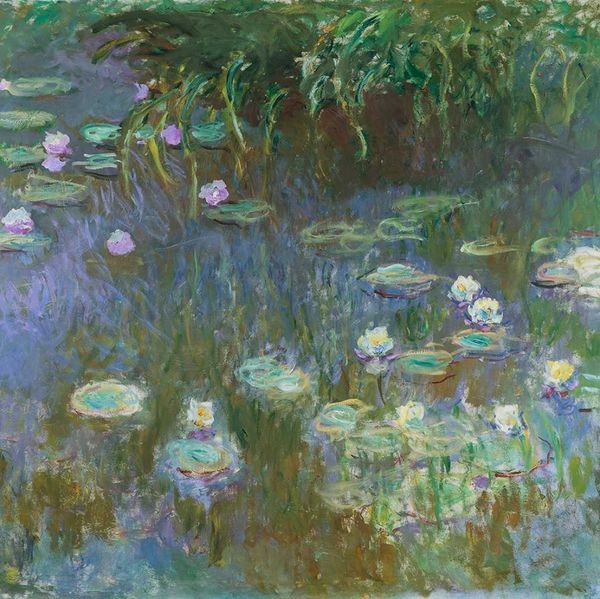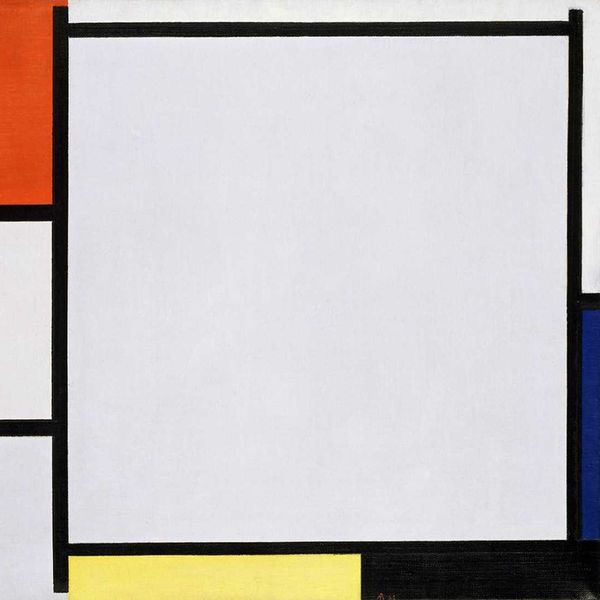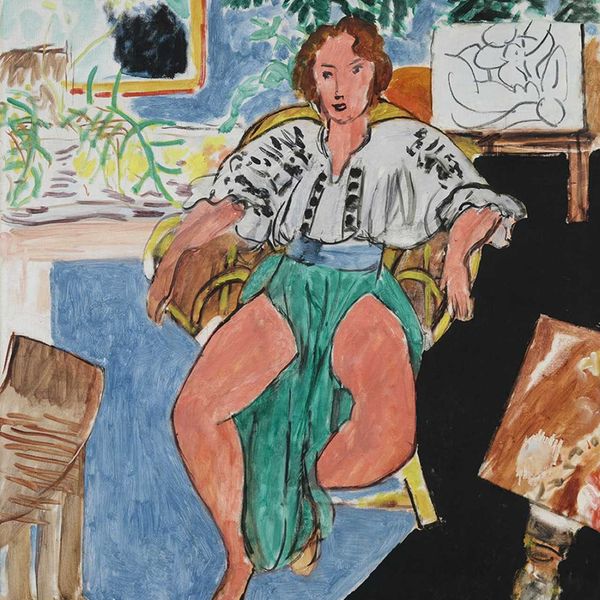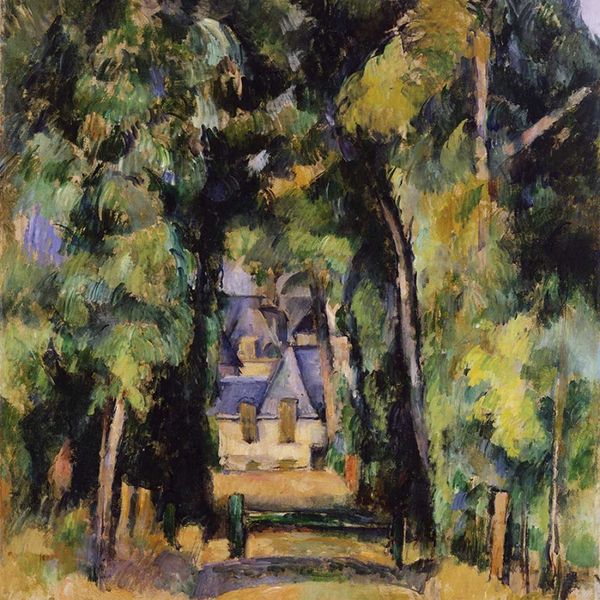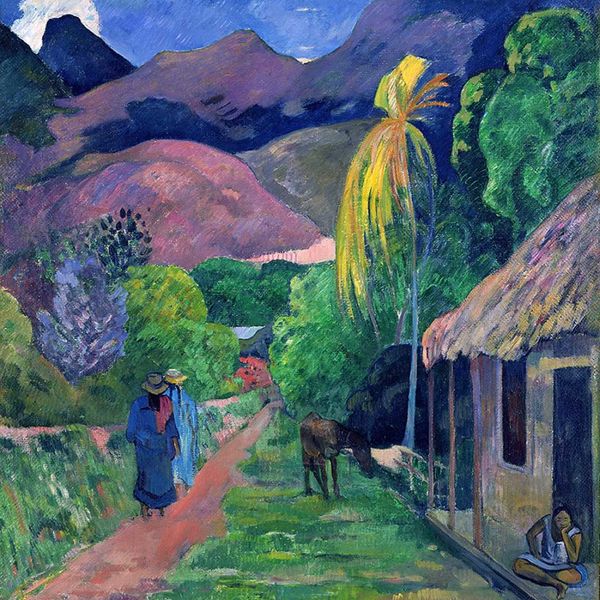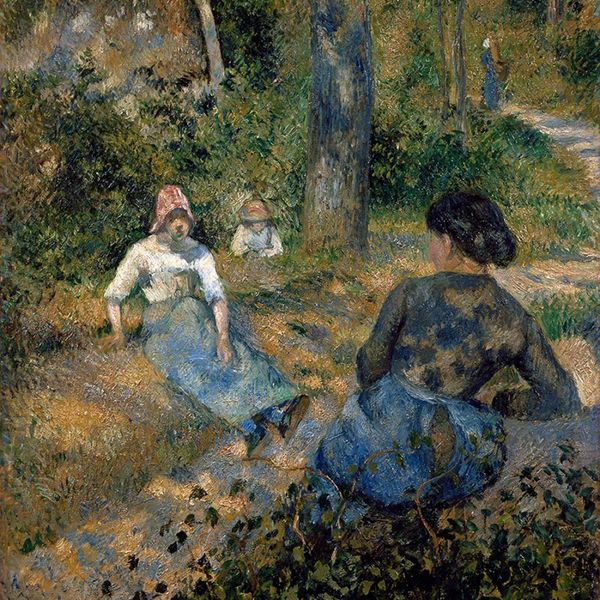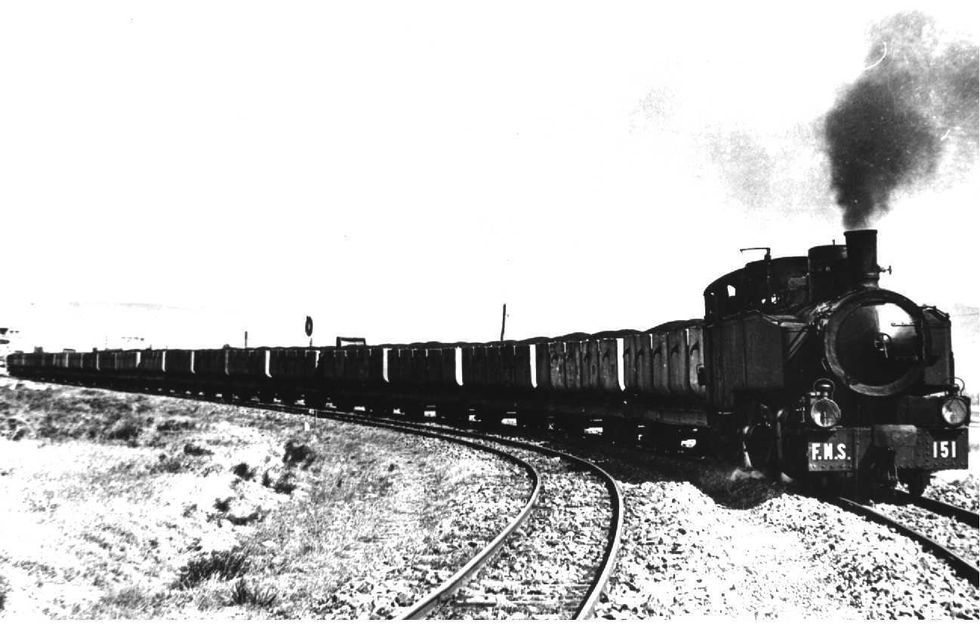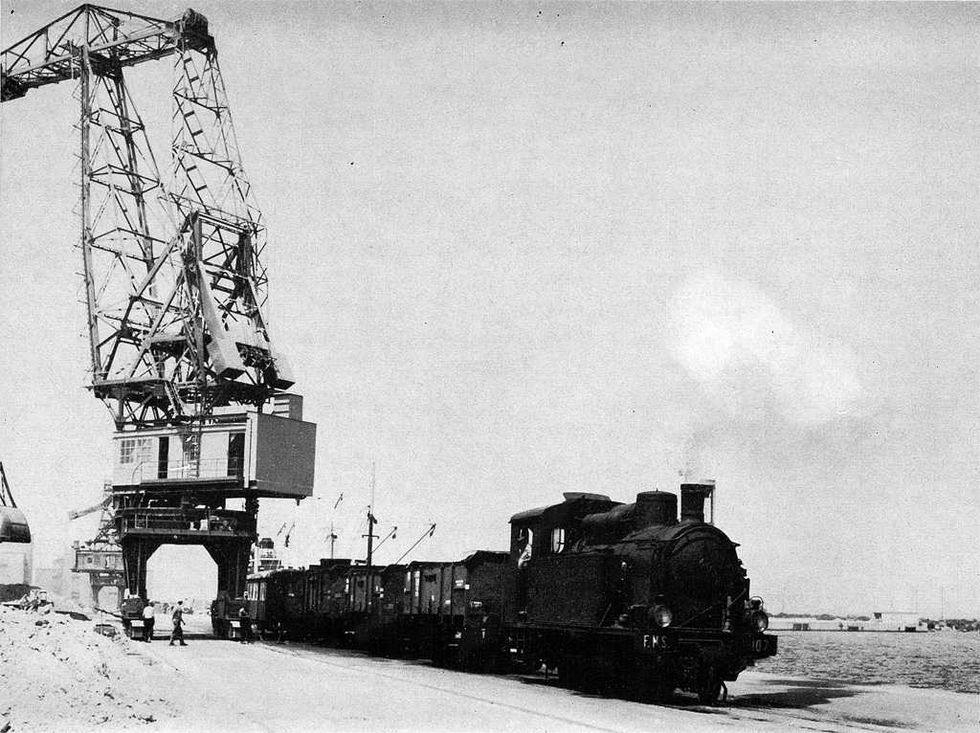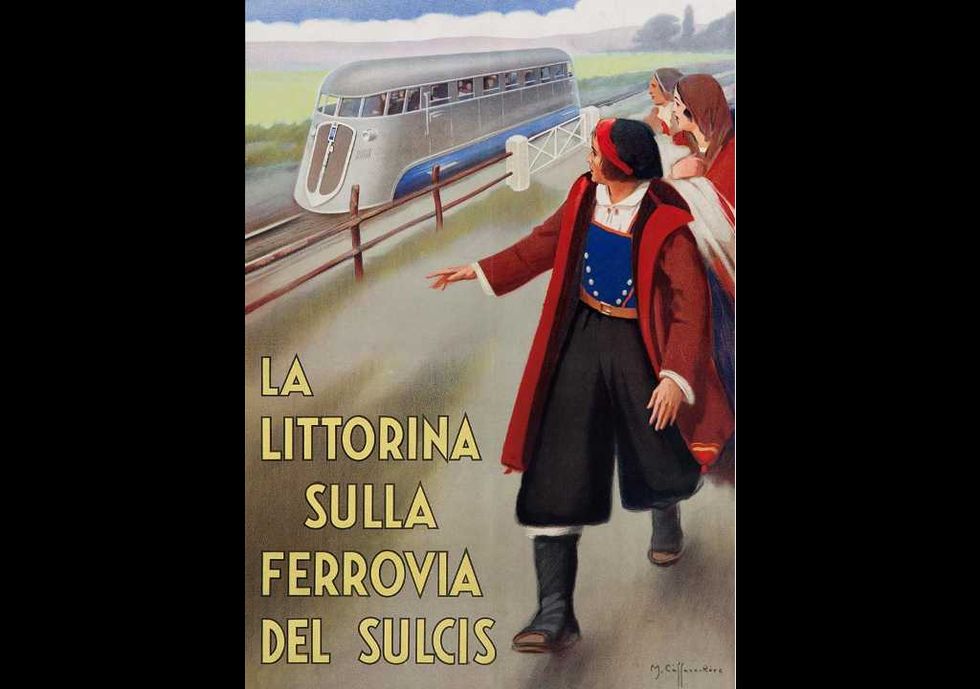Mentre la Moldavia avvia le pratiche per un futuro ingresso nell’Ue, la striscia separatista della Transnistria, riconosciuta praticamente solo da Mosca e con antichi legami con il Kgb, va nella direzione opposta. Domani il congresso dei deputati di Tiraspol si riunirà per decidere l’avvio di un referendum mirato alla diretta annessione alla Russia. La mossa non è casuale, ovviamente. Giovedì Vladimir Putin si affaccerà all’assemblea federale per un discorso plenario. In molti si aspettano che da quel pulpito possa rispondere direttamente alle richieste dei trasnistriani. E dare il via a un film che abbiamo già visto con la Crimea e le repubbliche del Donbass. La repubblica fantasma ha però degli elementi aggiuntivi che spingono ad accendere ancor più i fari sulla pericolosità delle mosse politiche e militari nell’area. Un nuovo fronte a Sud dell’Ucraina coinvolgerebbe ancora più la Nato e alzerebbe lo scontro interno riportando le lancette dell’orologio al 1992, quando lo staterello, dopo una guerra civile che ha lasciato sul terreno qualche migliaio di morti, tagliò i ponti con la Moldavia, rimanendo però al tempo stesso il suo più grande fornitore di energia. Adesso a soffiare sul fuoco del nazionalismo locale ci sono due aspetti. Le affermazioni di una crescente militarizzazione da parte della Moldova, in collaborazione con la Nato, sono state citate come giustificazione per le richieste di protezione della Transnistria dalla Russia. Queste affermazioni giungono nel contesto di accuse di maggiori rischi per la sicurezza e di un potenziale «terrorismo» all’interno della regione, spingendo a richiedere ulteriori «peacekeeper» russi.
Le dinamiche politiche in Transnistria sono state caratterizzate anche da operazioni di intelligence interna ed esterna volte a giustificare un potenziale intervento russo con il pretesto di proteggere i cittadini russi e i «compatrioti» nella regione. Queste operazioni includono denunce di aggressione della Moldavia e violazioni dei diritti umani contro la Transnistria, ponendo le basi per una narrazione che posiziona la Russia come forza protettiva contro l’invasione occidentale.
Secondo elemento di destabilizzazione è l’afflusso di profughi ucraini. Le statistiche ufficiali delle autorità de facto della Transnistria nel gennaio 2024 hanno riportato 185.200 arrivi. Tuttavia, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che il numero reale dei profughi ucraini oscilli tra i 5.000 e i 10.000. Il che rende bene l’idea dello storytelling in atto grazie al balletto di numeri. Il tira e molla serve a sua volta per creare un tema di intromissione nella politica interna della Moldavia.
Venti gironi fa a Mosca si è registrato un incontro significativo tra il politico moldavo filo-Cremlino Ilan Shor e Leonid Kalashnikov, presidente del comitato della Duma di Stato russa per gli affari della Comunità degli Stati indipendenti, l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti all’estero. Questo incontro in Russia non è stato solo un impegno diplomatico casuale, ma una mossa calcolata che illumina ulteriormente la strategia radicata del Cremlino per influenzare l’orientamento geopolitico della Moldavia. Shor, in questo incontro, ha sostenuto a gran voce l’integrazione della Moldavia nell’Unione economica eurasiatica (Eaeu) dominata dalla Russia, proponendola come l’unica «salvezza» per il Paese in mezzo «all’impatto negativo» dell’Occidente collettivo. Tradotto in altre parole, è facilmente immaginabile che Putin voglia accendere un falò a Tiraspol per evitare che la Moldavia finisca del tutto sotto l’influenza europea. Del tutto, perché dopo l’invasione russa dell’Ucraina l’economia di Chisinau si è spostata verso Occidente. Il taglio delle forniture di gas russo è stato compensato da acquisti (sebbene a prezzi molto più alti) sul mercato Ue e i fondi strutturali di Bruxelles hanno spinto flussi verso Bulgaria e Romania. Resta ancora un filo energetico che unisce la Moldavia con la sua repubblica separatista. Si chiama centrale di Cuciurgan e fino al 2022 teneva in piedi il 70% delle fabbriche moldave. La fornitura si è interrotta fino al febbraio del 2023 per poi ripartire a ranghi ridotti. Obiettivo di Chisinau è tagliare i ponti entro l’inizio del prossimo anno. Mosca si muove per evitare l’indipendenza energetica della Moldavia e lo fa con lusinghe economiche. All’interno di quadro quadro che ricorda molto il movimento di una placca tettonica pende però l’incognita militare e il potenziale incidente bellico. Da una parte e dall’altra si registrano piccoli atti di sabotaggio, senza contare l’enorme numero di droni e velivoli che sorvola l’area.
A pochi chilometri da Tiraspol, a Cobasna, c’è uno dei più grandi depositi di armi europeo. A dirlo è un documento ufficiale datato 11 luglio 2005 e depositato presso le Nazioni unite dall’allora vice ministro agli Esteri moldavo, Andrei Galbur. «Grande preoccupazione», si legge nel testo, «per le 25.000 tonnellate di munizioni stoccate a Cobasna e appartenenti alla federazione russa». Senza contare, prosegue il documento, che «una eventuale esplosione genererebbe lo stesso impatto della bomba di Hiroshima». Il deposito è ancora lì, intonso. È chiaro che le manovre attorno a Tiraspol riaccendono il pericolo. Nessuno può escludere che all’interno non ci siano armi chimiche o cosiddette bombe sporche. Un incidente cambierebbe la storia della regione e alzerebbe i toni in modo spropositato. La prima guerra mondiale è iniziata in fondo per molto meno. Dire che si scherza con il fuoco è poco.