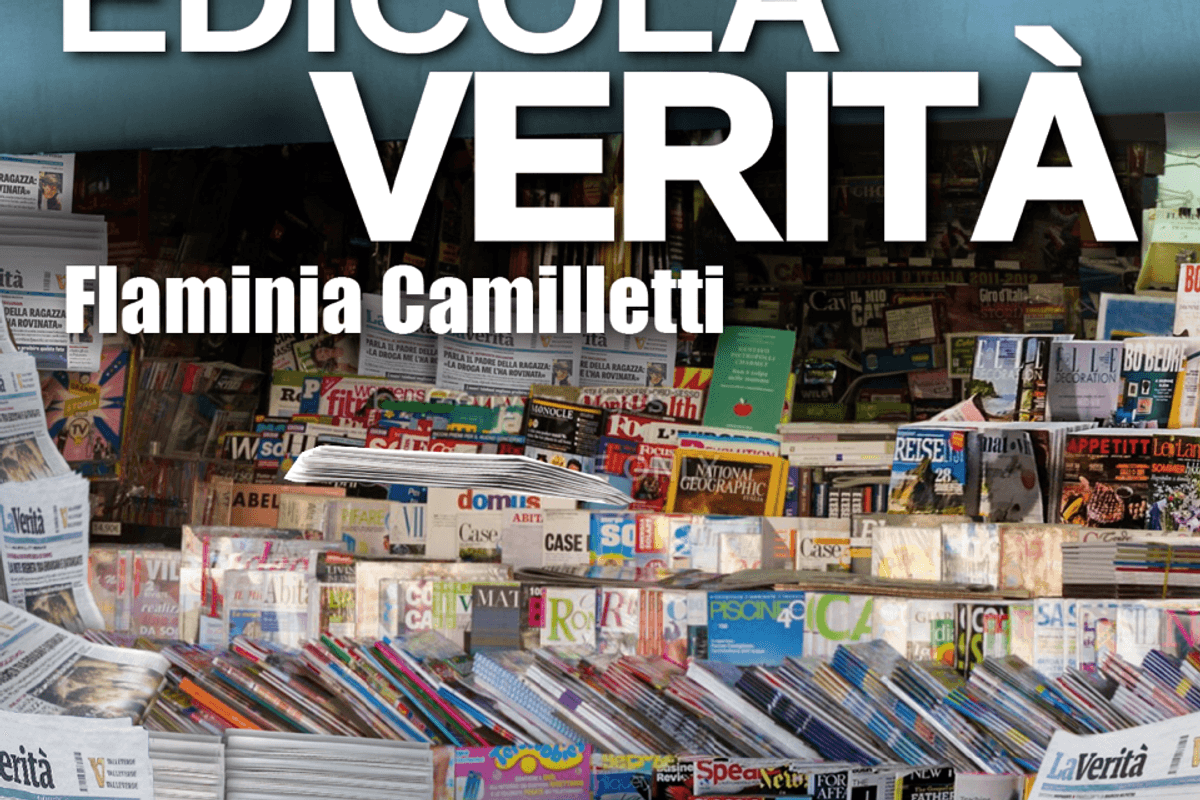Vediamo di riepilogare il contenzioso che Giacomo Leopardi aveva con la cittadina di Recanati, come può essere desunto dalla seconda strofa della canzone Le ricordanze. Gli abitanti, dice, sono gente zotica e vile, non nel senso di codarda ma in quello di ignobile, e ciò perché conoscenza e dottrina le sono estranee, e siccome le sono estranee le tratta come oggetto di riso e di scherno. Sono inoltre gente, anzi una «greggia», malevola, che lo odia e lo sfugge, non per invidia, che implicherebbe almeno un riconoscimento obliquo e perfido di una sua superiorità, ma per il senso di superiorità che, a torto, gli attribuisce: lo giudica insomma uno che se la tira senza averne motivo. Risultato: Giacomo è «dannato» a consumare la sua giovinezza in un «borgo selvaggio», in un «soggiorno disumano», abbandonato e nascosto, senza amore né vita, diventando aspro per l’asprezza altrui e sdegnando i suoi simili per l’influsso dei «simili» che si trova intorno.
Appena possibile, dunque, comincia il suo vagabondaggio lontano dal paese natale. Roma, Milano, Bologna, Firenze, Pisa, sempre alla ricerca di amore, di solidarietà intellettuale e di indipendenza economica. Incapace di quest’ultima per le sue precarie condizioni di salute, è costretto a un nuovo confino a Recanati, dove rimane durante quelli che in una lettera descrive come «sedici mesi di notte orribile». Ripartitone definitivamente, si stabilisce a Napoli e vi muore, due settimane prima del suo trentanovesimo compleanno.
A poca distanza dalla morte, l’atteggiamento che i suoi concittadini mostrano verso Leopardi appare di segno totalmente opposto a quello da lui percepito. Lungi dall’odiarlo, nel 1864 commissionano allo scultore Ugolino Panichi una sua statua, che oggi, in una piazza a lui intitolata e a poca distanza da un liceo che porta il suo nome, funge insieme da centro e da simbolo del luogo. E dappertutto si diramano arterie che, sfiorando un po’ il ridicolo, sembrano testimoniare una ingenua ma intensa devozione alle sue opere: via Passero solitario, viale Colle dell’Infinito, piazzale Sabato del villaggio. Forse stona un po’ il ristorante A Silvia Food, Drink & Pizza; ma è possibile leggerlo come una simpatica, allegra sciocchezza.
Con questa disposizione benevola, arriviamo a Casa Leopardi. L’avevo visitata in passato, prima che un film mediocre e sopravvalutato vi attirasse un pubblico da stadio (una signora che chiaramente non sa che cosa ha davanti insiste però di voler fare «la cosa più completa possibile»). L’ingresso, per biblioteca, abitazione e museo, costa 20 euro (!?), ma non sognatevi di comprare un biglietto ed entrare, come mi era capitato nella mia precedente incarnazione. Buona parte dei biglietti vengono distribuiti su prenotazione e sono esauriti da tempo; per i pochi che vengono messi in vendita nel giorno stesso, all’una del pomeriggio si stanno già vendendo quelli delle cinque. C’è un sentiero che porta al colle dell’Infinito, ma la vista che ispirò i famosi 15 endecasillabi è protetta da un alto muro e accessibile solo con un altro biglietto. E insieme con i biglietti potete acquistare ritratti, libri e altre diavolerie, come in ogni altro bookshop che si rispetti (così si chiamano ormai in Italia), inteso ad accrescere i profitti di un’istituzione «culturale». Se poi volete un’esperienza più esotica, potete unirvi a un signore che, impeccabilmente addobbato con abiti d’epoca, vi porterà per luoghi leopardiani declamando opportuni versi; mi chiedo che cosa farebbe la Disney con un’idea del genere e mi rispondo che lo sta già facendo - non la Disney come azienda ma la Disney come archetipo, come modello di business.
A questo punto i conti cominciano a tornare, o meglio a non tornare. La gente che popola questo circo non è meno zotica e vile di quella che indispettiva Giacomo, e non ha di lui un’opinione migliore; lui ne avrebbe ugualmente orrore e vorrebbe ugualmente starne alla larga. Se pure ha imparato a memoria qualche riga dei suoi scritti, il motivo che la spinge è fare soldi. Alle sue spalle: il giovane infelice riciclato come favoloso è strumentalizzato a fini commerciali e venduto come oggetto di consumo. Quell’abbraccio caldo e avvolgente che aveva invano cercato in vita gli è negato anche in morte: ogni briciolo della sua identità ha un prezzo, che lo allontana, invece di avvicinarlo, dall’obiettivo sfuggente del suo desiderio. Pratiche avide e rapaci hanno occupato il territorio della poesia e ne hanno imprigionato l’autore, «dannato» per sempre a questo inferno. E intendiamoci: rapaci non come un leone, che uccide la sua preda prima di sbranarla, ma come un avvoltoio, che preferisce cibarsi di carogne.