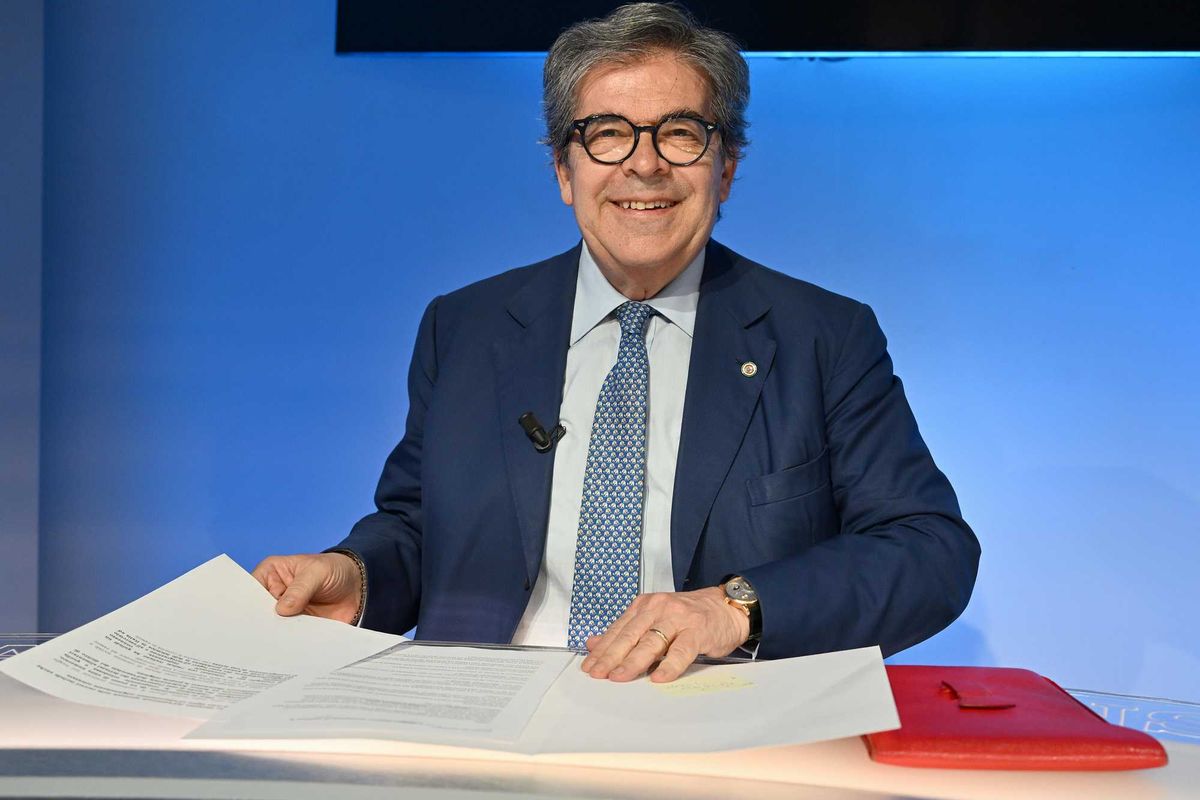Waverley Root, giornalista e scrittore americano, gastronomo innamorato dell'opera lirica e della cucina italiana - scrisse nel 1971 un libro importante sulla nostra gastronomia, The Food of Italy, affermando, tra l'altro, che «un pasto italiano è come un'opera». Gioachino Rossini era, per Root, la sintesi dell'italica armonia: musica e gastronomia. Del grande compositore pesarese scrisse: «Avrebbe potuto diventare un buongustaio di fama se il suo genio musicale non avesse eclissato il suo talento gastronomico».
Il bello è che anche il babbo di Figaro pensava di sé la stessa cosa. «Sono un pianista di terza classe, ma il primo gastronomo dell'universo». E con quale convinzione lodava i peccati di gola: «Dopo il far nulla, io non conosco occupazione per me più deliziosa del mangiare, mangiare come si deve, intendiamoci. L'appetito è per lo stomaco vuoto è ciò che l'amore è per il cuore».
Aveva un'orchestra in testa e una in pancia: «Lo stomaco vuoto rappresenta il fagotto e il piccolo flauto in cui brontola il malcontento e guaisce l'invidia, al contrario, lo stomaco pieno è il triangolo del piacere oppure i cembali della gioia». Per comporre i celebri crescendi rossiniani entrambe le orchestre dovevano funzionare alla perfezione. L'opera di Rossini si ascolta, ci si inebria e si mangia. L'italiana in Algeri, il Guglielo Tell, La Gazza ladra, Semiramide, effondono divine armonie e profumi di pasticci, fois gras, maccheroni e tartufo. Quando gli mancavano i tartufi andava in crisi di astinenza. Non riusciva a concentrarsi, soffriva fisicamente. Nel periodo in cui stava componendo lo Stabat Mater confessa in una lettera ad un amico: «Sto cercando motivi musicali, ma non mi vengono in mente che pasticci, tartufi e cose simili».
Divino e golosissimo compositore adorava i maccheroni di cui si era innamorato di un amore folle a Napoli nel tempo in cui era stato direttore musicale del San Carlo (1815-1822). Nello stesso periodo si innamorò anche della soprano Isabella Angelica Colbran che sposò nel 1822. All'amata spediva lettere d'amore di questo tenore: «Ciò che mi interessa ben altrimenti che la musica, cara Angelica, è la scoperta che ho fatto di una nuova insalata della quale mi affretto a inviarti la ricetta». Si trattava delle celebri Uova affogate alla Rossini, facili da fare, ma costosette anzichenò: tra gli ingredienti sono previsti il fegato d'oca e il tartufo in due versioni: a scaglie e in salsa. Se l'amore con la Colbran durò pochi anni, quello per i maccheroni perdurò tutta la vita. È nella città partenopea che crea la ricetta che cucinerà per gli amici e gli ospiti nei golosissimi pranzi e cene a casa sua: i Maccheroni alla Rossini. Per lui equivalevano ad un pezzo musicale ben riuscito dove si esibivano parmigiano, prosciutto, pomodoro e tartufo, «il Mozart dei funghi», che il cigno di Pesaro avrebbe messo dappertutto, anche nel cappuccino. Alessandro Dumas padre, invitato a cena racconta: «Sistemata la pasta in una casseruola come un bambino nella culla, i maccheroni finirono la cottura tra vapori che stordivano. Rossini restò là, immobile, affascinato, sorvegliando il suo piatto favorito e ascoltando il mormorio dei cari maccheroni come se prestasse orecchio a note armoniose».
A Passy dove abitava, poco lontano da Parigi, il Maestro si faceva arrivare i maccheroni direttamente da Napoli. Se per qualche disguido la spedizione tardava ad arrivare, si disperava e in fondo alle lettere che spediva a destra e a manca, si firmava «Gioachino Rossini, senza maccheroni».
Il padre di Figaro considerava la gastronomia uno dei pilastri dell'esistenza. «Mangiare, amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quest'opera buffa che è la vita». Una volta confessò di aver pianto in vita sua tre volte: «Quando mi fischiarono la prima opera, quando sentii suonare Paganini e quando mi cadde in acqua, durante una gita in barca, un tacchino farcito ai tartufi».
Rossini apparteneva a quella classe sociale elettiva che il contemporaneo Jean Anthelme Brillat-Savarin, giudice e gastronomo, chiamò «Buongustai per predestinazione» nel libro Fisiologia del Gusto, scritto nel 1825, l'anno in cui il musicista italiano compose Il Viaggio a Reims per l'incoronazione di Carlo X. Rossini, poi, non poteva che essere d'accordo con Brillat-Savarin laddove afferma: «La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella». Una sensazione del genere il musicista italiano la provò, molto giovane, a Venezia. La racconta Irina Sorokina, scrittrice e pianista russa che da anni vive in Italia, nel libro Sulla Punta della Lingua, Ricette d'Artisti. «Appena ventenne Gioachino Rossini si trovò in un bàcaro a Venezia. Era giovane e golosissimo. Il proprietario della trattoria gli servì il tipico piatto veneziano risi e bisi. A Rossini il piatto piacque subito e gli fece venire un momento d'ispirazione. Ed ecco che ai posteri fu regalato il delizioso brano “Di tanti palpiti", l'aria di Tancredi dall'omonima opera».
Incontrare Marie Antoine Carême, cuoco del banchiere James Mayer Rothschild , fu per l'autore della Gazza ladra come trovare la pietra filosofale della gastronomia: i piatti e le dolcezze che creava Carême, che era anche pasticcere, per Rossini erano più preziosi dell'oro. I due diventarono amiconi. L'affetto era tale che non si scordavano l'uno dell'altro neppure quando erano lontani più di mille chilometri.
Al compositore piaceva essere protagonista, inventare piatti nuovi, accostare sapori a sapori. Oggi sarebbe stato uno chef a tre stelle. Anche quando smise di produrre musica, la sua casa divenne un punto di riferimento gastronomico per i grandi che accorrevano a trovarlo. Al suo desco ospitò compositori come il francese Camille Saint-Saens, il tedesco Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi, Arrigo Boito; cantanti come la celebre Adelina Patti e Antonio Tamburini; ospitò Niccolò Paganini, l'amico banchiere Rothschild, Alexandre Dumas che oltre ai Tre Moschettieri e agli altri romanzi di cappa e spada si cimentò in un libro gastronomico: Le grand Dictionnaire de Cuisine. Peccato che a un certo punto l'amicizia tra lo scrittore francese e il musicista italiano si ruppe sui... maccheroni. La lite passò all'anedottica come «La guerra dei maccheroni». C'è chi dice che Dumas si rifiutò di mangiare i maccheroni del Maestro, altri raccontano che li mangiò, ma osò criticarli, fatto sta che Rossini che considerava i maccheroni cibo sacro, ritenne lo sgarbo un crimine di lesa maestà. Fu impossibile ricomporre il dissidio: troppo presuntuoso Dumas («Il mio gusto per la cucina viene dal cielo»), troppo affezionato agli adorati maccheroni Rossini. Il «moschettiere» affondò i colpi con maldicenze e pettegolezzi del tipo «è il cuoco che prepara i maccheroni in casa Rossini». E siccome il compositore sapeva bene che la calunnia è un venticello che bisognava smorzare subito, ribatté colpo su colpo spargendo il sale dell'ironia e il pepe del sarcasmo sulle piaghe di Dumas che, a quanto pare, ne aveva di aperte, prendendo di mira il confuso Le grand Dictionnaire de Cuisine. Picche e ripicche che andarono avanti per 28 anni, dal 1840 al 1868 quando Rossini lasciò questo mondo rimpianto in ugual misura da melomani e da gastronomi.