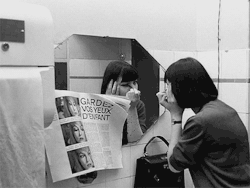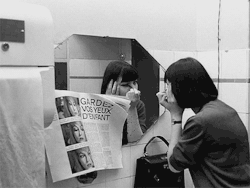2018-10-07
Quei registi feticcio della sinistra con un passato segreto da fascisti
Un nuovo saggio riscrive la storia della Nouvelle vague, il movimento che rivoluzionò il cinema europeo. Nata in un ambiente anticomunista, la corrente fu influenzata dai grandi intellettuali «collaborazionisti».Estate 1960, Spagna. Sul foglio franchista Primer plano esce l'articolo di un intellettuale romeno, il primo di un'inchiesta a puntate sulla Nouvelle vague. Si tratta di dimostrare che il nuovo cinema francese è un'autentica espressione di fascismo culturale. Spagna, Francia, Romania, Nouvelle vague, fascismo: è una strana storia, quella di cui stiamo per parlare.A raccontarcela è Claudio Siniscalchi, docente universitario e storico del cinema, nel suo nuovo saggio Quando la Nouvelle vague era fascista. Un libro di straordinaria erudizione, che se fosse comparso nel rodato circuito del marchettificio culturale avrebbe probabilmente generato un dibattito deflagrante su tutte le terze pagine dei giornaloni, ma che invece è uscito senza clamore per le anticonformiste edizioni Settimo Sigillo, di Enzo Cipriano. Ma restiamo sul pezzo: davvero la Nouvelle vague, cioè il movimento che cambiò il cinema europeo alla fine degli anni Cinquanta, quella di François Truffaut e Jean-Luc Godard, era fascista? A sostenerlo sulla stampa spagnola, nel 1960, era Jean Parvulesco. E qui si apre una storia nella storia. Parvulesco, chi era costui? Romeno, fuggito avventurosamente dal regime comunista nell'immediato dopoguerra, l'uomo era approdato a Parigi, dove aveva stretto contatti con tutte le anime inquiete della destra transalpina. Ancora nei primi anni 2000 (Parvulesco è morto nel 2010), i frequentatori dei siti Internet identitari europei potevano leggere delle sue analisi visionarie su Vladimir Putin e il destino escatologico dell'Eurasia, con quel pathos messianico così tipico in certi romeni «di destra». Un intellettuale originale, coltissimo, imperscrutabile, quindi. Bando alle divagazioni: che c'entrano le camicie nere con i cineasti parigini? Niente, in senso stretto. Eppure lo scrittore vi riscontra una ribellione esistenziale, un culto dell'azione che in qualche modo gli ricordano Ernst Von Salomon e Pierre Drieu La Rochelle. «L'esistenzialismo», scrive Parvulesco, «è stato, innanzitutto, il culto dell'abiezione masochista, del compromesso, della nausea che aiuta a vivere: la Nouvelle vague si riconosce nella violenza, a volte come fine e come mezzo di una certa visione della vita, che, essendo ancora tuttavia essenzialmente nichilista, non deve rappresentare una visione eroica della vita». Il movimento incarna quindi la ribellione alle «putrefazioni esistenzialiste». La sua filosofia è nichilista e la sua «morale si riduce ad una parola: autenticità». E ancora, più nel dettaglio: «François Truffaut si ricorderà di avere giurato che avrebbe girato Gilles di Drieu La Rochelle? Jean-Luc Godard pensa ancora di girare un grande film sulla guerra di Spagna di cui mi parlava un giorno a Saint- Germain-des-Prés? La guerra di Spagna vista da Drieu La Rochelle, nell'ottica delle brigate dell'Internazionale fascista. Nel 1950 Jean-Luc Godard sulla Gazette du cinéma si augurava che si realizzassero pellicole in onore della vita eroica di Philippe Henriot», ovvero un collaborazionista , ucciso il 28 giugno 1944 da un gruppo di resistenti. Non sarà sfuggito che Parvulesco sta qui dando informazioni di prima mano. Lo scrittore, infatti, era uno del giro. In À bout de souffle di Godard, il film manifesto del movimento, Jean-Pierre Melville interpreta uno scrittore dal nome di… Jean Parvulesco. Ed è invece lui in persona a comparire, come attore, in L'Arbre, le Maire et la Médiathèque, di Éric Rohmer o in Maîtresse di Barbet Schroeder. E già questa frequentazione la dice lunga. Siniscalchi ha del resto buon gioco nell'evidenziare come, se l'interpretazione dell'intellettuale romeno può sembrare forzata, non di meno essa ricalca quella che, con giudizio politico opposto, venne all'epoca da certa critica di sinistra, che non esitò a bollare i nuovi registi come reazionari. Sulla rivista marxista Positif, i film Le beau Serge e Les cousins, di Claude Chabrol, vengono recensiti accusando il regista di descrivere «con tenerezza un mondo che ha l'aria di conoscere bene, ma che, in effetti, conosciamo bene anche noi… Jeune nation, nazismo, ciò vi dice qualcosa?». È solo un esempio tra tanti. Positif era l'antagonista dei Cahiers du Cinéma, la rivista in cui i registi della Nouvelle vague avevano esordito come critici. I Cahiers erano stati fondati dal critico cattolico André Bazin, proveniente dal personalismo di Emmanuel Mounier, che nel 1950 aveva creato polemiche per il suo saggio anticomunista su Le cinéma soviétique et le mythe de Staline. L'altra tribuna in cui si esprimevano i registi della Nouvelle vague era Arts, la rivista degli hussards, un movimento letterario anti sartriano che intratteneva non pochi flirt con gli ambienti del collaborazionismo e che sosteneva l'Algeria francese. Come si vede, se non il fascismo, almeno una certa destra era in effetti presente nel Dna della corrente cinematografica. Ma c'è di più. Organico al movimento era per esempio lo scenografo e dialoghista Paul Gégauff, viveur e donnaiolo, provocatore inveterato che amava raccontare di aver combattuto con la «gioventù hitleriana» e di aver preso parte alla liberazione di Parigi… dall'altra parte della barricata. Fanfaronate, probabilmente, ma l'humus è chiaro. Ma anche i big del movimento avevano i loro scheletri nell'armadio. Il maoistissimo Godard degli anni Sessanta, per esempio, non solo aveva avuto un nonno materno petainista, ma una volta, parlando con il collega Romain Goupil e con Daniel Cohn-Bendit (è quest'ultimo a raccontarlo a Le Monde nel 2010) aveva detto: «Vedete, quando io ero bambino segnavo l'avanzata della Wehrmacht con delle bandierine sulla cartina. Tu, Romain, vieni da una famiglia comunista e facevi altri giochi. E Dany è figlio di emigranti ebrei. È qui la differenza, ecco perché siamo divenuti ciò che siamo». Quanto a Truffaut, non bisognerà dimenticare che negli anni Cinquanta aveva voluto incontrare il «maledetto» Lucien Rebatet, ex critico cinematografico dell'Action française e di Je suis partout, scrittore brillante ma anche feroce antisemita, e che aveva recensito sui Cahiers il secondo volume della nuova edizione dell'Histoire du cinéma scritta da Maurice Bardèche e Robert Brasillach, affermando di rispettare le idee dei due autori. Rohmer, poi, ha ricordato che «ci accusavano di essere a destra, ed effettivamente noi facevamo delle provocazioni alla Rebatet», mentre Chabrol era stato compagno di università di Jean-Marie Le Pen. Il che non ne fa certo un aderente del Front national, ma è interessante notare come tale amicizia non fu mai rinnegata da nessuno dei due. Alla morte del regista, Le Pen scrisse: «La vita ci aveva separati, ma io conservavo, e credo anche lui, un tenero ricordo dei nostri anni di gioventù. Claude era stato membro del comitato della corporazione studentesca di diritto, che io presiedevo. Era già pazzo di cinema e ci trascinava, a detrimento dei nostri corsi di legge, ogni mattina al cinema Le Paris per vedere i film che uscivano e di cui all'uscita discutevamo all'infinito». Cronache di un'altra Francia. E di un altro cinema.
Operazioni di soccorso dopo il crollo ai Fori Imperiali (Getty Images)
Una donna in preghiera in una chiesa nei pressi di Lagos, Nigeria (Getty Images)