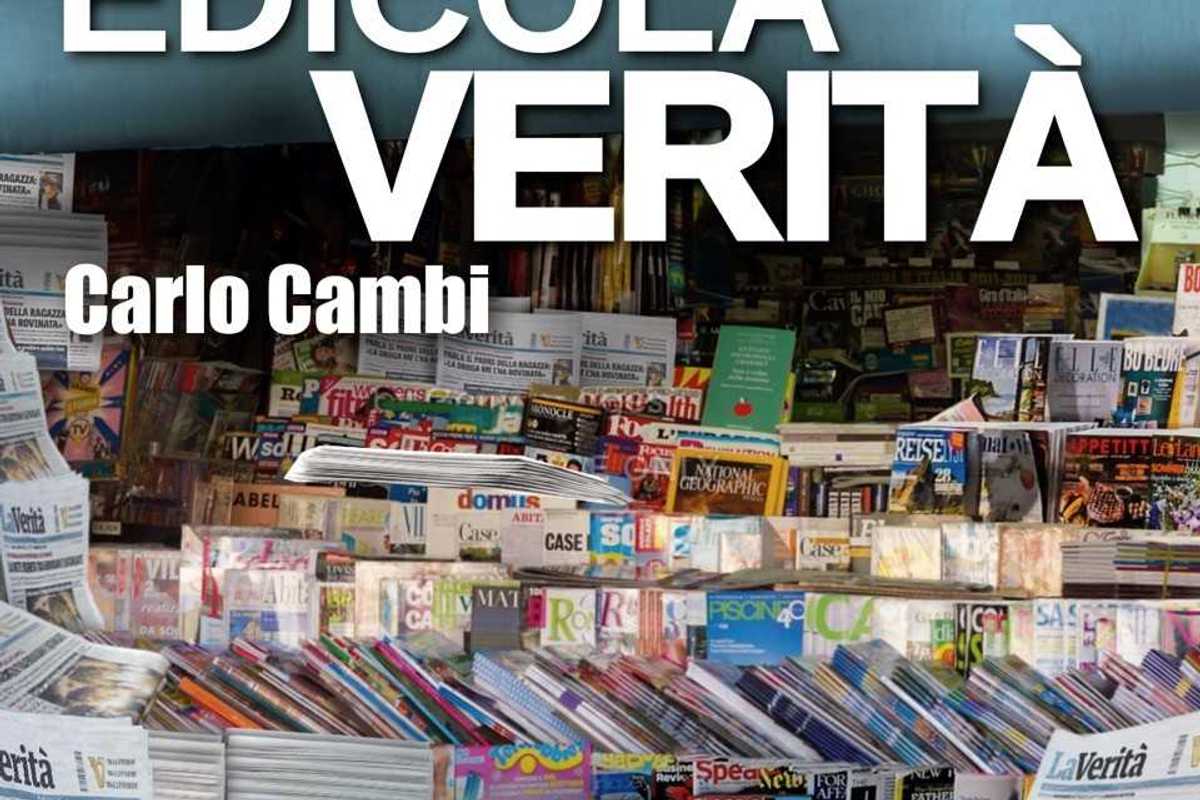«Le politiche Ue? Enorme fallimento». Studio del Senato smonta l’austerità

Con una tempestività degna di miglior causa, il servizio bilancio del Senato ha diffuso qualche giorno fa un documento di approfondimento dal titolo La riforma delle regole fiscali europee: lo stato dell’arte. Il titolo più appropriato avrebbe dovuto essere - parafrasando il famoso film di Woody Allen - Tutto quello che avreste voluto sapere sulle regole fallimentari dell’Eurozona (ma non avete mai osato chiedere).
In 12 fitte pagine c’è scritto tutto il male possibile delle regole che hanno governato le politiche di bilancio dei Paesi dell’Eurozona a partire dal 2011. Quelle stesse regole - peraltro condizionanti il finanziamento del Pnrr - di cui mercoledì il Financial Times, commentando l’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini, non ha esitato a richiedere il rispetto, qualsiasi governo arrivi a ottobre. Avvertendo che la politica di bilancio espansiva prospettata dalla coalizione di destra, metterà l’Italia «in rotta di collisione con Bruxelles».
il def
Oggi - e c’è da chiedersi perché proprio ora - arrivano i tecnici del Senato a dirci quanto avrebbero potuto dirci qualche anno fa o, anche solo qualche mese fa, quando il governo di Mario Draghi e il suo ministro dell’Economia Daniele Franco presentarono un Def in cui si vantavano che «il miglioramento del deficit strutturale di bilancio rappresenta la piena compliance con la regola europea». Da aprile, sono passati solo pochi mesi e ora apprendiamo che «con l’enorme aumento del rapporto debito/Pil, molti Paesi si preoccupano se un’economia basata sulla rottura delle vecchie regole è sostenibile.
La risposta in breve è inequivocabilmente affermativa. Esistono due modi per riportare il rapporto debito/Pil a un livello più ragionevole: ridurre il numeratore attraverso l’austerità o aumentare il denominatore attraverso gli investimenti. Una decade fa, l’Ue ha seguito la prima strada durante la crisi della zona euro e si è rivelata un enorme fallimento. Gli Stati Uniti hanno preso quest’ultima strada dopo la seconda guerra mondiale e si è rivelata un grande successo». Si stenta a credere a ciò che si legge. Draghi e Franco - ma soprattutto coloro che li hanno preceduti a partire dal 2011 - hanno seguito delle regole che si sono rivelate un «enorme fallimento», e solo pochi mesi fa hanno ancora insistito nel prevedere nel Def un sentiero di rientro del deficit/Pil verso l’obiettivo di medio termine del 0,3%, in ossequio proprio a quelle regole. Siamo stati vittime di un fallimento e vengono a dircelo con l’aria di chi in fondo l’aveva sempre saputo.
Naturalmente c’è da salutare con favore questa presa d’atto che però si ferma in mezzo al guado. Perché l’abbandono di quei difettosi e dannosi strumenti non avviene a causa della conta dei danni che ha provocato, ma perché «ora, la nuova realtà economica, richiede un nuovo approccio alle regole fiscali europee». Insomma, siamo di fronte al vecchio e abusato strumento del «questa volta è diverso». Infatti, si sostiene che la pandemia ha riportato in auge l’importanza della politica di bilancio e mostrato i limiti della politica monetaria e quindi «il mondo di oggi richiede un quadro di politica economica in cui la politica monetaria e fiscale possano lavorare insieme efficacemente per sostenere l’inflazione e la crescita». Ci permettiamo di dissentire. Era anche il «mondo di ieri» (qualunque esso fosse) a necessitare di una politica di bilancio non pro ciclica e non dominata da calcoli astrusi, soggetti a stime complesse e spesso fuorvianti.
Avremmo voluto non attendere l’agosto 2022 per sentirci dire - dieci anni dopo il varo del Trattato sul Fiscal compact che prevedeva la riduzione automatica del debito/Pil eccedente il 60% per 1/20 all’anno - che il rapporto debito/Pil di Maastricht del 60% è «irrealistico» e ora è «importante che sia attuato un approccio realistico e graduale […] poiché una riduzione iniziale troppo marcata del rapporto debito/Pil potrebbe comportare un costo economico e sociale elevato e sarebbe quindi controproducente, in particolare in un contesto caratterizzato da una politica monetaria condizionata dai limiti e dal rischio di ripercussioni a lungo termine sull’economia».
Devono essere caduti parecchi fulmini sulla via di Damasco per leggere che «lo strumento di politica fiscale diviene mezzo necessario e determinante per innescare la ripresa e renderla stabile e sostenibile nel tempo». Per poi affermare - in un crescendo rossiniano - che «una sana politica fiscale non è sempre equivalente alla riduzione del debito e del disavanzo». Infatti, i «disavanzi e il rapporto debito/Pil devono essere strumenti, non obiettivi». E puntare «esclusivamente sulla riduzione del debito potrebbe generare un circolo vizioso di crescita debole, tassi di interesse costantemente bassi e debito e deficit più elevati». Non avremmo saputo trovare parole più appropriate ed efficaci per descrivere la storia economica dell’Italia dal 2011 al 2021 e il sentiero su cui appare avviata dal 2023.
Che fare dunque? Partire dall’eliminazione dell’obiettivo del 60% debito/Pil che «è arbitrario e introduce un indesiderabile inasprimento della politica fiscale». Inoltre, «è quasi impossibile ridurre il debito al 60% del Pil nei prossimi decenni per l’Eurozona e molti suoi Stati membri».
la pandemia
Ora è il tempo delle «raccomandazioni specifiche per Paese» e il debito pubblico è sufficiente che sia «sostenibile». Tuttavia, affermare che «c’è voluta la pandemia per dimostrare che invece di preoccuparsi di rapporti arbitrari, sarebbe più saggio da parte dei Paesi investire maggiormente nella salute e rafforzare le catene di approvvigionamento per rendere l’economia più resiliente», costituisce solo una irricevibile giustificazione ex post di marchiani errori di politica economica.
Infatti, è sempre stato vero che «gli investimenti pubblici finanziati in disavanzo che aumentano la produzione potenziale sono una soluzione economicamente ragionevole». Purtroppo, per dieci anni l’Italia è stata costretta a ridurli.
Lo stato dell’arte della riforma oggi prevede l’Agenzia europea per la gestione del debito (Eda) - cioè un Mes sotto mentite spoglie - e un indicatore unico di performance nella forma di vincolo alla crescita della spesa. Il dibattito è aperto, speriamo solo che tra dieci anni non scoprano che anche queste nuove regole si sono rivelate un «enorme fallimento».