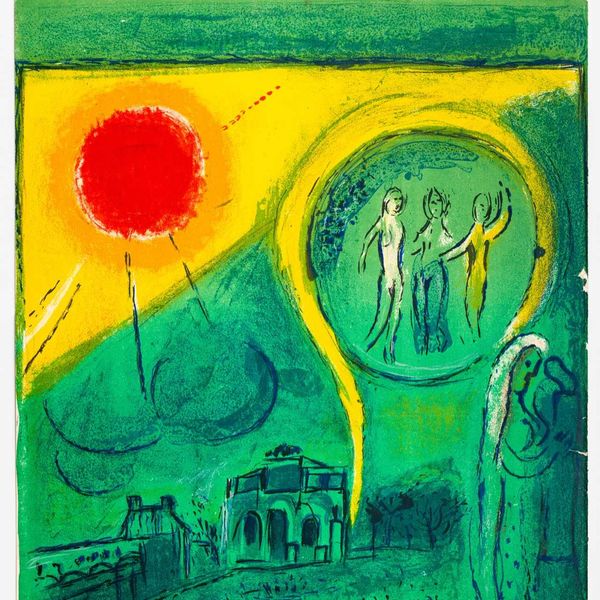Dire la verità richiede meno sforzo che dire le bugie: ci sono meno cose da ricordare. Quando invece si entra nel territorio delle balle e delle fake news, ogni bugia successiva deve rimanere ben collegata alla bugia precedente.
Sembra questa - adesso - la complicata condizione sul Mes dei giallorossi, che si sono autoobbligati a credere alla versione veicolata dal ministro Roberto Gualtieri, e smentita non solo dalla Verità ma soprattutto dal presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno. Prima, durante e dopo il vertice a Bruxelles, Gualtieri ha diffuso l'idea, con l'ausilio di qualche cronaca compiacente, di una trattativa aperta, di un rinvio, di un muscolare ed energico negoziato italiano. Purtroppo, il portoghese lo ha freddato sia nel pre partita sia nel dopo partita, riassumendo tutto in tre punti fermissimi: la firma sarà come previsto a inizio 2020 (entro il primo trimestre); l'impianto dell'accordo non cambia di una virgola (e infatti non è cambiato); al massimo, si può ancora trattare su qualche aspetto della normativa secondaria e sussidiaria (ed è ciò che è effettivamente avvenuto, specie sulle famigerate Cacs, le clausole di azione collettiva). Ma la sostanza non si sposta di un millimetro.
Tuttavia, la maggioranza si è abbarbicata alla narrazione del rinvio. Il fatto che, nel Consiglio europeo del 12-13 dicembre non ci sarà materialmente la firma della riforma del Mes, è diventato un balsamo per il Pd e per il corpaccione dei parlamentari grillini (i 7 deputati e senatori su 10 che, secondo tutte le analisi, non sarebbero confermati in caso di nuove elezioni), terrorizzati dall'idea che il tandem formato da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista potesse davvero usare l'argomento del Mes per far saltare tutto.
Ancora giovedì, in un ristorante del centro di Roma, sono stati intercettati per un lungo pranzo Dario Franceschini e Vincenzo Spadafora. Da trentasei ore, c'è anche una gran letteratura retroscenistica su una presunta telefonataccia (non confermata né smentita) di Beppe Grillo a Luigi Di Maio, per richiamare quest'ultimo alla fedeltà giallorossa.
Che può accadere, dunque? Realistico immaginare che il 10 o l'11 dicembre, alla Camera e al Senato, in occasione del dibattito che precede il Consiglio europeo, il quadripartito giallorosso stenderà una risoluzione ultra ammorbidita, fingendo che le cose stiano come Gualtieri le ha raccontate: compiacimento per il rinvio (inesistente, come sappiamo), mandato a trattare ancora (ma resta solo spazio per qualche limatura della legislazione di dettaglio), evocazione del mitico «pacchetto» (che in realtà non esiste più, visto che da Centeno allo stesso Paolo Gentiloni, tutti hanno dovuto ammettere che sull'unione bancaria si è drammaticamente indietro).
Per il Pd, è una pacchia: può prepararsi alle consuete giaculatorie europeiste. Chi invece soffre è Di Maio, che patisce due volte: una prima volta, perché si ritrova incatenato allo schema giallorosso da cui aveva cercato di divincolarsi (a partire dal tentativo di fare scelte elettorali autonome in Calabria e in Emilia Romagna); e una seconda volta, perché aveva provato a prendere le distanze da un mainstream filo Ue che è estraneo alla storia grillina (eccezion fatta per l'incredibile voto estivo che salvò la neonominata Ursula von der Leyen).
Morale: da trentasei ore Di Maio tace sull'argomento Mes, e, sia nei tg sia sui canali social, indossa i panni del ministro degli Esteri (ieri la conferenza stampa congiunta con il ministro russo Sergej Lavrov). Tace anche Alessandro Di Battista, che la scorsa settimana era tornato in campo con una fiammeggiante intervista anti Mes.
Tacciono o si barcamenano anche i due parlamentari grillini che Di Maio si era portato appresso nei vertici di maggioranza in veste di pubblici ministeri anti Mes. Alvise Maniero, che ancora qualche giorno fa, su Facebook, postava sferzanti infografiche sulle «pinze da cetriolo» per prendere la riforma Mes, e spiegava in modo terrorizzante le prospettive di ristrutturazione del debito («se hai un titolo italiano e l'Italia dovesse aver bisogno del fondo salva Stati, zac, ieri valeva 10, oggi vale 7, domani magari 3…»), chiamando i militanti alla mobilitazione («chi vuol veder passare questa riforma conta sull'indifferenza e sull'insofferenza, sul silenzio. Noi parliamone! Stateci vicini»), non aggiorna la pagina Facebook da martedì.
L'altro dioscuro anti Mes, Raphael Raduzzi, è andato l'altro pomeriggio a SkyTg24, ma è sembrato in cerca di diversivi: «Gli altri parlano di temi che già stanno nel Mes, non della riforma», e poi le immancabili polemiche contro Matteo Salvini, e la palla clamorosamente scaraventata in calcio d'angolo, quasi negando l'evidenza: «Noi quel trattato non lo abbiamo sottoscritto e non è neanche arrivato in Parlamento per essere ratificato, la trattativa è ancora aperta, e i margini ce li dobbiamo creare».
L'unico rimasto a presidiare in modo esplicito la linea anti Mes è Gian Luigi Paragone: ancora ieri, un video per dire che «il governo spedisce la palla in tribuna ma non servirà a nulla» e per definire il fondo «non salva stati ma sfascia stati». Ma tutt'intorno, c'è imbarazzo e silenzio.