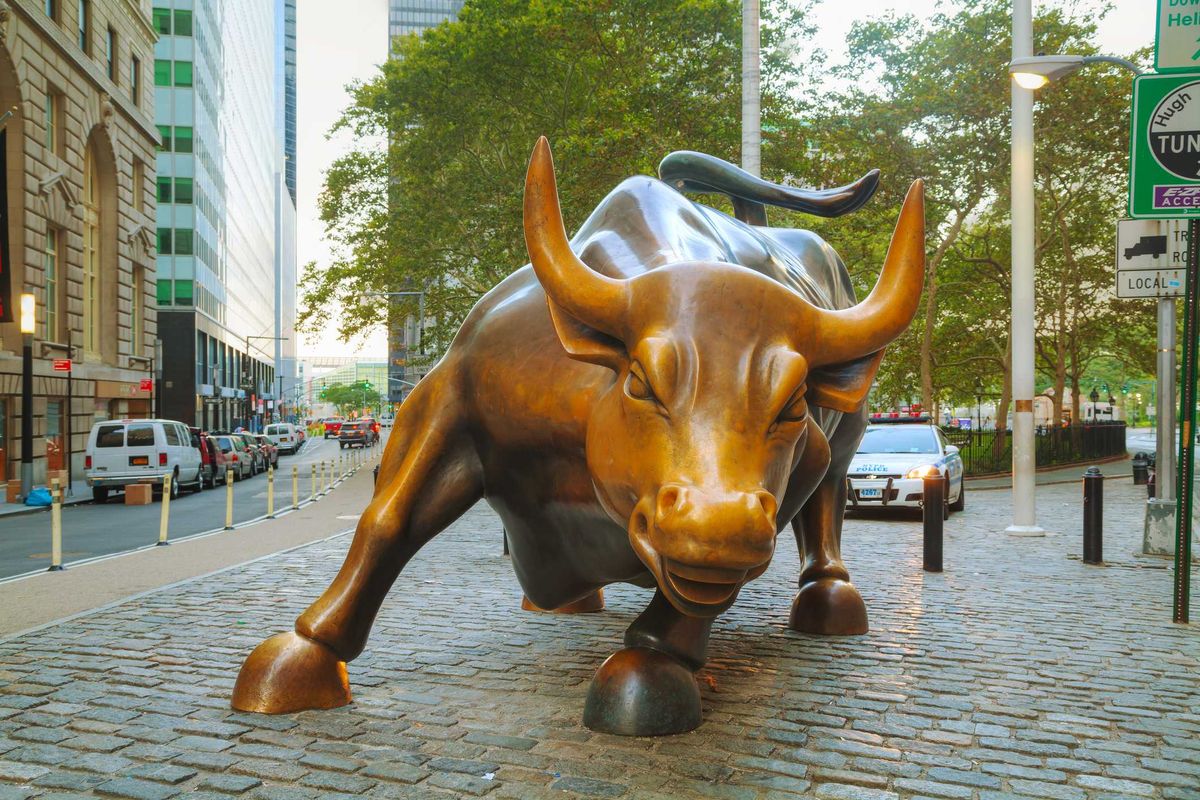2021-05-19
Per convincere gli italiani a fare figli serve una «rivoluzione culturale»
L'idea degli Stati generali della natalità è positiva, ma dietro al calo demografico non ci sono solo problemi economici. L'Occidente deve riscoprire il legittimo e naturale orgoglio della propria identitàPresidente di sezione a riposo della Corte di cassazioneMeglio tardi che mai, verrebbe da dire a proposito dei segni d'interesse che finalmente cominciano a manifestarsi da parte del mondo politico e anche di quello ecclesiastico sul fenomeno del drammatico declino demografico che ormai da anni affligge l'Italia oltre che, in varia misura, anche l'intera Europa. Un declino che, accentuato nel 2020 per effetto della pandemia da Covid, aveva tuttavia già dato luogo, a partire dagli anni immediatamente precedenti, a un calo secco della popolazione residente in Italia, passata, secondo i dati Istat, dai 60.589.445 del 2017 ai 59.641.488 del 2020. Vi è, quindi, da rallegrarsi del fatto che l'incontro promosso, sotto il titolo di «Stati generali della natalità», dal Forum delle associazioni familiari e apertosi il 14 maggio scorso nell'auditorium di via della Conciliazione, a Roma, abbia visto, oltre all'intervento del Papa, anche quello del presidente Mario Draghi e del ministro della Famiglia, Elena Bonetti, i quali tutti hanno posto l'accento sulla necessità di creare stimoli e incentivi volti a superare quello che è stato da molti definito come l'«inverno demografico». Tutto bene (a parte, forse, l'implicito richiamo, non necessariamente beneaugurante, agli «Stati generali» dai quali scaturì la rivoluzione francese), se non fosse però che i rimedi proposti, primo fra tutti l'assegno di natalità, sembrano dare per scontato che le cause della denatalità siano solo di natura socio-economica, mentre ci si dovrebbe rendere conto che, accanto a esse e forse più di esse, operano altre cause, di diversa natura, che incidono negativamente sulla stessa propensione a procreare, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni materiali che consentirebbero di farlo. Basti, a dimostrarlo, il solo fatto che nella fascia di popolazione che gode di un alto tenore di vita e che, quindi, non avrebbe problemi a mettere al mondo un maggior numero di figli, il tasso di natalità non è per nulla superiore ma, anzi, tende a essere addirittura inferiore rispetto a quello, già bassissimo, riscontrabile nelle fasce economicamente inferiori. La pura e semplice realtà è che alla base del fenomeno in questione non vi è soltanto l'atteggiamento del «vorrei, ma non posso», proprio di quanti si trovano nella obiettiva impossibilità o, almeno, nella estrema difficoltà di accudire e mantenere dei figli, dopo aver dato loro la vita. Vi è anche l'altro atteggiamento, molto più diffuso di quanto si voglia far credere, del «chi me lo fa fare?», proprio di quanti non vedono per quale ragione dovrebbero assumersi, pur avendo la possibilità di farlo, gli oneri e le responsabilità che la procreazione inevitabilmente comporta, pur se in varia misura, anche per chi non ha problemi economici. In passato un forte incentivo alla procreazione era quello costituito dalla diffusa sensazione (pur non avvertita, in molti casi, a livello cosciente), che il mettere al mondo dei figli rispondesse a una nobile finalità, che era quella di assicurare la perpetuazione della propria etnia e dei valori sui quali essa fondava la coscienza collettiva della propria identità; il che presupponeva che l'appartenenza a tale etnia fosse generalmente avvertita come motivo di legittimo orgoglio, pur senza per questo dar luogo necessariamente al disprezzo di altre e diverse etnie. Di qui la maggiore disponibilità, rispetto a quanto avviene attualmente, ad affrontare le difficoltà e i sacrifici che anche allora (e forse ancor più di adesso) potevano presentarsi come di ostacolo alla scelta della procreazione; disponibilità favorita anche dalla consapevolezza dell'apprezzamento che la società, nel suo complesso, generalmente mostrava nei confronti di quanti a quella scelta si fossero determinati. Tutto ciò è oggi completamente venuto meno non solo e non tanto per un aumento della tendenza (sempre presente, in realtà, nella natura umana) di ciascun individuo alla ricerca prioritaria del proprio benessere a scapito di ogni altra finalità, ma anche e soprattutto per la diffusione, nella società italiana e di tutto il mondo occidentale, di un assurdo senso di colpa che in essa è stato instillato, a far tempo dagli anni della decolonizzazione, con costanza e determinazione degne di miglior causa, dal «mainstream» della cosiddetta intellettualità (in parte, purtroppo, anche di matrice cattolica), secondo cui la storia dell'Occidente, specie nelle fasi di espansione, altro non è stata se non un seguito di sopraffazioni, violenze e ruberie nei confronti di tutti i popoli con i quali gli europei e gli americani di origine europea sono venuti a contatto. Senso di colpa dal quale è nato quello che Benedetto XVI, nel libro Senza radici di cui è stato autore, con Marcello Pera, ha giustamente definito come «odio di sé dell'Occidente», il quale «della sua storia vede ormai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro». Un «odio di sé» che si traduce anche in un certo tipo di «antirazzismo» dal quale traggono origine norme quali la cosiddetta legge Mancino, in forza della quale può essere passibile di sanzione penale chiunque sostenga pubblicamente, anche in un contesto di studi scientifici, che il livello di civiltà raggiunto dall'Europa è superiore a quello raggiunto dagli aborigeni d'Australia, senza per questo minimamente far intendere che questi ultimi debbano godere un rispetto inferiore a quello degli europei. Ed è di tutta evidenza che una società che odia sé stessa non può certamente nutrire in sé il desiderio della propria perpetuazione ma nutre, semmai, più o meno consapevolmente, quello della propria morte. Ben vengano, dunque, tutte le provvidenze economiche possibili e immaginabili a favore della procreazione, ma non ci si illuda che esse possano bastare a invertire la tendenza alla denatalità se non vengono affiancate da una vera e propria «rivoluzione culturale» che rifiuti totalmente il senso di colpa e restituisca non solo all'Italia ma a tutto l'Occidente il legittimo e naturale orgoglio della propria identità.
Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.